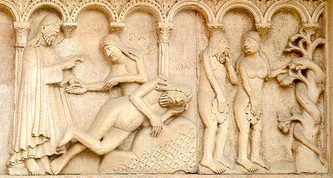ALBA DI PRIMAVERA
SULLA TERRAZZA DELL'ELEXIR
IL PADRE LA VIA DEL TAI KI KUNG
Introduzione alla filosofia e all'alchimia taoista.

Ancora Gratianus. Ancora una sorpresa e che sorpresa! Gratianus cerca di gettare un ponte fra l'Alchimia tradizionale così come lui la intende e l'Alchimia taoista. Il tentativo è ambizioso , non c'è che dire. Poche le corrispondenze armoniche , raccolte quà e là dall'autore, fra la Scienza d'occidente e quella d'oriente in questo libro.
E le difformità nelle quali si dovesse incappare nella lettura attenta dell'Alba di Primavera sono in qualche modo conciliabili? Non credo.
Lascio al lettore scrupoloso e perspicace.....l'ardua sentenza.
gdg
_Islam e femminino sacro:una relazione nascosta
di Lawrence Sudbury.

_
Notoriamente l’Islam è la religione in più rapida crescita nel mondo e quella, con il Giudaismo, più rigidamente monoteistica: il “tawheed” (la concezione dell’unicità di Dio) è così fondamentale che la prima frase della “Shahadada”, la dichiarazione di fede che costituisce il primo pilastro dell’Islam, proclama, in modo non dissimile dal “Sh’ma Yisrael” ebraico, il più inequivocabile credo monoteistico (“Ash-hadu an laa ilaaha illallah”, letteralmente “io testimonio che non vi è alcun Dio all’infuori di Allah”). Tenendo conto che in tutto il Corano ogni riferimento ad Allah avviene con il pronome di terza persona maschile, risulta chiaramente la qualità evidentemente e prettamente maschilista dell’Islam, che non lascia alcuno spazio ad alcuna forma di femminilizzazione del divino. Insomma, oggettivamente, nell’analisi dell’Islam dobbiamo ammettere di trovarci di fronte ad una completa esclusione del femminino sacro.
Almeno apparentemente.
In realtà, però, l’Islam non nasce dal nulla, ma da un substrato religioso molto composito ben presente e radicato nell’Arabia pre-islamica, un substrato in cui il concetto di divinità femminile è evidente e che riemerge, qua e là, all’interno della concezione maschilista musulmana.
Così, il luogo più sacro dei Musulmani è la Kaaba, alla Mecca, che contiene la pietra meteoritica nera, oggetto di venerazione da ben prima dell’avvento dell’Islam e che, in origine, era il “trono di Iside”; così il simbolo dell’Islam è la Mezzaluna crescente (a volte insieme ad una stella) che originariamente era segno di riconoscimento (anche come tatuaggio delle sacerdotesse) del culto della Grande Dea babilonese; così altri oggetti considerati “sacri” sono le torri (propriamente minareti) delle moschee, che erano uno dei simboli principali del paganesimo babilonese sin dai tempi di Nimrod (la cui moglie, Semiramide, eresse una torre di 130 metri a Babilonia, davanti alla quale tutti si prostrarono[1]) e che (anche in forma di obelisco) erano originariamente simbolo della fecondazione della madre terra nel contesto del culto solare legato a Baal[2].
Minareti, culti meteoriti, mezzelune e la Stella babilonese sono, dunque, tutti rimandi a culti pagani precedenti in cui il femminino sacro è molto evidente.
Ma possiamo anche spingerci più in là, facendo risalire persino il culto di Allah allo stesso substrato culturale e affermando che Allah era in origine una divinità pagana, legata al culto astrologico della fertilità e a vari altri aspetti del paganesimo babilonese. I Musulmani in genere sostengono Allah è la stessa divinità adorata (seppur con numerosi errori teologici) nella tradizione giudaico-cristiana, ma, ad esempio, lo studioso islamico Caesar Farah afferma: “non c’è ragione, quindi, per accettare l’idea che Allah passò ai Musulmani dai Cristiani e dagli Ebrei“[3] e spiega che come una tale ascendenza mostrerebbe caratteri di contraddizione non riscontrabili se, invece, tracciassimo la genealogia della divinità in una linea che, attraverso lo Yemen, risale fino a Babilonia, in cui il culto di Baal era condotto con sacrifici, prostrazioni e con l’usanza di “baciare l’idolo”[4], in modo non dissimile dai servizi di culto condotti presso la Kaaba e in altri luoghi in Arabia (in particolare dell’Arabia centrale), nei quali, tra l’altro, sono state trovate iscrizioni con il nome di Baal. Allo stesso modo, il grande studioso William Robertson Smith ha sostenuto che i culti più sviluppati d’Arabia non appartenevano ai nomadi puri (che potevano essere entrati in contatto con le religioni giudeo-cristiane) ma a insediamenti agricoli e commerciali di origine mesopotamica, che i beduini visitavano solo come pellegrini in adempimento di voti[5], così come descritto anche da Ibn Ishaq quando racconta la storia di una donna Jurhum che “era sterile e promise ad Allah che se avesse partorito un figlio lo avrebbe dato alla Kaaba come schiavo per servire il tempio e prendersi cura di esso[6]“.
Tutto ciò ci rimanda inequivocabilmente al culto della fertilità mesopotamico legato a Baal, un culto evidentemente solo nominalmente sostituito con gli dei del deserto (l’aramaico Allah e il Hubal yemenita) ma sostanzialmente inalterato. Ebbene, proprio in tale culto era implicita e sempre presente la relazione tra un alto dio maschile e una “dea madre”, nata dal riflesso di una società primitiva tribale in cui la famiglia era nucleo centrale, alla base dei rapporti di solidarietà, ricchezza, protezione e sostegno quotidiano e in cui risultava naturale l’esistenza di una famiglia divina a cui rivolgere preghiere.
In che modo tutto ciò si relaziona con la presenza di un culto del femminino sacro alla radice dell’Islam? Ebbene, i ritrovamenti archeologici nella Penisola araba hanno mostrato un gran numero di iscrizioni su rocce, tavolette e pareti in cui si delinea il culto di una famiglia di quattro persone, un dio e le sue tre “figlie” o dee. Molti hanno interpretato tale famiglia come Allah e la sua progenie[7], sottintendendo in questo modo la presenza di una quinta componente, genitrice delle tre dee, ma, in effetti, la simbolizzazione della divinità generatrice come una mezzaluna posta sopra le figure delle tre divinità create, stante la già menzionata simbologia femminina lunare, potrebbe anche far pensare ad un sottintendimento proprio di Allah, padre invisibile e increato onnipresente, e ad una raffigurazione propriamente riconducibile alla dea madre.
Comunque stiano le cose, di particolare importanza è la presenza di un ossequio a tre dee, collaboratrici di Allah e oggetto di culto, di radice evidentemente riconducibile ai culti astronomici babilonesi, nel pantheon pre-islamico.
Come ha sottolineato Adam McLean[8], la triplicità della dea è molto importante, dal momento che, non trattandosi semplicemente di una moltiplicazione per tre, ma piuttosto una triplice manifestazione, la Dea si rivela su tre livelli, nei tre regni del mondo e dell’umanità e le sue tre facce corrispondono a cielo, terra e inferi, o passato, presente e futuro. L’aspetto più importante della triplice dea è la sua manifestazione come Vergine / Madre / Tempo: la rappresentazione più semplice con la quale tutti possono identificare le tre fasi della vita della donna (giovane donna / madre / donna vecchia). Ebbene, è interessante notare che queste tre dee erano, in alcuni luoghi, rappresentate da meteoriti o “aerolithoi”, pietre cadute dal cielo, proprio come la pietra della Kaaba alla Mecca (così nel tempio di Afrodite a Cipro, nel tempio di Baalat presso Byblos e nei templi della dea Cibele a Cartagine e in Asia Minore[9]) e che in tutta l’Arabia questi stessi simboli sono stati trovati a rappresentare il culto di una triplice dea araba, tanto da permettere a McLean[10] di affermare: “molto prima della venuta dell’austero sistema patriarcale islamico, il popolo arabo adorava questa trinità di dee del deserto che erano, in realtà, i tre aspetti dell’unica dea. Così Al-Uzza (‘la potente’) rappresentava l’aspetto guerriero e della vergine, era la dea della stella del mattino nel deserto che aveva un santuario in un boschetto di acacie a sud della Mecca, dove era venerata sotto forma di una sacra pietra; Al-Lat, il cui nome significa semplicemente ‘Dea’, era l’aspetto connesso con la Madre Terra e i suoi frutti e con il governo della fecondità ed era adorata in At-Ta’if vicino alla Mecca, sotto forma di un grande blocco di granito bianco grezzo; Manat, l’aspetto vegliardo della Dea, stabiliva il destino e la morte e il suo santuario principale era situato sulla strada tra La Mecca e Medina, dove era venerata, sotto forma di una pietra nera non tagliata“.
Questa dea era la stessa che appariva sotto molti nomi in tutto il mondo dell’antichità (Astarte, Semiramide, Astarot, Iside, Venere, Fortuna, Diana, Astarte, Elat, ecc.) e, alla luce di ciò, non appare così strano che uno degli aspetti del culto della dea sopravvissuto all’Islam (così come, per esempio, nel Cattolicesimo romano) sia il rosario: attraverso i secoli gli adoratori di dee avevano usato il rosario per la preghiera (e, infatti, è ancora in uso nel culto di divinità femminili in tutto il mondo, per esempio tra gli Indù in India) collegata al culto della fertilità (attraverso la ripetizione mantrica dei nomi divini) e la sua eredità è stata raccolta dal “tasbih” (“subha”) arabo (il rosario musulmano che dovrebbe contenere 99 perline a rappresentare i titoli di Allah ma che, in realtà, ne ha 33 cioè 3-3 a simboleggiare i tre avatar della divinità), il cui nome significativamente, è traducibile semplicemente come “‘un oggetto con cui si loda”.
Sussiste anche la possibilità che, all’interno della famiglia divina, non esistesse una “Gran Madre” sottintesa ma, in una sintesi sincretistica tra concezione di generatività e generato (presente, per altro, in numerose altre culture, ad esempio in miti relativi Shingmoo in Cina, Hertha nell’antica Germania, Nutria in Etruria, Indrani in India, Afrodite in Grecia, Venere a Roma, Cibele in Asia Minore e Cartagine, Diana a Efeso, Iside in Egitto, etc), essa fosse espressa proprio attraverso le cosiddette “figlie di Allah”, Al-Lat, Manat e Al-Uzza, le cui figure vale la pena di analizzare un po’ più approfonditamente.
Al-Lat, la versione femminile dell’Allah aramaico, era la “Signora del Tempio” nel Pantheon semitico di Palmira, spesso citato nelle fonti antiche. Il suo culto era condiviso dalle tribù dei Banu Akat e dei Banu Nurbel in quella città, che probabilmente fornivano i guardiani o sacerdoti per il suo santuario, quasi certamente costruito dopo l’occupazione dei Nabatei della Siria[11]. Al-Lat era la dea madre (al-Ilahah), che rappresentava il sole, era la figura materna tra gli dei e le dee, la Grande Madre Terra della mitologia antica, e l’Astarte degli Arabi, citata già da Erodoto e il cui culto, seppure con varianti nomi nazionali, univa palmireni e membri delle tribù occidentali[12]. Portata nell’Hijaz da Palmira, probabilmente attraverso Teima, essa ebbe, come accennato, in Ta’if (città in ottimi rapporti con la Mecca) il centro del suo culto, con un tempio in cui era rappresentata con un quadrato di pietra[13] (e, d’altra parte, la dea madre era spesso rappresentata da un pietra, un montagna, una grotta, o pilastro di roccia). Dal momento che i Nabatei veneravano Allat come la “madre degli dei”, Tor Andrae ritiene che sia possibile presumere che in ambiente arabo essa corrispondesse alla grande dea semitica della maternità, della fertilità e del cielo[14], spesso chiamata semplicemente “Al Rabba”, “la sovrana” (un titolo che apparteneva anche a Ishtar e Astarte). Dopo che Maometto conquistò la Mecca e alcune delle sue tribù vicine, si rivolse contro Ta’if e il suo tempio di Al-Lat, distruggendolo, ma è altamente probabile che tale ostilità nascesse anche (se non soprattutto), dalla variante di culto solare (influenzato da ragioni culturali) che i normale culto lunare della dea aveva assunto in Arabia e che, in qualche modo, entrava in diretta concorrenzialità con il culto di Allah predicato dal Profeta[15].
Manat si ritiene fosse la dea autoctona degli Arabi che appare qualche tempo prima di Al-Uzza e Al-Lat. Il suo nome compare nel tempio di Baal nel 32 d.C., ma ha origine certamente molto prima. Essa era colei che controllava la fortuna e il mistero della vita e della morte, era la divinità principale degli al-Aus e degli al-Khazraj e riceveva una particolare venerazione a Yathrib (Medina), dove era rappresentata da un’immagine di legno che durante il culto veniva coperta di sangue[16]. Ibn al-Khalbi afferma che i Bedu erano soliti andare in ”Hajj” (pellegrinaggio) al suo tempio e durante il percorso non si radevano il capo, operazione che compivano solo al ritorno (secondo il rituale ripreso completamente dall’Islam)[17]. Come le Moire in Grecia, questa dea del destino e del tempo fu venerata con zelo (era lei che si occupava delle nascite, del matrimonio e della morte, della guerra e delle incursioni) ma il suo culto stava diminuendo al tempo di Maometto, probabilmente a causa dell’influenza ebraica a Medina (il che dimostra quanto gli al-Aus e gli al-Khazraj fossero disposti ad abbandonare la loro religione a favore di qualsiasi altra, incluso, in seguito, quella islamica).
Infine, Al-Uzza era stata portata alla Mecca dai Quraysh e aggiunta ai culti già stabiliti nella Kaaba. Al tempo di Maometto era la più importante delle divinità meccane, forse a parte Hubal (il Signore), probabilmente un altro termine per definire Allah. Il suo santuario principale era in una valle chiamata Hurad, appena fuori Mecca, dove sorgeva un haram e un altare sacrificale molto frequentato[18], su cui venivano immolati inizialmente esseri umani e poi animali (sebbene a Duma e Hira i sacrifici umani continuassero). Anche Maometto, in gioventù, secondo la tradizione, aveva sacrificato una pecora a Al-Uzza (e questo atto potrebbe benissimo essere stato compiuto sul Monte Hira, noto luogo di devozione al dio della luna Allah e sua figlia al-Uzza e sul quale avvenne poi l’incontro tra Maometto e l’angelo) ma si narra che durante lo scontro armato tra i meccani e i Musulmani a Badr i primi innalzarono il vessillo di al-Uzza in battaglia e che per questo, dopo la vittoria, il Profeta inviò Khalid ibn al-Walid (che poi conquistò la Siria all’Islam), a distruggere il tempio di al-Uzza a Nakhla[19].
Una volta distrutti tutti gli idoli, Allah regnava incontrastato nel Hijaz e la dea madre era scomparsa dalla sfera della religione araba, ma essa sopravvive ancora nelle leggende musulmane in quelli che vengono comunemente definiti i “versetti satanici”, un capitolo della vita di Maometto che i Musulmani vogliono dimenticare e che, per le vicende che seguirono, ha reso famoso, qualche anno fa, un romanzo omonimo di Salman Rushdie.
L’ambientazione è la Mecca, alcuni anni prima della Hijra, molto probabilmente nel 619 d.C., quando il protettore di Maometto, Abu Talib, e sua moglie, Khadija, erano entrambi morti o in punto di morte. I meccani erano diventati sempre più ostili verso il Profeta e ridicolizzavano la sua missione in ogni modo possibile. La cosa peggiore era che spesso lo tentavano promettendogli fama e fortuna se si fosse astenuto dall’attaccare le loro divinità. Maometto non era disposto a compromettere la sua missione e aveva sempre declinato le loro offerte, finché, come narra al-Tabari, non arrivò la tentazione più grande, quando i meccani offrirono a Maometto un compromesso tale per cui egli avrebbe adorato al-Lat e al-’Uzza per un anno, e essi avrebbero adorato Allah per un anno.
A questo punto i Profeta, tentato da Satana, avrebbe risposto, secondo al-Tabari:
“Che ne pensate voi di al-Lāt e di al-ʿUzzā
e di Manāt, il terzo idolo?
Ecco le gharānīq, la cui intercessione è cosa grata a Dio“[20]
(Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān ʿan taʿwīl al-Qurʾān, XVII, pp. 186-90)
La parola araba “gharānīq” del “verso satanico” è un “hapax”, un vocabolo che ricorre solo in questo testo, e si riferirebbe, secondo i commentatori, alle gru della Numidia ma, poiché un titolo della triade sacra era “le tre sublimi gru”, il significato implicito era quello di un’ammissione dell’esistenza delle tre divinità e un’attestazione del loro ruolo come intermediari divini.
Secondo Ṭabarī, le parole destarono forte stupore tra gli astanti che non si aspettavano che Maometto scendesse a patti con il politeismo pagano della stragrande maggioranza della città. Conseguentemente, sempre secondo al-Tabari, sarebbe stata avviata una preghiera collettiva per sottolineare la ritrovata concordia cittadina e la notizia dei “versetti satanici” avrebbe persino convinto alcuni emigrati (“muhājirūn”) a tornare dall’Abissinia, dove si erano rifugiati.
Oggi ci appare evidente l’incontestabile vantaggio politico derivante da una interpretazione sincretica e accomodante da parte di Maometto, ma è, altresì, chiaro che il prezzo spirituale di tale vantaggio sarebbe stato eccezionale, dal momento che il Profeta avrebbe smentito il più volte asserito monoteismo assoluto della nuova religione.
La mattina seguente, infatti, Maometto ritrattò quanto affermato, chiarendo che le parole gli erano state sussurrate all’orecchio sinistro (e non a quello destro, come normalmente faceva l’arcangelo Gabriele) e che quindi erano di origine satanica.
I “versetti satanici” furono disconosciuti da Maometto che fornì, al loro posto, l’autentica rivelazione:
“Che ne pensate voi di al-Lāt e di al-ʿUzzā
e di Manāt, il terzo idolo?
Voi dunque avreste i maschi e Lui le femmine?
La divisione sarebbe iniqua!
Esse non sono che nomi dati da voi e da’ vostri padri,
pei quali Iddio non v’inviò autorità alcuna.
Costoro non seguono altro che congetture e le passioni dell’animo,
mentre già giunse loro dal Signore la Guida“[21]
Che cosa significa questa “correzione”? In una società patriarcale come quella araba era considerato un peccato avere solo figlie (come accaduto proprio a Maometto che pare fosse notevolmente imbarazzato per questo motivo) e, dunque, nel caso le tre divinità fossero state reali, Allah sarebbe risultato imperfetto a causa della sua incapacità di procreare figli maschi. Inoltre, come sostenuto da Alfred Guillaume[22], l’interpolazione avrebbe reso quegli esseri divini o semi-divini intercessori di Allah, un ufficio che nell’Islam doveva essere accordato solo a Maometto stesso.
Conseguentemente le parole pronunciate da Maometto vennero successivamente eliminate dalla versione canonizzata del Corano, rimanendo, però, in un canto che i meccani utilizzavano quando camminavano intorno alla Pietra Nera[23].
Resta il fatto che, seppur per poche ore, il Profeta fosse sceso a compromessi seri con il paganesimo, con conseguenze fondamentali, dal momento che, se questa leggenda fosse vera (come ammesso in generale da numerosi commentatori musulmani), dovremmo pensare che non esista alcuna certezza che altre parti del Corano non siano state ispirate da Satana e non da Dio. Una delle più belle hadith riporta è il seguente discorso di Allah a Maometto: “il mio servo [Maometto] mi è sempre vicino con le sue opere volontarie di pietà, tanto che ho imparato ad amarlo e da quando lo amo io sono il suo occhio, il suo orecchio, la sua lingua, il suo piede, la sua mano. Egli vede attraverso di me, sente attraverso di me, parla attraverso di me, si muove e prova sentimenti attraverso di me“[24], ma se Maometto è “pura creta nelle mani di Dio”, come avrebbe potuto Dio stesso ammettere l’esistenza di divinità femminili? Il Profeta risolse il problema affermando: “Non inviammo prima di te nessun messaggero e nessun profeta, senza che Satana si intromettesse nella sua recitazione. Ma Allah abroga quello che Satana suggerisce. Allah conferma i Suoi segni. Allah è sapiente, saggio“[25], ma rimane l’incongruenza della possibilità satanica di interpolare il messaggio divino trasmesso direttamente attraverso il Profeta.
Senza addentrarci in questioni teologiche che poco ci riguardano, ciò che conta è che alla base del proto-islamismo (e, si sarebbe quasi tentati di dire, in competizione con esso) troviamo istanze di femminino sacro ben evidenti che, sebbene progressivamente nascoste da una società fortemente maschilista, tendono a riemergere in simboli, azioni, discorsi ancora vivi ed attivi nell’Islam odierno.
Ciò appare particolarmente evidente nello Sciismo e nel Sufismo, le correnti più mistiche del mondo musulmano. Non è un caso che nel Sufismo la “Sophia”, la saggezza di Allah che illumina i cuori dei saggi esoteristi sia definita “l’ultima immagine di Dio, l’Amato … la forma principale al di là della forma, l’ostacolo alla Via e la Via …“[26] e sia considerata così fondamentale da assumere una personalità a sé stante. Allo stesso modo, non è un caso che nello Sciismo esista un particolare culto di Fatma, vista come madre del Logos, in una palese eredità del ruolo già appartenuto in ambito iranico a Spenta Armaiti, e come fonte della saggezza dell’Imam[27], venendo a rappresentare, in fin dei conti, di nuovo una sorta di Sophia.
Proprio riguardo alla figura della Sophia, Ibn Arabi afferma che la sua natura universale (“tavi’at al-kull”) “è il lato femminile o materno dell’atto creativo. Lei è il ‘misericordioso soffio’ di Dio” [Nafa ar-Rahman]“[28] e che essa è anche la dimora di Dio perché “Dov’era il vostro Signore prima di creare la Creazione? Era in una nuvola, non c’era spazio sopra o sotto e la nuvola era la sua Saggezza“[29] ’46.
Infine, all’interno dell’Islam sufi, i principi divini maschile e femminile sono caratterizzati dalla penna e dalla tavoletta: la penna è Dio che scrive sul tabula rasa dell’anima del mondo[30], con un forte riferimento all’atto generativo e alla congiunzione tra principio maschile e femminile.
Ecco, dunque, che, ancora una volta, ritorna il principio generativo come nucleo fondamentale, pur nascosto e dissimulato, del senso religioso. Ma, in una società in cui la componente maschile impera al punto da informare di sé pervasivamente l’intero ambito religioso, anche il solo riferimento a tale nucleo risulta scandaloso. Eppure, il principio primo archetipico maternale trova comunque il modo di riemergere …
[1] Daniele, cap.3
[2] I Re 14:23, 2 Re 18:4, 23:14, Isaia 17:08, 27:9, Ger. 43:13; Ez. 08:05; Michea 5:13
[3] C. Farah, Islam, Barron’s Educational Series 2003, p.28
[4] I Re 19:18
[5]W. Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, II, Sheffield Academic Press 2009, p. 109 ss.
[6] A. Guillaume, The Life of Mohammad, Oxford University Press 2002, p.49
[7] Ad esempio F.E. Peters, Muhammad and the Origins of Islam, State University of New York Press 1994, pp. 98 ss.
[8] A. McLean, The Triple Goddess: An Exploration of the Archetypal Feminine, Phanes Press 1991, passim
[9] M. Stone, Ancient Mirrors of Womanhood: A Treasury of Goddess and Heroine Lore from Around the World, beacon Press 1990, passim
[10] A. McLean, Citato, pp. 80 ss.
[11] J. Teixidor, The Pantheon of Palmyra, Brill Academic 1997, pp. 55-58.
[12] A. Guillaume, Citato, p.61
[13] P. Hitti, History of the Arabs, Palgrave Macmillan 2002, p.98
[14] T. Andrae, Qu’ran, Religion and Theology, Volume 1, Routledge 2008, p.87
[15] E. Neumann, The Great Mother an Analysis of the Archetype, Kessinger Publishing 2004, pp.67-68
[16] A. Guillaume, Citato, p. 207
[17] F.E. Peters, Citato, p.110
[18] A. Guillaume, Citato, p. 108
[19] Ivi, pp. 565-566
[20] al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʿwīl al-Qurʾān, XVII, pp. 186-90
[21] Il Corano,m53:19-23. Trad. A.Bausani, BUR 2006
[22] A. Guillaume, Citato, pp. 112 ss.
[23] Ivi, p. 36
[24] I. Goldziher, Mohammed and Islam, General Books LLC. 2010, pp.42-43
[25] Corano, 22:52
[26] K. Cragg, Counsels in Contemporary Islam, ACLS Humanities 2008, p.81
[27] H. Corbin, Swedenborg & Esoteric Islam, Swedenborg Foundation Publishers 1995, p.47
[28] T. Burckhardt, Introduction to Sufi Doctrine, Fons Vitae 1997, pp.67-69
[29] ivi
[30] L. Bakhtiar, Sufi: Expressions of the Mystic Quest, Thames & Hudson 2004, pp. 86 ss.
Centro Studi La Runa.
Notoriamente l’Islam è la religione in più rapida crescita nel mondo e quella, con il Giudaismo, più rigidamente monoteistica: il “tawheed” (la concezione dell’unicità di Dio) è così fondamentale che la prima frase della “Shahadada”, la dichiarazione di fede che costituisce il primo pilastro dell’Islam, proclama, in modo non dissimile dal “Sh’ma Yisrael” ebraico, il più inequivocabile credo monoteistico (“Ash-hadu an laa ilaaha illallah”, letteralmente “io testimonio che non vi è alcun Dio all’infuori di Allah”). Tenendo conto che in tutto il Corano ogni riferimento ad Allah avviene con il pronome di terza persona maschile, risulta chiaramente la qualità evidentemente e prettamente maschilista dell’Islam, che non lascia alcuno spazio ad alcuna forma di femminilizzazione del divino. Insomma, oggettivamente, nell’analisi dell’Islam dobbiamo ammettere di trovarci di fronte ad una completa esclusione del femminino sacro.
Almeno apparentemente.
In realtà, però, l’Islam non nasce dal nulla, ma da un substrato religioso molto composito ben presente e radicato nell’Arabia pre-islamica, un substrato in cui il concetto di divinità femminile è evidente e che riemerge, qua e là, all’interno della concezione maschilista musulmana.
Così, il luogo più sacro dei Musulmani è la Kaaba, alla Mecca, che contiene la pietra meteoritica nera, oggetto di venerazione da ben prima dell’avvento dell’Islam e che, in origine, era il “trono di Iside”; così il simbolo dell’Islam è la Mezzaluna crescente (a volte insieme ad una stella) che originariamente era segno di riconoscimento (anche come tatuaggio delle sacerdotesse) del culto della Grande Dea babilonese; così altri oggetti considerati “sacri” sono le torri (propriamente minareti) delle moschee, che erano uno dei simboli principali del paganesimo babilonese sin dai tempi di Nimrod (la cui moglie, Semiramide, eresse una torre di 130 metri a Babilonia, davanti alla quale tutti si prostrarono[1]) e che (anche in forma di obelisco) erano originariamente simbolo della fecondazione della madre terra nel contesto del culto solare legato a Baal[2].
Minareti, culti meteoriti, mezzelune e la Stella babilonese sono, dunque, tutti rimandi a culti pagani precedenti in cui il femminino sacro è molto evidente.
Ma possiamo anche spingerci più in là, facendo risalire persino il culto di Allah allo stesso substrato culturale e affermando che Allah era in origine una divinità pagana, legata al culto astrologico della fertilità e a vari altri aspetti del paganesimo babilonese. I Musulmani in genere sostengono Allah è la stessa divinità adorata (seppur con numerosi errori teologici) nella tradizione giudaico-cristiana, ma, ad esempio, lo studioso islamico Caesar Farah afferma: “non c’è ragione, quindi, per accettare l’idea che Allah passò ai Musulmani dai Cristiani e dagli Ebrei“[3] e spiega che come una tale ascendenza mostrerebbe caratteri di contraddizione non riscontrabili se, invece, tracciassimo la genealogia della divinità in una linea che, attraverso lo Yemen, risale fino a Babilonia, in cui il culto di Baal era condotto con sacrifici, prostrazioni e con l’usanza di “baciare l’idolo”[4], in modo non dissimile dai servizi di culto condotti presso la Kaaba e in altri luoghi in Arabia (in particolare dell’Arabia centrale), nei quali, tra l’altro, sono state trovate iscrizioni con il nome di Baal. Allo stesso modo, il grande studioso William Robertson Smith ha sostenuto che i culti più sviluppati d’Arabia non appartenevano ai nomadi puri (che potevano essere entrati in contatto con le religioni giudeo-cristiane) ma a insediamenti agricoli e commerciali di origine mesopotamica, che i beduini visitavano solo come pellegrini in adempimento di voti[5], così come descritto anche da Ibn Ishaq quando racconta la storia di una donna Jurhum che “era sterile e promise ad Allah che se avesse partorito un figlio lo avrebbe dato alla Kaaba come schiavo per servire il tempio e prendersi cura di esso[6]“.
Tutto ciò ci rimanda inequivocabilmente al culto della fertilità mesopotamico legato a Baal, un culto evidentemente solo nominalmente sostituito con gli dei del deserto (l’aramaico Allah e il Hubal yemenita) ma sostanzialmente inalterato. Ebbene, proprio in tale culto era implicita e sempre presente la relazione tra un alto dio maschile e una “dea madre”, nata dal riflesso di una società primitiva tribale in cui la famiglia era nucleo centrale, alla base dei rapporti di solidarietà, ricchezza, protezione e sostegno quotidiano e in cui risultava naturale l’esistenza di una famiglia divina a cui rivolgere preghiere.
In che modo tutto ciò si relaziona con la presenza di un culto del femminino sacro alla radice dell’Islam? Ebbene, i ritrovamenti archeologici nella Penisola araba hanno mostrato un gran numero di iscrizioni su rocce, tavolette e pareti in cui si delinea il culto di una famiglia di quattro persone, un dio e le sue tre “figlie” o dee. Molti hanno interpretato tale famiglia come Allah e la sua progenie[7], sottintendendo in questo modo la presenza di una quinta componente, genitrice delle tre dee, ma, in effetti, la simbolizzazione della divinità generatrice come una mezzaluna posta sopra le figure delle tre divinità create, stante la già menzionata simbologia femminina lunare, potrebbe anche far pensare ad un sottintendimento proprio di Allah, padre invisibile e increato onnipresente, e ad una raffigurazione propriamente riconducibile alla dea madre.
Comunque stiano le cose, di particolare importanza è la presenza di un ossequio a tre dee, collaboratrici di Allah e oggetto di culto, di radice evidentemente riconducibile ai culti astronomici babilonesi, nel pantheon pre-islamico.
Come ha sottolineato Adam McLean[8], la triplicità della dea è molto importante, dal momento che, non trattandosi semplicemente di una moltiplicazione per tre, ma piuttosto una triplice manifestazione, la Dea si rivela su tre livelli, nei tre regni del mondo e dell’umanità e le sue tre facce corrispondono a cielo, terra e inferi, o passato, presente e futuro. L’aspetto più importante della triplice dea è la sua manifestazione come Vergine / Madre / Tempo: la rappresentazione più semplice con la quale tutti possono identificare le tre fasi della vita della donna (giovane donna / madre / donna vecchia). Ebbene, è interessante notare che queste tre dee erano, in alcuni luoghi, rappresentate da meteoriti o “aerolithoi”, pietre cadute dal cielo, proprio come la pietra della Kaaba alla Mecca (così nel tempio di Afrodite a Cipro, nel tempio di Baalat presso Byblos e nei templi della dea Cibele a Cartagine e in Asia Minore[9]) e che in tutta l’Arabia questi stessi simboli sono stati trovati a rappresentare il culto di una triplice dea araba, tanto da permettere a McLean[10] di affermare: “molto prima della venuta dell’austero sistema patriarcale islamico, il popolo arabo adorava questa trinità di dee del deserto che erano, in realtà, i tre aspetti dell’unica dea. Così Al-Uzza (‘la potente’) rappresentava l’aspetto guerriero e della vergine, era la dea della stella del mattino nel deserto che aveva un santuario in un boschetto di acacie a sud della Mecca, dove era venerata sotto forma di una sacra pietra; Al-Lat, il cui nome significa semplicemente ‘Dea’, era l’aspetto connesso con la Madre Terra e i suoi frutti e con il governo della fecondità ed era adorata in At-Ta’if vicino alla Mecca, sotto forma di un grande blocco di granito bianco grezzo; Manat, l’aspetto vegliardo della Dea, stabiliva il destino e la morte e il suo santuario principale era situato sulla strada tra La Mecca e Medina, dove era venerata, sotto forma di una pietra nera non tagliata“.
Questa dea era la stessa che appariva sotto molti nomi in tutto il mondo dell’antichità (Astarte, Semiramide, Astarot, Iside, Venere, Fortuna, Diana, Astarte, Elat, ecc.) e, alla luce di ciò, non appare così strano che uno degli aspetti del culto della dea sopravvissuto all’Islam (così come, per esempio, nel Cattolicesimo romano) sia il rosario: attraverso i secoli gli adoratori di dee avevano usato il rosario per la preghiera (e, infatti, è ancora in uso nel culto di divinità femminili in tutto il mondo, per esempio tra gli Indù in India) collegata al culto della fertilità (attraverso la ripetizione mantrica dei nomi divini) e la sua eredità è stata raccolta dal “tasbih” (“subha”) arabo (il rosario musulmano che dovrebbe contenere 99 perline a rappresentare i titoli di Allah ma che, in realtà, ne ha 33 cioè 3-3 a simboleggiare i tre avatar della divinità), il cui nome significativamente, è traducibile semplicemente come “‘un oggetto con cui si loda”.
Sussiste anche la possibilità che, all’interno della famiglia divina, non esistesse una “Gran Madre” sottintesa ma, in una sintesi sincretistica tra concezione di generatività e generato (presente, per altro, in numerose altre culture, ad esempio in miti relativi Shingmoo in Cina, Hertha nell’antica Germania, Nutria in Etruria, Indrani in India, Afrodite in Grecia, Venere a Roma, Cibele in Asia Minore e Cartagine, Diana a Efeso, Iside in Egitto, etc), essa fosse espressa proprio attraverso le cosiddette “figlie di Allah”, Al-Lat, Manat e Al-Uzza, le cui figure vale la pena di analizzare un po’ più approfonditamente.
Al-Lat, la versione femminile dell’Allah aramaico, era la “Signora del Tempio” nel Pantheon semitico di Palmira, spesso citato nelle fonti antiche. Il suo culto era condiviso dalle tribù dei Banu Akat e dei Banu Nurbel in quella città, che probabilmente fornivano i guardiani o sacerdoti per il suo santuario, quasi certamente costruito dopo l’occupazione dei Nabatei della Siria[11]. Al-Lat era la dea madre (al-Ilahah), che rappresentava il sole, era la figura materna tra gli dei e le dee, la Grande Madre Terra della mitologia antica, e l’Astarte degli Arabi, citata già da Erodoto e il cui culto, seppure con varianti nomi nazionali, univa palmireni e membri delle tribù occidentali[12]. Portata nell’Hijaz da Palmira, probabilmente attraverso Teima, essa ebbe, come accennato, in Ta’if (città in ottimi rapporti con la Mecca) il centro del suo culto, con un tempio in cui era rappresentata con un quadrato di pietra[13] (e, d’altra parte, la dea madre era spesso rappresentata da un pietra, un montagna, una grotta, o pilastro di roccia). Dal momento che i Nabatei veneravano Allat come la “madre degli dei”, Tor Andrae ritiene che sia possibile presumere che in ambiente arabo essa corrispondesse alla grande dea semitica della maternità, della fertilità e del cielo[14], spesso chiamata semplicemente “Al Rabba”, “la sovrana” (un titolo che apparteneva anche a Ishtar e Astarte). Dopo che Maometto conquistò la Mecca e alcune delle sue tribù vicine, si rivolse contro Ta’if e il suo tempio di Al-Lat, distruggendolo, ma è altamente probabile che tale ostilità nascesse anche (se non soprattutto), dalla variante di culto solare (influenzato da ragioni culturali) che i normale culto lunare della dea aveva assunto in Arabia e che, in qualche modo, entrava in diretta concorrenzialità con il culto di Allah predicato dal Profeta[15].
Manat si ritiene fosse la dea autoctona degli Arabi che appare qualche tempo prima di Al-Uzza e Al-Lat. Il suo nome compare nel tempio di Baal nel 32 d.C., ma ha origine certamente molto prima. Essa era colei che controllava la fortuna e il mistero della vita e della morte, era la divinità principale degli al-Aus e degli al-Khazraj e riceveva una particolare venerazione a Yathrib (Medina), dove era rappresentata da un’immagine di legno che durante il culto veniva coperta di sangue[16]. Ibn al-Khalbi afferma che i Bedu erano soliti andare in ”Hajj” (pellegrinaggio) al suo tempio e durante il percorso non si radevano il capo, operazione che compivano solo al ritorno (secondo il rituale ripreso completamente dall’Islam)[17]. Come le Moire in Grecia, questa dea del destino e del tempo fu venerata con zelo (era lei che si occupava delle nascite, del matrimonio e della morte, della guerra e delle incursioni) ma il suo culto stava diminuendo al tempo di Maometto, probabilmente a causa dell’influenza ebraica a Medina (il che dimostra quanto gli al-Aus e gli al-Khazraj fossero disposti ad abbandonare la loro religione a favore di qualsiasi altra, incluso, in seguito, quella islamica).
Infine, Al-Uzza era stata portata alla Mecca dai Quraysh e aggiunta ai culti già stabiliti nella Kaaba. Al tempo di Maometto era la più importante delle divinità meccane, forse a parte Hubal (il Signore), probabilmente un altro termine per definire Allah. Il suo santuario principale era in una valle chiamata Hurad, appena fuori Mecca, dove sorgeva un haram e un altare sacrificale molto frequentato[18], su cui venivano immolati inizialmente esseri umani e poi animali (sebbene a Duma e Hira i sacrifici umani continuassero). Anche Maometto, in gioventù, secondo la tradizione, aveva sacrificato una pecora a Al-Uzza (e questo atto potrebbe benissimo essere stato compiuto sul Monte Hira, noto luogo di devozione al dio della luna Allah e sua figlia al-Uzza e sul quale avvenne poi l’incontro tra Maometto e l’angelo) ma si narra che durante lo scontro armato tra i meccani e i Musulmani a Badr i primi innalzarono il vessillo di al-Uzza in battaglia e che per questo, dopo la vittoria, il Profeta inviò Khalid ibn al-Walid (che poi conquistò la Siria all’Islam), a distruggere il tempio di al-Uzza a Nakhla[19].
Una volta distrutti tutti gli idoli, Allah regnava incontrastato nel Hijaz e la dea madre era scomparsa dalla sfera della religione araba, ma essa sopravvive ancora nelle leggende musulmane in quelli che vengono comunemente definiti i “versetti satanici”, un capitolo della vita di Maometto che i Musulmani vogliono dimenticare e che, per le vicende che seguirono, ha reso famoso, qualche anno fa, un romanzo omonimo di Salman Rushdie.
L’ambientazione è la Mecca, alcuni anni prima della Hijra, molto probabilmente nel 619 d.C., quando il protettore di Maometto, Abu Talib, e sua moglie, Khadija, erano entrambi morti o in punto di morte. I meccani erano diventati sempre più ostili verso il Profeta e ridicolizzavano la sua missione in ogni modo possibile. La cosa peggiore era che spesso lo tentavano promettendogli fama e fortuna se si fosse astenuto dall’attaccare le loro divinità. Maometto non era disposto a compromettere la sua missione e aveva sempre declinato le loro offerte, finché, come narra al-Tabari, non arrivò la tentazione più grande, quando i meccani offrirono a Maometto un compromesso tale per cui egli avrebbe adorato al-Lat e al-’Uzza per un anno, e essi avrebbero adorato Allah per un anno.
A questo punto i Profeta, tentato da Satana, avrebbe risposto, secondo al-Tabari:
“Che ne pensate voi di al-Lāt e di al-ʿUzzā
e di Manāt, il terzo idolo?
Ecco le gharānīq, la cui intercessione è cosa grata a Dio“[20]
(Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān ʿan taʿwīl al-Qurʾān, XVII, pp. 186-90)
La parola araba “gharānīq” del “verso satanico” è un “hapax”, un vocabolo che ricorre solo in questo testo, e si riferirebbe, secondo i commentatori, alle gru della Numidia ma, poiché un titolo della triade sacra era “le tre sublimi gru”, il significato implicito era quello di un’ammissione dell’esistenza delle tre divinità e un’attestazione del loro ruolo come intermediari divini.
Secondo Ṭabarī, le parole destarono forte stupore tra gli astanti che non si aspettavano che Maometto scendesse a patti con il politeismo pagano della stragrande maggioranza della città. Conseguentemente, sempre secondo al-Tabari, sarebbe stata avviata una preghiera collettiva per sottolineare la ritrovata concordia cittadina e la notizia dei “versetti satanici” avrebbe persino convinto alcuni emigrati (“muhājirūn”) a tornare dall’Abissinia, dove si erano rifugiati.
Oggi ci appare evidente l’incontestabile vantaggio politico derivante da una interpretazione sincretica e accomodante da parte di Maometto, ma è, altresì, chiaro che il prezzo spirituale di tale vantaggio sarebbe stato eccezionale, dal momento che il Profeta avrebbe smentito il più volte asserito monoteismo assoluto della nuova religione.
La mattina seguente, infatti, Maometto ritrattò quanto affermato, chiarendo che le parole gli erano state sussurrate all’orecchio sinistro (e non a quello destro, come normalmente faceva l’arcangelo Gabriele) e che quindi erano di origine satanica.
I “versetti satanici” furono disconosciuti da Maometto che fornì, al loro posto, l’autentica rivelazione:
“Che ne pensate voi di al-Lāt e di al-ʿUzzā
e di Manāt, il terzo idolo?
Voi dunque avreste i maschi e Lui le femmine?
La divisione sarebbe iniqua!
Esse non sono che nomi dati da voi e da’ vostri padri,
pei quali Iddio non v’inviò autorità alcuna.
Costoro non seguono altro che congetture e le passioni dell’animo,
mentre già giunse loro dal Signore la Guida“[21]
Che cosa significa questa “correzione”? In una società patriarcale come quella araba era considerato un peccato avere solo figlie (come accaduto proprio a Maometto che pare fosse notevolmente imbarazzato per questo motivo) e, dunque, nel caso le tre divinità fossero state reali, Allah sarebbe risultato imperfetto a causa della sua incapacità di procreare figli maschi. Inoltre, come sostenuto da Alfred Guillaume[22], l’interpolazione avrebbe reso quegli esseri divini o semi-divini intercessori di Allah, un ufficio che nell’Islam doveva essere accordato solo a Maometto stesso.
Conseguentemente le parole pronunciate da Maometto vennero successivamente eliminate dalla versione canonizzata del Corano, rimanendo, però, in un canto che i meccani utilizzavano quando camminavano intorno alla Pietra Nera[23].
Resta il fatto che, seppur per poche ore, il Profeta fosse sceso a compromessi seri con il paganesimo, con conseguenze fondamentali, dal momento che, se questa leggenda fosse vera (come ammesso in generale da numerosi commentatori musulmani), dovremmo pensare che non esista alcuna certezza che altre parti del Corano non siano state ispirate da Satana e non da Dio. Una delle più belle hadith riporta è il seguente discorso di Allah a Maometto: “il mio servo [Maometto] mi è sempre vicino con le sue opere volontarie di pietà, tanto che ho imparato ad amarlo e da quando lo amo io sono il suo occhio, il suo orecchio, la sua lingua, il suo piede, la sua mano. Egli vede attraverso di me, sente attraverso di me, parla attraverso di me, si muove e prova sentimenti attraverso di me“[24], ma se Maometto è “pura creta nelle mani di Dio”, come avrebbe potuto Dio stesso ammettere l’esistenza di divinità femminili? Il Profeta risolse il problema affermando: “Non inviammo prima di te nessun messaggero e nessun profeta, senza che Satana si intromettesse nella sua recitazione. Ma Allah abroga quello che Satana suggerisce. Allah conferma i Suoi segni. Allah è sapiente, saggio“[25], ma rimane l’incongruenza della possibilità satanica di interpolare il messaggio divino trasmesso direttamente attraverso il Profeta.
Senza addentrarci in questioni teologiche che poco ci riguardano, ciò che conta è che alla base del proto-islamismo (e, si sarebbe quasi tentati di dire, in competizione con esso) troviamo istanze di femminino sacro ben evidenti che, sebbene progressivamente nascoste da una società fortemente maschilista, tendono a riemergere in simboli, azioni, discorsi ancora vivi ed attivi nell’Islam odierno.
Ciò appare particolarmente evidente nello Sciismo e nel Sufismo, le correnti più mistiche del mondo musulmano. Non è un caso che nel Sufismo la “Sophia”, la saggezza di Allah che illumina i cuori dei saggi esoteristi sia definita “l’ultima immagine di Dio, l’Amato … la forma principale al di là della forma, l’ostacolo alla Via e la Via …“[26] e sia considerata così fondamentale da assumere una personalità a sé stante. Allo stesso modo, non è un caso che nello Sciismo esista un particolare culto di Fatma, vista come madre del Logos, in una palese eredità del ruolo già appartenuto in ambito iranico a Spenta Armaiti, e come fonte della saggezza dell’Imam[27], venendo a rappresentare, in fin dei conti, di nuovo una sorta di Sophia.
Proprio riguardo alla figura della Sophia, Ibn Arabi afferma che la sua natura universale (“tavi’at al-kull”) “è il lato femminile o materno dell’atto creativo. Lei è il ‘misericordioso soffio’ di Dio” [Nafa ar-Rahman]“[28] e che essa è anche la dimora di Dio perché “Dov’era il vostro Signore prima di creare la Creazione? Era in una nuvola, non c’era spazio sopra o sotto e la nuvola era la sua Saggezza“[29] ’46.
Infine, all’interno dell’Islam sufi, i principi divini maschile e femminile sono caratterizzati dalla penna e dalla tavoletta: la penna è Dio che scrive sul tabula rasa dell’anima del mondo[30], con un forte riferimento all’atto generativo e alla congiunzione tra principio maschile e femminile.
Ecco, dunque, che, ancora una volta, ritorna il principio generativo come nucleo fondamentale, pur nascosto e dissimulato, del senso religioso. Ma, in una società in cui la componente maschile impera al punto da informare di sé pervasivamente l’intero ambito religioso, anche il solo riferimento a tale nucleo risulta scandaloso. Eppure, il principio primo archetipico maternale trova comunque il modo di riemergere …
[1] Daniele, cap.3
[2] I Re 14:23, 2 Re 18:4, 23:14, Isaia 17:08, 27:9, Ger. 43:13; Ez. 08:05; Michea 5:13
[3] C. Farah, Islam, Barron’s Educational Series 2003, p.28
[4] I Re 19:18
[5]W. Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, II, Sheffield Academic Press 2009, p. 109 ss.
[6] A. Guillaume, The Life of Mohammad, Oxford University Press 2002, p.49
[7] Ad esempio F.E. Peters, Muhammad and the Origins of Islam, State University of New York Press 1994, pp. 98 ss.
[8] A. McLean, The Triple Goddess: An Exploration of the Archetypal Feminine, Phanes Press 1991, passim
[9] M. Stone, Ancient Mirrors of Womanhood: A Treasury of Goddess and Heroine Lore from Around the World, beacon Press 1990, passim
[10] A. McLean, Citato, pp. 80 ss.
[11] J. Teixidor, The Pantheon of Palmyra, Brill Academic 1997, pp. 55-58.
[12] A. Guillaume, Citato, p.61
[13] P. Hitti, History of the Arabs, Palgrave Macmillan 2002, p.98
[14] T. Andrae, Qu’ran, Religion and Theology, Volume 1, Routledge 2008, p.87
[15] E. Neumann, The Great Mother an Analysis of the Archetype, Kessinger Publishing 2004, pp.67-68
[16] A. Guillaume, Citato, p. 207
[17] F.E. Peters, Citato, p.110
[18] A. Guillaume, Citato, p. 108
[19] Ivi, pp. 565-566
[20] al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʿwīl al-Qurʾān, XVII, pp. 186-90
[21] Il Corano,m53:19-23. Trad. A.Bausani, BUR 2006
[22] A. Guillaume, Citato, pp. 112 ss.
[23] Ivi, p. 36
[24] I. Goldziher, Mohammed and Islam, General Books LLC. 2010, pp.42-43
[25] Corano, 22:52
[26] K. Cragg, Counsels in Contemporary Islam, ACLS Humanities 2008, p.81
[27] H. Corbin, Swedenborg & Esoteric Islam, Swedenborg Foundation Publishers 1995, p.47
[28] T. Burckhardt, Introduction to Sufi Doctrine, Fons Vitae 1997, pp.67-69
[29] ivi
[30] L. Bakhtiar, Sufi: Expressions of the Mystic Quest, Thames & Hudson 2004, pp. 86 ss.
Centro Studi La Runa.
i Misteri di Eleusi :incontro fra la vita e la morte
di Stefano Arcella.

_
Il significato generale dei Misteri.
Prima di entrare nel merito dei Misteri di Eleusi è bene chiarire al lettore il significato generale che, nel mondo classico, si attribuiva al sostantivo “Mysteria”. Esso designa i segreti, ossia conoscenze inaccessibili, in ragione stessa della loro natura e della loro profondità, alla maggioranza degli uomini e riservate solo a quei pochi, dotati delle qualità intellettive e della sensibilità spirituale necessarie per accoglierle ed interiorizzarle. Un livello di conoscenza riservato a pochi eletti (ossia persone scelte secondo un criterio rigorosamente selettivo), quindi esoterico nel senso pieno del termine ed iniziatico in quanto concernente il percorso interiore per l’inizio di una nuova vita. Gli antichi Elleni non concepiscono che si possa partecipare a chiunque, indistintamente e senza precauzioni, le dottrine spirituali e la stessa impostazione aristocratica – nel senso qualitativo dell’espressione – riguarda l’accesso alle arti ed alle scienze. Per essi la medicina e la stessa filosofia, nei suoi aspetti più profondi, restano scienze segrete. Per la medicina, abbiamo la testimonianza di Sorano, il quale nella sua Vita di Ippocrate, scrive:
“Ippocrate insegnava la sua arte a coloro che erano qualificati per apprenderla, facendo loro prestar giuramento… Infatti le cose sacre si rivelano a uomini consacrati: i profani non possono occuparsene, prima di essere stati iniziati ai sacri riti di questa scienza” (in V. Magnien, tr.it. I Misteri d’Eleusi, Edizioni di Ar, Padova, 1996, p.21).
Questo riferimento alla medicina può apparire estraneo all’argomento specifico delle religioni misteriche, per chi guardi le cose dal punto di vista della mentalità scientifica moderna che separa rigorosamente scienza e religione, ma non lo è affatto se ci si cala nella mentalità degli Antichi per i quali l’essere umano è un tutto unitario che si articola nei tre elementi costituitivi di soma, psyché e nous (corpo, anima e mente); la salute del corpo e dell’anima sono strettamente connesse, ogni squilibrio fisico riflette un disordine più profondo. L’accesso alle dottrine spirituali più segrete è quindi la base per una migliore e diversa armonia dell’essere umano, anche sul piano fisico, poiché, come spiega Plotino nelle Enneadi, i piani dell’Essere sono distinti ma collegati. Per la filosofia sono illuminanti le testimonianze di Clemente d’Alessandria e di Giamblico sui Pitagorici e su Platone, nonché quella dell’imperatore Giuliano sugli Stoici.
“Non soltanto i Pitagorici e Platone – scrive Clemente d’Alessandria – nascondono la maggior parte dei loro princìpi dottrinali, ma gli stessi Epicurei dicono di avere dei segreti, e di non permettere a chiunque di consultare i libri nei quali sono esposti. D’altra parte ancora, secondo gli Stoici, Zenone scrisse alcuni trattati che essi non danno da leggere facilmente ai loro discepoli” (Stromata, V, 9).
“I più importanti e universali princìpi insegnati alla loro scuola – dice Giamblico – i Pitagorici li conservavano sempre in loro stessi, osservando un perfetto silenzio, in guisa da non svelarli agli exoterici, e affidandosi senza l’ausilio della scrittura, come divini misteri, alla memoria di quelli che dovevano succedere loro” (Vita di Pitagora, edizione Nauck, 32, par.226).
“Si ingiungeva a quelli del Portico di venerare gli Dei, di essere iniziati a tutti i Misteri, e di essere perfezionati dalle più sante iniziazioni (teletài)” (Giuliano, Orazioni, 108 a).
La filosofia aveva dunque, nel suo nucleo più interno, un carattere misterico e spirituale, comprendendo l’accesso a verità intuitive che trascendono il pensiero logico-discorsivo, ed analogo discorso può farsi per le arti figurative e per la poesia, che avevano tutte un’ispirazione sacra ed una radice misterica. Abbiamo voluto fare queste precisazioni generali affinché il lettore comprenda che questa impostazione misterica non era limitata a specifiche confraternite praticanti questo o quel culto, ma dava il tono generale a tutta una civiltà, in considerazione dello stretto legame che univa i vari aspetti della realtà alla luce di una visione del mondo e dell’uomo di carattere sintetico ed unitivo. I Misteri si fondavano sempre su un mito, sulla narrazione di una vicenda divina avvenuta in illo tempore, in un tempo fuori del tempo, per dirla con l’espressione di Mircea Eliade, lo storico delle religioni che ha particolarmente evidenziato come il rito antico reiterasse e riattualizzasse una vicenda metastorica che si calava nella storia e nella quotidianità dell’uomo.
Il mito: Persefone negli Inferi e l’incontro delle due Dee.
La fonte basilare per la conoscenza del mito che racchiude l’archetipo dei Misteri eleusini è l’Inno omerico a Demetra che canta come la Dea istituì i Misteri di Eleusi in occasione del suo soggiorno in questa città.
“Prima di partire, ella svelò ai sovrani amministratori della giustizia, a Trittolemo, a Diocle, il fustigator di cavalli, alla forza di Eumolpo, a Keleo, il conduttor di guerrieri, la perfetta celebrazione dei sacri riti; ella ammaestrò tutti negli òrgia venerabili… Felice chi fra gli uomini che vivono sulla Terra li ha contemplati! Chi non è stato perfezionato nei sacri Misteri, chi non vi ha preso parte, mai avrà, dopo morto, un destino simile al primo, oltre l’orizzonte oscuro” (Inni omerici, vv.473-482).
Il termine òrgia ha, nel greco antico, un senso diverso da quello comune di “orgia” nella nostra lingua; esso designava un intenso stato interiore in cui l’iniziato si sentiva immerso e quindi spinto ad una apertura di coscienza verso la dimensione del sacro, vissuta come un quid più profondo dell’uomo stesso, ossia come una “trascendenza immanente”. Le iscrizioni e le raffigurazioni mostrano costantemente la Dea Demetra in relazione coi Misteri di Eleusi. Associata a Demetra è Persefone, o Core, sua figlia. Le iscrizioni eleusine chiamano Demetra e Persefone “le due Dee” e gli autori antichi adoperano la locuzione “la madre e la figlia”. Nel mito omerico Kore, nel mentre raccoglieva fiori nella pianura di Nysa, fu rapita da Plutone (Ade), dio degli Inferi. Demetra la cercò per nove giorni, durante i quali non gustò l’ambrosia, il nettare degli dei. Infine Elios (il Sole) le rivelò la verità: Zeus aveva deciso di dare in sposa Kore a suo fratello Plutone. Furibonda contro il sovrano degli dèi, Demetra non tornò sull’Olimpo. Nelle sembianze di una vecchia, si diresse verso Eleusi e si sedette vicino al Pozzo delle Vergini (allusione simbolica ad un rito di purificazione). Interrogata dalle figlie del re Celeo, dichiarò che il suo nome era Doso e che era sfuggita ai pirati, i quali l’avevano rapita a Creta. Accettò poi l’invito di fungere da nutrice dell’ultimo figlio della regina Metanira. Entrò nel palazzo, si sedette su uno sgabello e restò a lungo silenziosa (allusione simbolica all’importanza rituale del silenzio mentale, come superamento del pensiero dialettico). Infine una serva, Iambe, riuscì a farla ridere con i suoi scherzi grossolani. Demetra rifiutò la coppa di vino rosso offerta da Metanira e chiese del ciceone, mescolanza di orzo tritato, di acqua e di foglie di menta. La dea non allattò Demofonte, figlio del re al quale faceva da nutrice, ma gli soffregò il corpo con l’ambrosia e durante la notte lo nascose nel fuoco “come un tizzone” (allusione simbolica alla potenza purificatrice del fuoco e ad un probabile rito di iniziazione che si svolgeva in presenza di un fuoco rituale). Il bambino assomigliava sempre più ad un dio, ma questo processo di rigenerazione fu interrotto dalla regina Metanira che una notte scoprì il figlio tra le braci e prese a lamentarsi. ”Uomini ignoranti, insensati, che non sapete vedere il vostro destino di ventura o di sventura!” esclama allora la Dea. Demofonte non potrà più sfuggire al suo destino mortale. L’epilogo del mito narra che Demetra, ritrova sua figlia Kore, grazie all’intervento di Zeus su Plutone, che riesce, però, ad introdurre nella bocca di Persefone un chicco di melagrana e la costringe ad inghiottirlo; ciò determina il ritorno annuale di Kore, per quattro mesi, presso il suo sposo nell’Ade. Demetra, dopo aver ritrovato sua figlia, acconsente a ritornare fra gli dèi e la terra si ricopre di vegetazione (allusione all’origine sacra e misterica dell’agricoltura). Prima di tornare sull’Olimpo, la dea rivela i suoi riti e insegna i suoi misteri a Trittolemo, Diocle, Eumolpo e Celeo.
L’inno omerico menziona due tipi di iniziazione; più esattamente spiega i Misteri eleusini sia come ricongiungimento delle due Dee sia come conseguenza della mancata immortalizzazione di Demofonte. Demetra stava per trasformare un uomo in un dio, ma la trasformazione è bloccata dalla madre del bambino; il mito può leggersi come allusione al destino mortale dell’uomo, ad un processo di elevazione interrotto, che può essere completato solo attraverso un percorso misterico ed iniziatico, per coloro che sono idonei ad affrontarlo. Demetra è la Terra madre, la “nutrice carissima”, colei che dona la perfezione della vita, che porta a compimento la vita in tutte le sue manifestazioni, dalle superiori alle inferiori e la virtù è la perfezione delle anime, secondo la testimonianza di Proclo (Sul Cratilo, 168). Demetra è colei che ha donato agli uomini l’agricoltura e, assieme ad essa, i Misteri. La dea non ha fatto agli uomini due doni diversi, perché, stando alle fonti antiche, l’agricoltura è parte integrante dei Misteri. Varrone – secondo quanto ci riferisce Sant’Agostino – nel parlare dei misteri eleusini, non ha dato che ragguagli sull’agricoltura. Egli afferma, infatti, che molti particolari, nei Misteri, si riferiscono solo alla scoperta dei cereali (S. Agostino, La città di Dio, III,20). La coltivazione della terra è allo stesso tempo, simbolo e supporto per la coltivazione e l’affinamento della propria interiorità. In altri termini non si tratta solo di un simbolo, ma di una pratica estremamente concreta, ogni atto potendo essere il supporto di una elevazione interiore. A questo riguardo, si può ricordare che nella vita del contadino è molto importante l’essere in sintonia con le forze cosmiche, con le quattro fasi della luna e con quelle del sole e, quindi, coi ritmi delle stagioni. L’uomo delle culture contadine sente la sua intima connessione col Tutto cosmico, l’interazione fra la sua azione e le forze cosmiche, a differenza dell’uomo moderno che si chiude nel suo guscio razionale ed individualistico, rimuovendo il suo legame con la vita e l’energia dell’universo.
Il potere di Persefone è complementare a quello di Demetra. Mediante i Misteri l’uomo riceve una nuova vita ed una nuova anima. Il potere che infonde la nuova vita iniziatica è lo stesso principio, Persefone, che dal seme affidato alla terra e nascosto in essa – quindi il seme nell’oscurità – fa nascere una nuova pianta, che fa discendere nella terra un’anima destinata a dare forma e vita ad un corpo umano, che fa morire gli uomini e regna sui morti, che riconduce le anime verso l’alto, per dare loro una vita nuova. Persefone è, al tempo stesso, la dea della vita e della morte, a dimostrazione dell’inestricabile nesso vita-morte che caratterizzava la visione del mondo e della vita presso gli Antichi, un nesso presente anche in altri filoni misterici, come quello mitriaco, in cui la spiga di grano – simbolo comune all’iconografia eleusina – nasce dalla coda o dal sangue del toro sacrificato.
“Proserpina rapita da Hades è l’energia di germinazione che viene ritratta quando il sole va verso il solstizio d’inverno” (G. Lido, Dei Mesi, 4,137).
Esiste dunque un legame fra il ritrarsi dell’energia fecondatrice, la “morte del sole” fisico – che corrisponde alla nascita del sole interiore, quel “sole di mezzanotte” di cui parla Apuleio ne L’asino d’oro – e la discesa agli Inferi, ossia il viaggio dell’uomo nella profondità più oscura del suo essere, per trasformarla in creatività spirituale che poi sboccia e fiorisce con la primavera, i due aspetti, quello cosmico e quello interiore, essendo sempre collegati, poiché l’uomo è parte integrante del Tutto. La correlazione fra vicenda mitica e vicenda dell’anima umana è ben presente nella coscienza degli Antichi. “Come Core, l’anima discende nella génesis – scrive Olimpiodoro – Come Dioniso, essa nella génesis si disunisce e si disperde. Come Prometeo e i Titani, è avvinta ad un corpo, dal quale si distacca, dopo essersi rinvigorita come Eracle. Essa si riunifica raccogliendosi grazie ad Apollo e Atena salvatrice, praticando in vera purità la Filosofia. Essa risale verso la sua origine con Demetra”. (Olimpiodoro, Commento al Fedone, ediz. Norvin, pag. 111).
La discesa agli Inferi di Persefone può essere letta – in base alla polivalenza dei simboli antichi – anche come la discesa dell’anima nel mondo della generazione, cui segue il passaggio dall’Uno al molteplice (lo smembramento di Dioniso) e poi lo sforzo di liberazione simboleggiato dalle fatiche di Eracle. Il ritorno all’Uno avviene grazie alla forza della luce spirituale (Apollo) ed alla sapienza iniziatica (Atena Salvatrice). Molteplici sono le varianti del mito, fra le quali quella secondo cui Persefone è figlia di Zeus e Demetra, ossia l’anima nasce dall’incontro fra il Principio virile olimpico e la Madre Terra, il principio femminile fecondatore, inteso come forza cosmica. Non conosciamo i contenuti esperienziali dei Grandi Misteri, che si svolgevano nel mese di settembre-ottobre (Boedromione), ma è intuitivo ritenere che essi consistessero in una reiterazione esperienziale del mito della discesa agli Inferi di Kore, quindi in una esperienza di buio e di tenebre cui seguiva una esperienza di luce, una trasformazione dello stato interiore nella direzione dell’unificazione con la divinità. La rinascita della vegetazione era l’aspetto mitico rivissuto nei Piccoli Misteri celebrati nel mese di Antesterione, in primavera, segnati da purificazioni, digiuni e sacrifici; l’aspetto della manifestazione era quello minore, rispetto alla fase in cui si poneva il seme spirituale della nuova nascita, il seme che deve morire per fruttificare.
Un messaggio per l’uomo contemporaneo
I Misteri di Eleusi sono una preparazione al post-mortem, come Omero chiaramente ci dice. Gli Antichi – parliamo degli iniziati ai Misteri – mantenevano sempre viva la consapevolezza del nostro destino mortale e della necessità di prepararsi alla morte ed alle esperienze che l’anima dovrà affrontare nel post-mortem. Si può ricordare, a questo proposito, che presso i Tibetani e presso gli Egizi esistono – e sono ora ampiamente pubblicati e conosciuti – i Libri dei Morti, che venivano meditati in vita dalle élites sacerdotali per prepararsi alle prove dell’aldilà.
L’uomo contemporaneo è caratterizzato dalla rimozione, nella sua vita, della dimensione della morte; essa è messa, per così dire, fra parentesi, come se si dovesse vivere in eterno. Tutta la febbre del denaro, l’accumulazione di ricchezze, il fenomeno del consumismo – i bisogni artificiali indotti dalla pubblicità – si spiegano in questa chiave. Il mondo moderno è la via degli attaccamenti, che sono – secondo le dottrine sapienziali di Oriente e d’Occidente – la radice, il seme della trasmigrazione nel ciclo delle rinascite, il ciclo della génesis di cui parlavano gli antichi Greci. La fuga dalla morte, il vedere una cerimonia funebre come qualcosa che riguarda gli altri, che non ci tocca direttamente è la strada di quella “possibilità inautentica” di cui parlava il filosofo Martin Heidegger, del quale si stanno studiando alcune affinità con le filosofie orientali. I Misteri di Eleusi ci richiamano alla consapevolezza della nostra impermanenza, come base per una diversa scala di valori, per fondare un modo diverso, più limpido e distaccato, di guardare alla vita e quindi anche al vivere sociale. L’unione fra Cielo (Zeus) e Terra (Demetra), l’origine sacra dell’agricoltura, il nesso fra questa e i Misteri, ci richiamano alla coscienza dell’intima unità del tutto, della partecipazione dell’uomo ad un Tutto cosmico cui è legato da mille fili, dall’aria che respira ai frutti della terra di cui si nutre, all’acqua che gli è indispensabile, all’energia solare ed a quella della luna. La base di una vera ecologia non può che essere di natura spirituale, in termini di visione del mondo; lo stravolgimento dell’ecosistema è, innanzitutto, un’alterazione delle forze cosmiche, delle energie universali i cui effetti si ritorcono a danno dell’uomo. La natura può essere trasformata, non distrutta. E’ l’uomo che pone le basi per la sua stessa distruzione.
La discesa agli Inferi, l’esperienza delle tenebre e poi della luce ci richiama alla necessità di conoscere sé stessi, di osservarsi, per vedere i propri limiti ed adoperarsi per superarli. I Pitagorici e gli Stoici praticavano l’“esame di coscienza” quotidiano, come momento di autoconoscenza e stimolo al perfezionamento morale; l’uomo moderno – coinvolto nel vortice di una vita frenetica – vive spesso nella meccanicità e nella distrazione e non prende coscienza dei suoi limiti e dei suoi errori. La comprensione, anche solo intellettuale, della spiritualità misterica può essere un validissimo aiuto per un diverso atteggiamento esistenziale che dia un senso alla vita.
Centro Studi la Runa.
Alcune considerazioni dell'autore non sono condivisibili. Ad esempio, " il sole di mezzanotte" o " la discesa agli Inferi" hanno tutt'altro significato per gli studiosi di Alchimia. Poi, la natura " trasformata" lascia di stucco. Se la " nostra " Natura, lo dovesse consentire si può cercare di seguirla in un cammino nella sabbie, difficoltoso e incerto per chi pratica l'Alchimia, come insegna Limojon de Saint Disdier nella Lettera ai veri discepoli di Ermete.
gdg
Il significato generale dei Misteri.
Prima di entrare nel merito dei Misteri di Eleusi è bene chiarire al lettore il significato generale che, nel mondo classico, si attribuiva al sostantivo “Mysteria”. Esso designa i segreti, ossia conoscenze inaccessibili, in ragione stessa della loro natura e della loro profondità, alla maggioranza degli uomini e riservate solo a quei pochi, dotati delle qualità intellettive e della sensibilità spirituale necessarie per accoglierle ed interiorizzarle. Un livello di conoscenza riservato a pochi eletti (ossia persone scelte secondo un criterio rigorosamente selettivo), quindi esoterico nel senso pieno del termine ed iniziatico in quanto concernente il percorso interiore per l’inizio di una nuova vita. Gli antichi Elleni non concepiscono che si possa partecipare a chiunque, indistintamente e senza precauzioni, le dottrine spirituali e la stessa impostazione aristocratica – nel senso qualitativo dell’espressione – riguarda l’accesso alle arti ed alle scienze. Per essi la medicina e la stessa filosofia, nei suoi aspetti più profondi, restano scienze segrete. Per la medicina, abbiamo la testimonianza di Sorano, il quale nella sua Vita di Ippocrate, scrive:
“Ippocrate insegnava la sua arte a coloro che erano qualificati per apprenderla, facendo loro prestar giuramento… Infatti le cose sacre si rivelano a uomini consacrati: i profani non possono occuparsene, prima di essere stati iniziati ai sacri riti di questa scienza” (in V. Magnien, tr.it. I Misteri d’Eleusi, Edizioni di Ar, Padova, 1996, p.21).
Questo riferimento alla medicina può apparire estraneo all’argomento specifico delle religioni misteriche, per chi guardi le cose dal punto di vista della mentalità scientifica moderna che separa rigorosamente scienza e religione, ma non lo è affatto se ci si cala nella mentalità degli Antichi per i quali l’essere umano è un tutto unitario che si articola nei tre elementi costituitivi di soma, psyché e nous (corpo, anima e mente); la salute del corpo e dell’anima sono strettamente connesse, ogni squilibrio fisico riflette un disordine più profondo. L’accesso alle dottrine spirituali più segrete è quindi la base per una migliore e diversa armonia dell’essere umano, anche sul piano fisico, poiché, come spiega Plotino nelle Enneadi, i piani dell’Essere sono distinti ma collegati. Per la filosofia sono illuminanti le testimonianze di Clemente d’Alessandria e di Giamblico sui Pitagorici e su Platone, nonché quella dell’imperatore Giuliano sugli Stoici.
“Non soltanto i Pitagorici e Platone – scrive Clemente d’Alessandria – nascondono la maggior parte dei loro princìpi dottrinali, ma gli stessi Epicurei dicono di avere dei segreti, e di non permettere a chiunque di consultare i libri nei quali sono esposti. D’altra parte ancora, secondo gli Stoici, Zenone scrisse alcuni trattati che essi non danno da leggere facilmente ai loro discepoli” (Stromata, V, 9).
“I più importanti e universali princìpi insegnati alla loro scuola – dice Giamblico – i Pitagorici li conservavano sempre in loro stessi, osservando un perfetto silenzio, in guisa da non svelarli agli exoterici, e affidandosi senza l’ausilio della scrittura, come divini misteri, alla memoria di quelli che dovevano succedere loro” (Vita di Pitagora, edizione Nauck, 32, par.226).
“Si ingiungeva a quelli del Portico di venerare gli Dei, di essere iniziati a tutti i Misteri, e di essere perfezionati dalle più sante iniziazioni (teletài)” (Giuliano, Orazioni, 108 a).
La filosofia aveva dunque, nel suo nucleo più interno, un carattere misterico e spirituale, comprendendo l’accesso a verità intuitive che trascendono il pensiero logico-discorsivo, ed analogo discorso può farsi per le arti figurative e per la poesia, che avevano tutte un’ispirazione sacra ed una radice misterica. Abbiamo voluto fare queste precisazioni generali affinché il lettore comprenda che questa impostazione misterica non era limitata a specifiche confraternite praticanti questo o quel culto, ma dava il tono generale a tutta una civiltà, in considerazione dello stretto legame che univa i vari aspetti della realtà alla luce di una visione del mondo e dell’uomo di carattere sintetico ed unitivo. I Misteri si fondavano sempre su un mito, sulla narrazione di una vicenda divina avvenuta in illo tempore, in un tempo fuori del tempo, per dirla con l’espressione di Mircea Eliade, lo storico delle religioni che ha particolarmente evidenziato come il rito antico reiterasse e riattualizzasse una vicenda metastorica che si calava nella storia e nella quotidianità dell’uomo.
Il mito: Persefone negli Inferi e l’incontro delle due Dee.
La fonte basilare per la conoscenza del mito che racchiude l’archetipo dei Misteri eleusini è l’Inno omerico a Demetra che canta come la Dea istituì i Misteri di Eleusi in occasione del suo soggiorno in questa città.
“Prima di partire, ella svelò ai sovrani amministratori della giustizia, a Trittolemo, a Diocle, il fustigator di cavalli, alla forza di Eumolpo, a Keleo, il conduttor di guerrieri, la perfetta celebrazione dei sacri riti; ella ammaestrò tutti negli òrgia venerabili… Felice chi fra gli uomini che vivono sulla Terra li ha contemplati! Chi non è stato perfezionato nei sacri Misteri, chi non vi ha preso parte, mai avrà, dopo morto, un destino simile al primo, oltre l’orizzonte oscuro” (Inni omerici, vv.473-482).
Il termine òrgia ha, nel greco antico, un senso diverso da quello comune di “orgia” nella nostra lingua; esso designava un intenso stato interiore in cui l’iniziato si sentiva immerso e quindi spinto ad una apertura di coscienza verso la dimensione del sacro, vissuta come un quid più profondo dell’uomo stesso, ossia come una “trascendenza immanente”. Le iscrizioni e le raffigurazioni mostrano costantemente la Dea Demetra in relazione coi Misteri di Eleusi. Associata a Demetra è Persefone, o Core, sua figlia. Le iscrizioni eleusine chiamano Demetra e Persefone “le due Dee” e gli autori antichi adoperano la locuzione “la madre e la figlia”. Nel mito omerico Kore, nel mentre raccoglieva fiori nella pianura di Nysa, fu rapita da Plutone (Ade), dio degli Inferi. Demetra la cercò per nove giorni, durante i quali non gustò l’ambrosia, il nettare degli dei. Infine Elios (il Sole) le rivelò la verità: Zeus aveva deciso di dare in sposa Kore a suo fratello Plutone. Furibonda contro il sovrano degli dèi, Demetra non tornò sull’Olimpo. Nelle sembianze di una vecchia, si diresse verso Eleusi e si sedette vicino al Pozzo delle Vergini (allusione simbolica ad un rito di purificazione). Interrogata dalle figlie del re Celeo, dichiarò che il suo nome era Doso e che era sfuggita ai pirati, i quali l’avevano rapita a Creta. Accettò poi l’invito di fungere da nutrice dell’ultimo figlio della regina Metanira. Entrò nel palazzo, si sedette su uno sgabello e restò a lungo silenziosa (allusione simbolica all’importanza rituale del silenzio mentale, come superamento del pensiero dialettico). Infine una serva, Iambe, riuscì a farla ridere con i suoi scherzi grossolani. Demetra rifiutò la coppa di vino rosso offerta da Metanira e chiese del ciceone, mescolanza di orzo tritato, di acqua e di foglie di menta. La dea non allattò Demofonte, figlio del re al quale faceva da nutrice, ma gli soffregò il corpo con l’ambrosia e durante la notte lo nascose nel fuoco “come un tizzone” (allusione simbolica alla potenza purificatrice del fuoco e ad un probabile rito di iniziazione che si svolgeva in presenza di un fuoco rituale). Il bambino assomigliava sempre più ad un dio, ma questo processo di rigenerazione fu interrotto dalla regina Metanira che una notte scoprì il figlio tra le braci e prese a lamentarsi. ”Uomini ignoranti, insensati, che non sapete vedere il vostro destino di ventura o di sventura!” esclama allora la Dea. Demofonte non potrà più sfuggire al suo destino mortale. L’epilogo del mito narra che Demetra, ritrova sua figlia Kore, grazie all’intervento di Zeus su Plutone, che riesce, però, ad introdurre nella bocca di Persefone un chicco di melagrana e la costringe ad inghiottirlo; ciò determina il ritorno annuale di Kore, per quattro mesi, presso il suo sposo nell’Ade. Demetra, dopo aver ritrovato sua figlia, acconsente a ritornare fra gli dèi e la terra si ricopre di vegetazione (allusione all’origine sacra e misterica dell’agricoltura). Prima di tornare sull’Olimpo, la dea rivela i suoi riti e insegna i suoi misteri a Trittolemo, Diocle, Eumolpo e Celeo.
L’inno omerico menziona due tipi di iniziazione; più esattamente spiega i Misteri eleusini sia come ricongiungimento delle due Dee sia come conseguenza della mancata immortalizzazione di Demofonte. Demetra stava per trasformare un uomo in un dio, ma la trasformazione è bloccata dalla madre del bambino; il mito può leggersi come allusione al destino mortale dell’uomo, ad un processo di elevazione interrotto, che può essere completato solo attraverso un percorso misterico ed iniziatico, per coloro che sono idonei ad affrontarlo. Demetra è la Terra madre, la “nutrice carissima”, colei che dona la perfezione della vita, che porta a compimento la vita in tutte le sue manifestazioni, dalle superiori alle inferiori e la virtù è la perfezione delle anime, secondo la testimonianza di Proclo (Sul Cratilo, 168). Demetra è colei che ha donato agli uomini l’agricoltura e, assieme ad essa, i Misteri. La dea non ha fatto agli uomini due doni diversi, perché, stando alle fonti antiche, l’agricoltura è parte integrante dei Misteri. Varrone – secondo quanto ci riferisce Sant’Agostino – nel parlare dei misteri eleusini, non ha dato che ragguagli sull’agricoltura. Egli afferma, infatti, che molti particolari, nei Misteri, si riferiscono solo alla scoperta dei cereali (S. Agostino, La città di Dio, III,20). La coltivazione della terra è allo stesso tempo, simbolo e supporto per la coltivazione e l’affinamento della propria interiorità. In altri termini non si tratta solo di un simbolo, ma di una pratica estremamente concreta, ogni atto potendo essere il supporto di una elevazione interiore. A questo riguardo, si può ricordare che nella vita del contadino è molto importante l’essere in sintonia con le forze cosmiche, con le quattro fasi della luna e con quelle del sole e, quindi, coi ritmi delle stagioni. L’uomo delle culture contadine sente la sua intima connessione col Tutto cosmico, l’interazione fra la sua azione e le forze cosmiche, a differenza dell’uomo moderno che si chiude nel suo guscio razionale ed individualistico, rimuovendo il suo legame con la vita e l’energia dell’universo.
Il potere di Persefone è complementare a quello di Demetra. Mediante i Misteri l’uomo riceve una nuova vita ed una nuova anima. Il potere che infonde la nuova vita iniziatica è lo stesso principio, Persefone, che dal seme affidato alla terra e nascosto in essa – quindi il seme nell’oscurità – fa nascere una nuova pianta, che fa discendere nella terra un’anima destinata a dare forma e vita ad un corpo umano, che fa morire gli uomini e regna sui morti, che riconduce le anime verso l’alto, per dare loro una vita nuova. Persefone è, al tempo stesso, la dea della vita e della morte, a dimostrazione dell’inestricabile nesso vita-morte che caratterizzava la visione del mondo e della vita presso gli Antichi, un nesso presente anche in altri filoni misterici, come quello mitriaco, in cui la spiga di grano – simbolo comune all’iconografia eleusina – nasce dalla coda o dal sangue del toro sacrificato.
“Proserpina rapita da Hades è l’energia di germinazione che viene ritratta quando il sole va verso il solstizio d’inverno” (G. Lido, Dei Mesi, 4,137).
Esiste dunque un legame fra il ritrarsi dell’energia fecondatrice, la “morte del sole” fisico – che corrisponde alla nascita del sole interiore, quel “sole di mezzanotte” di cui parla Apuleio ne L’asino d’oro – e la discesa agli Inferi, ossia il viaggio dell’uomo nella profondità più oscura del suo essere, per trasformarla in creatività spirituale che poi sboccia e fiorisce con la primavera, i due aspetti, quello cosmico e quello interiore, essendo sempre collegati, poiché l’uomo è parte integrante del Tutto. La correlazione fra vicenda mitica e vicenda dell’anima umana è ben presente nella coscienza degli Antichi. “Come Core, l’anima discende nella génesis – scrive Olimpiodoro – Come Dioniso, essa nella génesis si disunisce e si disperde. Come Prometeo e i Titani, è avvinta ad un corpo, dal quale si distacca, dopo essersi rinvigorita come Eracle. Essa si riunifica raccogliendosi grazie ad Apollo e Atena salvatrice, praticando in vera purità la Filosofia. Essa risale verso la sua origine con Demetra”. (Olimpiodoro, Commento al Fedone, ediz. Norvin, pag. 111).
La discesa agli Inferi di Persefone può essere letta – in base alla polivalenza dei simboli antichi – anche come la discesa dell’anima nel mondo della generazione, cui segue il passaggio dall’Uno al molteplice (lo smembramento di Dioniso) e poi lo sforzo di liberazione simboleggiato dalle fatiche di Eracle. Il ritorno all’Uno avviene grazie alla forza della luce spirituale (Apollo) ed alla sapienza iniziatica (Atena Salvatrice). Molteplici sono le varianti del mito, fra le quali quella secondo cui Persefone è figlia di Zeus e Demetra, ossia l’anima nasce dall’incontro fra il Principio virile olimpico e la Madre Terra, il principio femminile fecondatore, inteso come forza cosmica. Non conosciamo i contenuti esperienziali dei Grandi Misteri, che si svolgevano nel mese di settembre-ottobre (Boedromione), ma è intuitivo ritenere che essi consistessero in una reiterazione esperienziale del mito della discesa agli Inferi di Kore, quindi in una esperienza di buio e di tenebre cui seguiva una esperienza di luce, una trasformazione dello stato interiore nella direzione dell’unificazione con la divinità. La rinascita della vegetazione era l’aspetto mitico rivissuto nei Piccoli Misteri celebrati nel mese di Antesterione, in primavera, segnati da purificazioni, digiuni e sacrifici; l’aspetto della manifestazione era quello minore, rispetto alla fase in cui si poneva il seme spirituale della nuova nascita, il seme che deve morire per fruttificare.
Un messaggio per l’uomo contemporaneo
I Misteri di Eleusi sono una preparazione al post-mortem, come Omero chiaramente ci dice. Gli Antichi – parliamo degli iniziati ai Misteri – mantenevano sempre viva la consapevolezza del nostro destino mortale e della necessità di prepararsi alla morte ed alle esperienze che l’anima dovrà affrontare nel post-mortem. Si può ricordare, a questo proposito, che presso i Tibetani e presso gli Egizi esistono – e sono ora ampiamente pubblicati e conosciuti – i Libri dei Morti, che venivano meditati in vita dalle élites sacerdotali per prepararsi alle prove dell’aldilà.
L’uomo contemporaneo è caratterizzato dalla rimozione, nella sua vita, della dimensione della morte; essa è messa, per così dire, fra parentesi, come se si dovesse vivere in eterno. Tutta la febbre del denaro, l’accumulazione di ricchezze, il fenomeno del consumismo – i bisogni artificiali indotti dalla pubblicità – si spiegano in questa chiave. Il mondo moderno è la via degli attaccamenti, che sono – secondo le dottrine sapienziali di Oriente e d’Occidente – la radice, il seme della trasmigrazione nel ciclo delle rinascite, il ciclo della génesis di cui parlavano gli antichi Greci. La fuga dalla morte, il vedere una cerimonia funebre come qualcosa che riguarda gli altri, che non ci tocca direttamente è la strada di quella “possibilità inautentica” di cui parlava il filosofo Martin Heidegger, del quale si stanno studiando alcune affinità con le filosofie orientali. I Misteri di Eleusi ci richiamano alla consapevolezza della nostra impermanenza, come base per una diversa scala di valori, per fondare un modo diverso, più limpido e distaccato, di guardare alla vita e quindi anche al vivere sociale. L’unione fra Cielo (Zeus) e Terra (Demetra), l’origine sacra dell’agricoltura, il nesso fra questa e i Misteri, ci richiamano alla coscienza dell’intima unità del tutto, della partecipazione dell’uomo ad un Tutto cosmico cui è legato da mille fili, dall’aria che respira ai frutti della terra di cui si nutre, all’acqua che gli è indispensabile, all’energia solare ed a quella della luna. La base di una vera ecologia non può che essere di natura spirituale, in termini di visione del mondo; lo stravolgimento dell’ecosistema è, innanzitutto, un’alterazione delle forze cosmiche, delle energie universali i cui effetti si ritorcono a danno dell’uomo. La natura può essere trasformata, non distrutta. E’ l’uomo che pone le basi per la sua stessa distruzione.
La discesa agli Inferi, l’esperienza delle tenebre e poi della luce ci richiama alla necessità di conoscere sé stessi, di osservarsi, per vedere i propri limiti ed adoperarsi per superarli. I Pitagorici e gli Stoici praticavano l’“esame di coscienza” quotidiano, come momento di autoconoscenza e stimolo al perfezionamento morale; l’uomo moderno – coinvolto nel vortice di una vita frenetica – vive spesso nella meccanicità e nella distrazione e non prende coscienza dei suoi limiti e dei suoi errori. La comprensione, anche solo intellettuale, della spiritualità misterica può essere un validissimo aiuto per un diverso atteggiamento esistenziale che dia un senso alla vita.
Centro Studi la Runa.
Alcune considerazioni dell'autore non sono condivisibili. Ad esempio, " il sole di mezzanotte" o " la discesa agli Inferi" hanno tutt'altro significato per gli studiosi di Alchimia. Poi, la natura " trasformata" lascia di stucco. Se la " nostra " Natura, lo dovesse consentire si può cercare di seguirla in un cammino nella sabbie, difficoltoso e incerto per chi pratica l'Alchimia, come insegna Limojon de Saint Disdier nella Lettera ai veri discepoli di Ermete.
gdg
La cognizione del peccato originale
di Giuseppe Galasso, Corriere della Sera.

In che modo peccarono Adamo ed Eva, facendosi così cacciare dal paradiso terrestre, e condannando noi poveri e innocenti loro discendenti al rischio della dannazione eterna, la donna alle doglie del parto, l'uomo alle sue sudate fatiche, e chi vuole riguadagnare il paradiso (questa volta, celeste) a una disciplina di purezza del pensiero e delle opere? Fu il molto umano peccato del congiungimento carnale tra uomo e donna?
Non sono quesiti peregrini e oziosi. Vi si arrovellarono spiriti e intelletti cristiani ed europei tra i maggiori, e le relative risposte hanno formato una parte rilevante delle nostre idee religiose e morali. A quasi ottant'anni dal suo apparire nel 1933, il libro di Antonello Gerbi, Il peccato di Adamo ed Eva, ora riedito, a cura del figlio Sandro, da Adelphi, lo riconferma.
Il libro nacque nella scia del precedente studio di Gerbi sulla politica del romanticismo. Qui egli aveva notato che per un modesto scrittore libertino olandese, Adriaan Beverland, il peccato originale era consistito nella «voglia di copulare» e nell'attuarla; e che questa tesi aveva trovato eco in pensatori importanti, e perfino in Kant, influenzando il pensiero romantico, specie nelle sue «miscele di sensualità e religione». Poi Gerbi studiò anche gli sviluppi dell'«ipotesi beverlandiana» fin dagli inizi del cristianesimo, e ne nacque questo libro, in cui il concetto di colpa è visto come «quasi un nesso tra la religione e la morale», e ne è seguita la progressiva «umanizzazione».
Dopo Beverland, i significati metafisici e teologici del «peccato originale» vennero superati, affermando e giustificando il «peccato» come implicazione naturale della condizione umana, e vanificando l'idea di colpa. Le condanne di Adamo ed Eva (l'amore naturale come peccato, il lavoro come pena) e le idee connesse di male e di dolore furono ridotte a fatti di natura. Cadde la tradizione antica della miseria e infelicità della condizione umana, bisognosa, per il suo vizio d'origine, di comprensione e di perdono, di grazia e di redenzione. Emergevano integre la natura e l'esperienza terrena dell'uomo, non più condizionate dalla maledizione inflitta ai due progenitori, né dal pessimismo che da san Paolo e sant'Agostino a Pascal l'aveva sempre connotata.
Questo il giudizio di Gerbi, che vedeva, quindi, completarsi col romanticismo quella rivalutazione della condizione umana che, malgrado tutte le revisioni, resta un significato essenziale dell'umanesimo. Beverland si trasformava, da modesto (e anche osceno) scrittore su problemi più grandi di lui, nel casuale starter di una grande rivoluzione morale e culturale, acquisendo nella storia del pensiero europeo un posto tuttora ben poco riconosciuto.
È una tesi ardita, che spiega perché su di essa i recensori del libro, pur apprezzandone la dottrina e l'acume, avanzarono corpose riserve. Per Alberto Pincherle, ad esempio, la tesi del peccato originale come causa del male nell'uomo e nell'universo non c'è più nella nostra cultura; il cristianesimo aveva forzato in senso drammatico il testo biblico su quel peccato; dall'umanesimo in poi ci siamo allontanati dalle concezioni paoline e cristiane.
Queste critiche dovettero avere effetto su Gerbi, che continuò a raccogliere materiali sul suo tema, pensando di riscrivere il libro, come dimostra il figlio, che utilizza per la nuova edizione schede e note del padre riportate nel testo. In effetti, Gerbi aveva chiara la modesta statura di Beverland. «Occorre a volte (scrisse poi) uno scrittore di basso rango per sconsacrare e ravvivare un tema d'alta portata». Poco geniale, l'olandese aveva, tuttavia, diffuso «la sacrilega "ipotesi"» e l'aveva fatta circolare e agire anche «su menti e in ambienti chiusi» ad alte disquisizioni teoriche.
Il dubbio, tuttavia, sull'effettivo ruolo di Beverland resta, ma il merito del libro di Gerbi trascende questo punto. Egli individuò bene il grande problema filosofico adombrato nel mito del peccato originale. Un mito in cui emerge, a mio avviso, l'essenziale della vita e della storia: il non potere, cioè, mai riposare nelle braccia, per liete che siano, del presente, dell'ordine vigente delle cose. Una spinta incoercibile spinge ad andare oltre, in meglio o in peggio si vedrà poi. Ha un alto significato, sempre a mio avviso, che questa spinta (diabolica già nella Bibbia) sia affidata alla curiosità e all'iniziativa della irrequieta Eva contro il pigro e timorato Adamo. Forse pensava a questo Raffaele Mattioli, che, ricevuto il libro di Gerbi, gli rispondeva con un epigramma spiritosissimo: «nessun dalla testa mi leva/ che il pomo d'Adamo/ fosse il c...o di Eva». Si possono dire cose essenziali anche così, e si può indicare un sentiero importante di riflessione storica e teorica anche seguendo, come fa qui Gerbi, la pista di un modesto Beverland.
La questione è mal posta ? Il tema è interessante , alcune boutades molto meno. C'é un'altro libro : " Il peccato originale nel pensiero moderno " dove ( da una breve recensione ) : " Secondo una profonda intuizione di Lev Sestov, nella tradizione occidentale, accanto alla visione biblica del peccato originale, dove il male è il risultato di una libera scelta dell’uomo, sta la visione -1 - anassimandrea: il male è una colpa inscritta nel destino del vivente. Modelli opposti che convivono, confliggono e talvolta si intrecciano nel pensiero moderno, quando l’idea di Rivelazione inizia a essere negata o trascritta in termini di pura ragione. Di qui l’idea di una ricerca sul tema del peccato originale da Cusano a Solov’ev, affidando la redazione dei contributi sui singoli momenti e figure a storici della filosofia che fossero esperti nei diversi settori. Ad emergere è una pluralità di interpretazioni del male, della libertà dell’uomo e di Dio, che ridisegna e arricchisce il profilo della filosofia moderna, offrendo spunti di riflessione per la stessa teologia ".
Alle parole " ......ridisegna e arricchisce il profili della filosofia moderna ......" preferirei "ricolloca la filosofia al posto che le compete ".
gdg
-1- Anassimandro, 610 a.C. , scrisse l'opera : Sulla natura .
Non sono quesiti peregrini e oziosi. Vi si arrovellarono spiriti e intelletti cristiani ed europei tra i maggiori, e le relative risposte hanno formato una parte rilevante delle nostre idee religiose e morali. A quasi ottant'anni dal suo apparire nel 1933, il libro di Antonello Gerbi, Il peccato di Adamo ed Eva, ora riedito, a cura del figlio Sandro, da Adelphi, lo riconferma.
Il libro nacque nella scia del precedente studio di Gerbi sulla politica del romanticismo. Qui egli aveva notato che per un modesto scrittore libertino olandese, Adriaan Beverland, il peccato originale era consistito nella «voglia di copulare» e nell'attuarla; e che questa tesi aveva trovato eco in pensatori importanti, e perfino in Kant, influenzando il pensiero romantico, specie nelle sue «miscele di sensualità e religione». Poi Gerbi studiò anche gli sviluppi dell'«ipotesi beverlandiana» fin dagli inizi del cristianesimo, e ne nacque questo libro, in cui il concetto di colpa è visto come «quasi un nesso tra la religione e la morale», e ne è seguita la progressiva «umanizzazione».
Dopo Beverland, i significati metafisici e teologici del «peccato originale» vennero superati, affermando e giustificando il «peccato» come implicazione naturale della condizione umana, e vanificando l'idea di colpa. Le condanne di Adamo ed Eva (l'amore naturale come peccato, il lavoro come pena) e le idee connesse di male e di dolore furono ridotte a fatti di natura. Cadde la tradizione antica della miseria e infelicità della condizione umana, bisognosa, per il suo vizio d'origine, di comprensione e di perdono, di grazia e di redenzione. Emergevano integre la natura e l'esperienza terrena dell'uomo, non più condizionate dalla maledizione inflitta ai due progenitori, né dal pessimismo che da san Paolo e sant'Agostino a Pascal l'aveva sempre connotata.
Questo il giudizio di Gerbi, che vedeva, quindi, completarsi col romanticismo quella rivalutazione della condizione umana che, malgrado tutte le revisioni, resta un significato essenziale dell'umanesimo. Beverland si trasformava, da modesto (e anche osceno) scrittore su problemi più grandi di lui, nel casuale starter di una grande rivoluzione morale e culturale, acquisendo nella storia del pensiero europeo un posto tuttora ben poco riconosciuto.
È una tesi ardita, che spiega perché su di essa i recensori del libro, pur apprezzandone la dottrina e l'acume, avanzarono corpose riserve. Per Alberto Pincherle, ad esempio, la tesi del peccato originale come causa del male nell'uomo e nell'universo non c'è più nella nostra cultura; il cristianesimo aveva forzato in senso drammatico il testo biblico su quel peccato; dall'umanesimo in poi ci siamo allontanati dalle concezioni paoline e cristiane.
Queste critiche dovettero avere effetto su Gerbi, che continuò a raccogliere materiali sul suo tema, pensando di riscrivere il libro, come dimostra il figlio, che utilizza per la nuova edizione schede e note del padre riportate nel testo. In effetti, Gerbi aveva chiara la modesta statura di Beverland. «Occorre a volte (scrisse poi) uno scrittore di basso rango per sconsacrare e ravvivare un tema d'alta portata». Poco geniale, l'olandese aveva, tuttavia, diffuso «la sacrilega "ipotesi"» e l'aveva fatta circolare e agire anche «su menti e in ambienti chiusi» ad alte disquisizioni teoriche.
Il dubbio, tuttavia, sull'effettivo ruolo di Beverland resta, ma il merito del libro di Gerbi trascende questo punto. Egli individuò bene il grande problema filosofico adombrato nel mito del peccato originale. Un mito in cui emerge, a mio avviso, l'essenziale della vita e della storia: il non potere, cioè, mai riposare nelle braccia, per liete che siano, del presente, dell'ordine vigente delle cose. Una spinta incoercibile spinge ad andare oltre, in meglio o in peggio si vedrà poi. Ha un alto significato, sempre a mio avviso, che questa spinta (diabolica già nella Bibbia) sia affidata alla curiosità e all'iniziativa della irrequieta Eva contro il pigro e timorato Adamo. Forse pensava a questo Raffaele Mattioli, che, ricevuto il libro di Gerbi, gli rispondeva con un epigramma spiritosissimo: «nessun dalla testa mi leva/ che il pomo d'Adamo/ fosse il c...o di Eva». Si possono dire cose essenziali anche così, e si può indicare un sentiero importante di riflessione storica e teorica anche seguendo, come fa qui Gerbi, la pista di un modesto Beverland.
La questione è mal posta ? Il tema è interessante , alcune boutades molto meno. C'é un'altro libro : " Il peccato originale nel pensiero moderno " dove ( da una breve recensione ) : " Secondo una profonda intuizione di Lev Sestov, nella tradizione occidentale, accanto alla visione biblica del peccato originale, dove il male è il risultato di una libera scelta dell’uomo, sta la visione -1 - anassimandrea: il male è una colpa inscritta nel destino del vivente. Modelli opposti che convivono, confliggono e talvolta si intrecciano nel pensiero moderno, quando l’idea di Rivelazione inizia a essere negata o trascritta in termini di pura ragione. Di qui l’idea di una ricerca sul tema del peccato originale da Cusano a Solov’ev, affidando la redazione dei contributi sui singoli momenti e figure a storici della filosofia che fossero esperti nei diversi settori. Ad emergere è una pluralità di interpretazioni del male, della libertà dell’uomo e di Dio, che ridisegna e arricchisce il profilo della filosofia moderna, offrendo spunti di riflessione per la stessa teologia ".
Alle parole " ......ridisegna e arricchisce il profili della filosofia moderna ......" preferirei "ricolloca la filosofia al posto che le compete ".
gdg
-1- Anassimandro, 610 a.C. , scrisse l'opera : Sulla natura .
E il torero «matò» la morte prendendola per le corna
di Stenio Solinas, dal Giornale.

In Italia le corride interessano un ristrettissimo pubblico di aficionados e non vantano quarti di nobiltà intellettuale. Se si esclude Volapiè, il bellissimo saggio che Max David pubblicò da Bietti ormai quasi mezzo secolo fa, da noi non c’è nulla di paragonabile a quanto sul campo ha prodotto, per esempio, la Francia: da Montherlant a Leiris, a Jean Cau, tori e toreri fanno parte della sua cultura e non è un caso che Picasso e Dalì furono due pittori made in France e che il primo romanzo dell’americano Ernest Hemingway, Fiesta, raccontasse di un gruppo di connazionali di stanza a Parigi che andava in trasferta da Pamplona a Madrid per seguire la «temporada» delle corride. Lo scorso anno, Denis Podalydès, un attore francese molto amato in patria (la sua ultima performance è un credibilissimo Nicolas Sarkozy nel film La conquête presentato al Festival di Cannes) alla corrida ha addirittura dedicato un libro, La peur Matamore (Seuil-Archimbaud editore), riflessione sulla paura e sulla malinconia. Dice Podalydès che la corrida «piace ai grandi malinconici. Essi vedono nella luce e nel movimento nel mezzo di un circo tondo come il loro cuore rigonfio, una proiezione dei loro tormenti più nascosti, più ostinatamente fissi, una ragione al loro sragionare, l’istantanea possibilità di un transfert radicale». C’è questo senso della inutilità delle cose e dei gesti, e insieme la loro insopprimibile bellezza, la noia della vita e il brevissimo momento del suo riscatto, la paura della vita e il suo fuggirla sino a quando sei chiamato a fare i conti con la paura stessa e con la vita stessa. C’è quel senso di spettacolo funebre, di pompa e di rituale, la retorica che può essere resa sopportabile solo se al suo fondo c’è un mistero e un’esaltazione che la rendono insieme umana e divina.
C’è, infine, la consapevolezza della miseria e della grandezza umana, il suo essere appena un gradino - e però che gradino - al di sopra della pura e semplice bestialità, e insieme la fascinazione morbosa che quest’ultima emana, la stanchezza del lasciarsi andare sino ad esserne travolti. Sfidando il toro, sfidiamo ciò che di più profondo c’è in noi stessi, esorcizziamo paure e desideri atavici.
Adesso Matteo Nucci si incarica di riempire un vuoto culturale con il suo Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie, pagg. 326, euro 16,80) degna prosecuzione dell’isolato capolavoro di Max David e degno contraltare di Matadors, dello scozzese Eamonn O’Neill, uscito oltre Manica una dozzina d’anni fa. Saggio filosofo e insieme romanzo, accomuna la platonica Apologia di Socrate, quel suo «una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta», alla confessione fatta da José Tomàs, il torero più celebre della Spagna moderna, quando spiegò perché, cinque anni dopo il suo addio alle corride, non ce la facesse più a stare lontano dall’arena, dovesse, insomma, ancora e sempre, cercare qualcosa di più: «Una vita senza tori non è degna d’essere vissuta».
Nucci è un quarantenne che alla corrida è arrivato per caso, «un giovane antitaurino che alla metà degli Ottanta ancora non poteva tollerare la morte sconcia di un animale di fronte a migliaia di persone: non capivo il rito, non sapevo che il toro è un re e non sapevo nulla del sacrificio e della morte, non sapevo nulla e dovevo tenere duro. Tenni duro tutta l’estate». Poi capitolò e, visto il libro, è stata una resa incondizionata, ma per nulla cieca, bellissima. Naturalmente, non siamo di fronte a un esaltato cantore del sangue, della violenza fine a se stessa, del coraggio senza se e senza ma.
Nucci sa che cos’è la paura e sa che esiste il coraggio di avere paura, l’ammissione di non potercela fare, e il coraggio della paura, l’accettazione di quello che potrebbe avvenire. Ciò che nell’arena ti appare uno spettacolo coreografico, trasportato sul terreno diventa qualcosa di terribile e di funesto: un animale spaventoso che ti carica al galoppo, tu che lo attendi e poi con un lieve movimento della cappa, te lo fai passare di fianco. Chi ne ha avuta una fra le mani, sarà rimasto sorpreso dalla sua pesantezza e dallo sforzo fisico che il torero deve compiere per maneggiarla e agitarla come fosse un fazzoletto. Proprio perché non tutto ciò che appare è come sembra, dagli spalti vedi grazia e leggerezza, lì dove, sul campo, c’è tensione e pesantezza, una continua, sorda elettricità che si trasmette fra l’animale e l’uomo.
In Il toro non sbaglia mai, la liceità della corrida è affrontata di sbieco, essendo più materia fideistica che razionale. C’è una razza di tori, detta «tori da combattimento», che l’abolizione della corrida libererebbe dalla morte nell’arena per consegnarla a quella del macello. Quanto a uno scontro impari fra uomo e animale, perché il primo è aiutato da banderilleros e picadores a cavallo, va detto che è proprio questo aiuto a rimettere su un piano di parità un confronto altrimenti impossibile. Naturalmente, c’è tutto un coté animalistico rispettabile, ma senza stare a ironizzare più di tanto sul perché si possa tirare il collo alle galline, far vivere i maiali come tali, far gareggiare i cavalli e portare scarpe di cuoio, è il tema della morte il grande tabù, e l’uccidere come affermazione e non come necessità, il fuggire la morte come il dolore, proprio della società contemporanea, esorcizzando la prima, moltiplicando le terapie contro il secondo.
Ben costruito e ben scritto, mai noioso né inutilmente specialistico, il libro di Nucci racconta con passione e autorità un rito in cui si conserva tutta la violenza della vita. Non uno sport, ma una tragedia.
Paolo Lucarelli raccontava che Eugène Canseliet riteneva la tauromachia una rappresentazione iniziatica. Di certo , comunque, non quella alla quale faccio riferimento nell'articolo in questo sito : " Creta e il palazzo di Cnosso ".
«Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta»
gdg
C’è, infine, la consapevolezza della miseria e della grandezza umana, il suo essere appena un gradino - e però che gradino - al di sopra della pura e semplice bestialità, e insieme la fascinazione morbosa che quest’ultima emana, la stanchezza del lasciarsi andare sino ad esserne travolti. Sfidando il toro, sfidiamo ciò che di più profondo c’è in noi stessi, esorcizziamo paure e desideri atavici.
Adesso Matteo Nucci si incarica di riempire un vuoto culturale con il suo Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie, pagg. 326, euro 16,80) degna prosecuzione dell’isolato capolavoro di Max David e degno contraltare di Matadors, dello scozzese Eamonn O’Neill, uscito oltre Manica una dozzina d’anni fa. Saggio filosofo e insieme romanzo, accomuna la platonica Apologia di Socrate, quel suo «una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta», alla confessione fatta da José Tomàs, il torero più celebre della Spagna moderna, quando spiegò perché, cinque anni dopo il suo addio alle corride, non ce la facesse più a stare lontano dall’arena, dovesse, insomma, ancora e sempre, cercare qualcosa di più: «Una vita senza tori non è degna d’essere vissuta».
Nucci è un quarantenne che alla corrida è arrivato per caso, «un giovane antitaurino che alla metà degli Ottanta ancora non poteva tollerare la morte sconcia di un animale di fronte a migliaia di persone: non capivo il rito, non sapevo che il toro è un re e non sapevo nulla del sacrificio e della morte, non sapevo nulla e dovevo tenere duro. Tenni duro tutta l’estate». Poi capitolò e, visto il libro, è stata una resa incondizionata, ma per nulla cieca, bellissima. Naturalmente, non siamo di fronte a un esaltato cantore del sangue, della violenza fine a se stessa, del coraggio senza se e senza ma.
Nucci sa che cos’è la paura e sa che esiste il coraggio di avere paura, l’ammissione di non potercela fare, e il coraggio della paura, l’accettazione di quello che potrebbe avvenire. Ciò che nell’arena ti appare uno spettacolo coreografico, trasportato sul terreno diventa qualcosa di terribile e di funesto: un animale spaventoso che ti carica al galoppo, tu che lo attendi e poi con un lieve movimento della cappa, te lo fai passare di fianco. Chi ne ha avuta una fra le mani, sarà rimasto sorpreso dalla sua pesantezza e dallo sforzo fisico che il torero deve compiere per maneggiarla e agitarla come fosse un fazzoletto. Proprio perché non tutto ciò che appare è come sembra, dagli spalti vedi grazia e leggerezza, lì dove, sul campo, c’è tensione e pesantezza, una continua, sorda elettricità che si trasmette fra l’animale e l’uomo.
In Il toro non sbaglia mai, la liceità della corrida è affrontata di sbieco, essendo più materia fideistica che razionale. C’è una razza di tori, detta «tori da combattimento», che l’abolizione della corrida libererebbe dalla morte nell’arena per consegnarla a quella del macello. Quanto a uno scontro impari fra uomo e animale, perché il primo è aiutato da banderilleros e picadores a cavallo, va detto che è proprio questo aiuto a rimettere su un piano di parità un confronto altrimenti impossibile. Naturalmente, c’è tutto un coté animalistico rispettabile, ma senza stare a ironizzare più di tanto sul perché si possa tirare il collo alle galline, far vivere i maiali come tali, far gareggiare i cavalli e portare scarpe di cuoio, è il tema della morte il grande tabù, e l’uccidere come affermazione e non come necessità, il fuggire la morte come il dolore, proprio della società contemporanea, esorcizzando la prima, moltiplicando le terapie contro il secondo.
Ben costruito e ben scritto, mai noioso né inutilmente specialistico, il libro di Nucci racconta con passione e autorità un rito in cui si conserva tutta la violenza della vita. Non uno sport, ma una tragedia.
Paolo Lucarelli raccontava che Eugène Canseliet riteneva la tauromachia una rappresentazione iniziatica. Di certo , comunque, non quella alla quale faccio riferimento nell'articolo in questo sito : " Creta e il palazzo di Cnosso ".
«Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta»
gdg
VERSO L'ARCA D'ARGENTO.
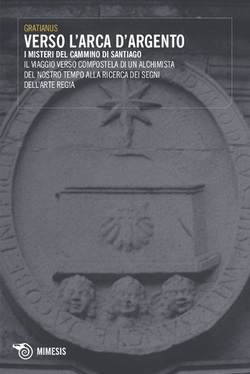
Gratianus, Verso l'arca d'argento, I misteri del Cammino di Santiago. Il viaggio verso Compostella di un alchimista del nostro tempo alla ricerca dei segni dell’Arte Regia.
Difficile commentare questo libro per chi conosce l'autore. Difficile perchè sono rimasto sorpreso conoscendo una buona parte delle attività di ricerca " filosofica "di Gratianus. Gratianus non chiama in causa nè Fulcanelli, nè Canseliet nè Lucarelli: ciò che egli propone è tutta farina del suo sacco. Lo studio della simbolica dell'Arte Sacra ha una sua originalità indiscutibile ( in questo sito una paginetta è dedicata a Santiago di Compostella ) e non condivisibile per quanto mi riguarda. Gratianus percorre a piedi l'intero tratto fra Saint Jean Pied de Port e Santiago de Compostela con coraggio e grande tenacia , sostando negli ostelli spesso affollati di pellegrini. Una prova eroica che gli va riconosciuta.
Difficile commentare questo libro per chi conosce l'autore. Difficile perchè sono rimasto sorpreso conoscendo una buona parte delle attività di ricerca " filosofica "di Gratianus. Gratianus non chiama in causa nè Fulcanelli, nè Canseliet nè Lucarelli: ciò che egli propone è tutta farina del suo sacco. Lo studio della simbolica dell'Arte Sacra ha una sua originalità indiscutibile ( in questo sito una paginetta è dedicata a Santiago di Compostella ) e non condivisibile per quanto mi riguarda. Gratianus percorre a piedi l'intero tratto fra Saint Jean Pied de Port e Santiago de Compostela con coraggio e grande tenacia , sostando negli ostelli spesso affollati di pellegrini. Una prova eroica che gli va riconosciuta.
Un re orso e a volte corvo.
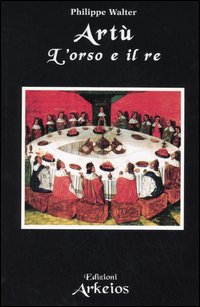
Lo studio delle varie leggende concernenti il ciclo di re Artù e del mondo cavalleresco ha ricevuto negli ultimi anni una notevole estensione, dovuta anche ad una serie fortunata di films che hanno riproposto al grande pubblico un insieme di narrazioni prima destinate solamente agli specialisti e ad una ristretta cerchia di lettori “affascinata” dal mondo della cavalleria. Tuttavia, i personaggi più importanti e rilevanti del ciclo, come Artù e il mago Merlino, restavano sostanzialmente confinati in un alone di leggenda che rendeva difficile la comprensione della dimensione simbolica da essi coperta. Su Merlino, poi, i libri di interesse serio e di buona dottrina si possono contare sulle dita di una mano e non sono mancati anche in questo caso tentativi dilettanteschi di trasformare questo personaggio sconcertante delle leggende medievali, in una personalità molto vicina alle attese fantasiose del grande pubblico odierno. Ma è il re Artù che ha affascinato generazioni di studiosi e di dilettanti, sempre pronti a farlo uscire dalle nebbie del puro racconto leggendario e capaci di addentrarsi in ipotesi sconcertanti che, come alcune fra le più recenti, ne hanno fatto avventurosamente un eroe scaturito dalle leggende dei popoli delle steppe che dalle nebbie delle terre eurasiatiche ha potuto finalmente approdare in Britannia dopo millenni di vicissitudini. Ci sono stati persino alcuni volenterosi che hanno sottoposto le testimonianze in nostro possesso ad una serrata indagine per provare la realtà storica del personaggio, in questo caso diventato un eroe della resistenza bretone contro i tanti invasori succedutisi nell’isola del Nord. Queste sono solo alcune delle infinite ipotesi fatte per cercare di dare consistenza ad un personaggio che in vario modo e secondo modalità diverse, ha contribuito a formare il modo di vivere di generazioni di nobili e aristocratici medievali che intendevano identificarsi con qualcuno dei tanti cavalieri del seguito di Artù.
È merito di Philippe Walter avere ripreso il dossier concernente questa straordinaria figura di sovrano, avere riesaminato tutte le testimonianze e tentare di delinearne i contorni ad un tempo mitici e simbolici. Walter non è un avventuroso dilettante come se ne trovano ovunque. Prima di affrontare il personaggio di Artù ha studiato il mondo cortese e la letteratura d’oil scrivendo due libri su Chrétien de Troyes e sul complesso mondo letterario nel quale affondano le proprie radici le tante opere dello scrittore dello Champagne. Ha esaminato poi alcuni simboli di quel ciclo narrativo evidenziando l’importanza del corvo e di animali “solari” che spesso emergono da un passato antichissimo. Lo stesso suo studio sul mago Merlino è andato molto oltre i limiti accademici che per es. mostra il saggio di Paul Zumthor, e si è soffermato invece sulla dimensione “sapienziale” di questo straordinario personaggio e sugli aspetti sacrali che traspaiono in molte delle sue azioni. Ultimamente ha analizzato la figura di Galaad e i suoi rapporti con il Graal soffermandosi su aspetti del simbolismo e sull’ambientazione sacra che illuminano molti forme narrative del ciclo in questione. Come si vede, si tratta di uno studioso che da anni conosce la materia e che non indugia sulle mode del momento per ottenere un facile riconoscimento alle eventuali ambizioni.
Raffigurazione di Artù. Particolare. Basilica di Otranto
In questo suo libro Philippe Walter ha il merito di aver analizzato tutto ciò che è stato scritto su Re Artù e sulla Tavola Rotonda tentando un’interpretazione non limitata ai soliti aspetti letterari e narrativi. Ha cercato di penetrare in profondità analizzando il significato di questo personaggio, i simboli che lo concernono, le sue modalità di azione, il tipo di regalità che egli ha incarnato, il rapporto che le leggende stabiliscono con tutta una serie di situazioni e di miti che aiutano a decifrare simboli molto antichi, alcuni addirittura senz’altro precedenti lo stesso mondo celtico. È evidente che un simile metodo di indagine, ricco di riferimenti alle più attente delle recenti metodologie, fa giustizia di interpretazioni al limite della sopportabilità culturale come quelle che caratterizzano certi recenti autori francesi troppo legati al folklore delle loro regioni, nei quali la fantasia spesso prende la mano e si dispiega in personalissime interpretazioni che trasformano i dati folkloristici in quelli che a loro appaiono come strumenti inoppugnabili di indagine culturale.
Walter è molto prudente, non si abbandona ad ipotesi azzardate, saggia la consistenza del materiale giunto fino a noi, lo compara con quello che emerge in altre aree culturali affini, analizza simboli arcaici, in qualche caso risale fino a rituali preistorici, verifica la consistenza del retroterra celtico che alcuni racconti hanno perpetuato. Ne emerge uno studio che dà consistenza al significato simbolico della figura di Artù e le sue attribuzioni diventano mezzi per delimitarne le competenze. Si scopre così il valore dell’orso-Artù e del corvo-Artù, simboli della forza guerriera e in molti casi dell’autorità sovrana dell’eroe; acquistano spessore quei miti che lo riconducono ad un “luogo santo” posto al centro del mondo, là dove si trova un’enigmatica isola che “ruota su se stessa” eternamente irradiata dalla Grazia divina. Lo studio di Walter, senza mai nominarle, toglie consistenza oggettiva alle tesi avanzate recentemente da C.S.Littleton e L.A.Malcor, relative ad un Artù emerso dalle steppe, dalla Scozia a Camelot, come recita il loro libro. Gli eventuali punti di rassomiglianza non sono altro che le caratteristiche di chi combatte a cavallo e ne è necessariamente condizionato nelle forme di combattimento, nel tipo di armatura e nello stesso rapporto con l’animale.
Analizzando poi il tipo di temporalità che ritma le storie e la vita di Artù, Walter scopre che ci troviamo davanti ad una condizione originaria: il tempo di Artù e delle sue gesta non è quello dello scorrimento o del quotidiano, non delimita una “storia”, ma riconduce ad una dimensione nella quale i simboli della “ruota solare” e del “centro del mondo” rivelano uno stadio di felicità perfetta, l’illud tempus delle origini, quando lo scorrimento sembrava essersi fermato, una primordiale montagna edenica dal quale il “Re Orso”, come certi guerrieri-veggenti dell’India tradizionale, è fuoruscito e nela quale, dopo un duello che lo renderà gravemente infermo, il re dovrà essere “riassorbito” in attesa che tempi propizi permettano il suo “ritorno” nel mondo del divenire per condurre la sua ultima battaglia contro le forze del male.
Philippe Walter ha dato gli elementi essenziali per capire il complesso mondo e le leggende che hanno ascoltato generazioni di cavalieri e di nobili.
Nuccio d'Anna
* * *
È merito di Philippe Walter avere ripreso il dossier concernente questa straordinaria figura di sovrano, avere riesaminato tutte le testimonianze e tentare di delinearne i contorni ad un tempo mitici e simbolici. Walter non è un avventuroso dilettante come se ne trovano ovunque. Prima di affrontare il personaggio di Artù ha studiato il mondo cortese e la letteratura d’oil scrivendo due libri su Chrétien de Troyes e sul complesso mondo letterario nel quale affondano le proprie radici le tante opere dello scrittore dello Champagne. Ha esaminato poi alcuni simboli di quel ciclo narrativo evidenziando l’importanza del corvo e di animali “solari” che spesso emergono da un passato antichissimo. Lo stesso suo studio sul mago Merlino è andato molto oltre i limiti accademici che per es. mostra il saggio di Paul Zumthor, e si è soffermato invece sulla dimensione “sapienziale” di questo straordinario personaggio e sugli aspetti sacrali che traspaiono in molte delle sue azioni. Ultimamente ha analizzato la figura di Galaad e i suoi rapporti con il Graal soffermandosi su aspetti del simbolismo e sull’ambientazione sacra che illuminano molti forme narrative del ciclo in questione. Come si vede, si tratta di uno studioso che da anni conosce la materia e che non indugia sulle mode del momento per ottenere un facile riconoscimento alle eventuali ambizioni.
Raffigurazione di Artù. Particolare. Basilica di Otranto
In questo suo libro Philippe Walter ha il merito di aver analizzato tutto ciò che è stato scritto su Re Artù e sulla Tavola Rotonda tentando un’interpretazione non limitata ai soliti aspetti letterari e narrativi. Ha cercato di penetrare in profondità analizzando il significato di questo personaggio, i simboli che lo concernono, le sue modalità di azione, il tipo di regalità che egli ha incarnato, il rapporto che le leggende stabiliscono con tutta una serie di situazioni e di miti che aiutano a decifrare simboli molto antichi, alcuni addirittura senz’altro precedenti lo stesso mondo celtico. È evidente che un simile metodo di indagine, ricco di riferimenti alle più attente delle recenti metodologie, fa giustizia di interpretazioni al limite della sopportabilità culturale come quelle che caratterizzano certi recenti autori francesi troppo legati al folklore delle loro regioni, nei quali la fantasia spesso prende la mano e si dispiega in personalissime interpretazioni che trasformano i dati folkloristici in quelli che a loro appaiono come strumenti inoppugnabili di indagine culturale.
Walter è molto prudente, non si abbandona ad ipotesi azzardate, saggia la consistenza del materiale giunto fino a noi, lo compara con quello che emerge in altre aree culturali affini, analizza simboli arcaici, in qualche caso risale fino a rituali preistorici, verifica la consistenza del retroterra celtico che alcuni racconti hanno perpetuato. Ne emerge uno studio che dà consistenza al significato simbolico della figura di Artù e le sue attribuzioni diventano mezzi per delimitarne le competenze. Si scopre così il valore dell’orso-Artù e del corvo-Artù, simboli della forza guerriera e in molti casi dell’autorità sovrana dell’eroe; acquistano spessore quei miti che lo riconducono ad un “luogo santo” posto al centro del mondo, là dove si trova un’enigmatica isola che “ruota su se stessa” eternamente irradiata dalla Grazia divina. Lo studio di Walter, senza mai nominarle, toglie consistenza oggettiva alle tesi avanzate recentemente da C.S.Littleton e L.A.Malcor, relative ad un Artù emerso dalle steppe, dalla Scozia a Camelot, come recita il loro libro. Gli eventuali punti di rassomiglianza non sono altro che le caratteristiche di chi combatte a cavallo e ne è necessariamente condizionato nelle forme di combattimento, nel tipo di armatura e nello stesso rapporto con l’animale.
Analizzando poi il tipo di temporalità che ritma le storie e la vita di Artù, Walter scopre che ci troviamo davanti ad una condizione originaria: il tempo di Artù e delle sue gesta non è quello dello scorrimento o del quotidiano, non delimita una “storia”, ma riconduce ad una dimensione nella quale i simboli della “ruota solare” e del “centro del mondo” rivelano uno stadio di felicità perfetta, l’illud tempus delle origini, quando lo scorrimento sembrava essersi fermato, una primordiale montagna edenica dal quale il “Re Orso”, come certi guerrieri-veggenti dell’India tradizionale, è fuoruscito e nela quale, dopo un duello che lo renderà gravemente infermo, il re dovrà essere “riassorbito” in attesa che tempi propizi permettano il suo “ritorno” nel mondo del divenire per condurre la sua ultima battaglia contro le forze del male.
Philippe Walter ha dato gli elementi essenziali per capire il complesso mondo e le leggende che hanno ascoltato generazioni di cavalieri e di nobili.
Nuccio d'Anna
* * *
Da Orfeo a Pitagora di Claudio Landi.

Premessa di Lorenzo Barberis:
"Il mito di Orfeo rappresenta il più potente archetipo della poesia e del Poeta nella letteratura occidentale, e pertanto il suo studio è di particolare interesse. Cantore divino, in grado di ammansire le belve feroci, Orfeo usa questa sua capacità per recuperare l'amata Euridice dopo la sua morte prematura; egli ottiene il suo ritorno al mondo dei vivi, ma dovrà essere lui a guidarla, senza voltarsi indietro. Egli fallisce in questo compito e, impazzito per la definitiva perdita, sprezza le Menadi, che quindi lo decapitano. Ma la sua testa continua a cantare il nome di Euridice. Vediamo così fusi inscindibilmente nella figura del poeta: il poeta come mago, il poeta come innamorato, il poeta come folle (tutti strettamente interconnessi: il poeta è folle per amore, e questa follia è ciò che lo spinge a varcare la soglia degli inferi). I classici esaltarono di Orfeo soprattutto la sua dimensione di poeta-mago, come è evidente da questo mosaico romano del I secolo; la setta orfica, sorta in Grecia verso il VII secolo a.C., si ispirava ai suoi mitici insegnamenti per apprendere l'arte della metempsicosi.
La figura di Orfeo sopravvisse nel cristianesimo delle origini, dove divenne una metafora di Cristo.Il parallelismo era del resto piuttosto evidente: come Orfeo scende agli inferi per salvare l'anima dell'amata Euridice, così fa Cristo per salvare l'anima dei suoi fedeli, sia pure con ben diverso successo.Questa funzione di Orfeo come metafora di Cristo ne favorì la sopravvivenza medioevale: il serpente che morde Euridice a un tallone diviene allegoria di Satana,e quindi viene effigiato nell'aspetto di un orrendo dragone ."
Molti aspetti della disciplina e della metafisica pitagoriche, così come riportate dagli allievi diretti o indiretti della scuola di Crotone quali forse si consideravano i neoplatonici Proclo e Giamblico, traggono vita e ispirazione dalle preesistenti filosofie e religiosità d’ordine orfico. In questo testo si dimostrano efficacemente tali tesi sulla base di un vastissimo apparato documentale e presentando alcune conclusioni del tutto originali o, comunque, scarsamente analizzate in Italia.
Orfeo circondato dagli animali. Mosaico pavimentale romano, da Palermo. Museo archeologico regionale di Palermo.
La religiosità misterica nella Magna Grecia è intimamente connessa alla presenza di un vasto corredo di culti iniziatici. Queste forme di religiosità sono a volte osmotiche ed altre volte contrastanti con la stabile cosmologia olimpica. I rappresentanti dei culti misterici hanno avuto, nel passato come fino ai nostri giorni, esponenti credibili e “imbonitori” a vario titolo, messi in ridicolo molto spesso dai rappresentanti di una cultura ufficiale. I famosi e misteriosi “goeti”, ad esempio, (purificatori e guaritori) collegati a culti molto remoti, sembrano evocare fortemente l’idea di uno sciamanesimo primordiale comune a tutta l’area pan-ellenica. Questi esseri, a metà strada fra il mago e il sacerdote, vantavano spesso filiazioni divine ed esiste tutta una cosmogonia primordiale che ne giustifica le potenzialità misteriche e salvifiche. Basti pensare ai culti relativi ai Dattili Idei (i “forgiatori”, gli esperti nell’arte del metallo) che, secondo alcuni sono alla origine dell’istruzione dello stesso Orfeo.
Nel testo di Nuccio D’Anna si fa grande attenzione alla divisione fra diverse cultualità, cercando di evitare i riduzionismi che portano a vedere qualsiasi misteriosofia primordiale presente nell’Ellade come riferentesi esclusivamente alla Demetra eleusina. Ed è proprio in tale contesto che viene testimoniata una fitta presenza di asceti vaganti di tradizione orfico-apollinea, (alcuni inseribili forse in vere e proprie confraternite, altri con un modus operandi assolutamente eremitico) che guarivano, consigliavano, purificavano città e persone, traevano responsi, ma soprattutto mantenevano la loro ascesi e il loro isolamento dal mondo, vagando da una parte all’altra della Grecia e delle regioni limitrofe.
In questo volume viene più volte citato il papiro di Derveni (vicino all’attuale Salonicco), scoperto nel 1962, contenente un particolare testo orfico da cui è possibile trarre una cosmogonia assai diversa da quella classica. Assai interessanti risultano le numerose considerazioni semiologiche sul significato del nome di Orfeo (dal “solitario”, all’”orfano”) ad indicare una condizione di tipo misteriosofico, propria dell’essere chiamato con questo nome; in questa chiave diventa illuminante l’excursus filosofico e semiologico che D’Anna propone fino ad arrivare ai “bukoloi” così importanti nella tradizione augustea attraverso i versi di Virgilio. In tale contesto i miti che narrano la fine di Orfeo narrati da Eschilo e ripresi più tardi da Virgilio e Ovidio parlano di una tradizione in cui il suono creatore espresso dal canto di Orfeo permane benefico e illuminante, nonostante provenga dalla sua testa mozzata che transitando dal fiume Ebro “feconda” il mondo con la sua parola divina.
Anche l’universale simbolismo dell’uovo assume nell’orfismo una funzione particolare connessa al “tempo” e alle numerose cosmogenesi orfiche; ed è interessante ricordare come lo stesso Aristotele parli del “vento” cosmico come attributo caratterizzante dell’uovo orfico. Questo uovo ritorna nel più volte citato papiro di Derveni richiamando la luce ierofanica e il concetto stesso di “Phanes”, al centro della figura circolare perfetta, il grande sole di un “tempo anteriore al tempo”.
Non si può prescindere, in questa analisi da un confronto e uno scambio fra dottrine orfiche e dionisiache. Il testo ne pone in evidenza assai più i contatti e le osmosi filosofiche e religiose piuttosto che i contrasti; pone inoltre in luce il progressivo passaggio da una “normale” civiltà di re-sacerdoti, ad una in cui la misteriosofia orfico-iniziatica diventa l’unico mezzo realizzativo e reintegrativo. A tale proposito vengono richiamati il Cratilo, il Fedone e le Leggi di Platone, e mostrato come la ripresa, da parte del grande filosofo, di una dottrina orfica influenzi poi tutta la storia della filosofia occidentale. Parliamo di quella dottrina relativa al corpo come “tomba dell’anima” dove il percorso del myste è teso a svincolarsi da tale prigione e presentarsi come essere rinnovato spiritualmente e sciolto da tale legame.
Partendo dall’analisi delle cosmogonie più arcaiche e dal primordiale smembramento del fanciullo-Dioniso, viene inoltre mostrata la funzione della contrapposizione fra i Cureti (i famosi guerrieri danzanti “scelti” da Giove per il mantenimento del ritmo celeste) e i sette Titani (antichi signori “decaduti”, testimoni di un precedente ordine sacro), nell’aspetto più “sciamanico” del mito dionisiaco. Acquistano perciò un particolare valore entrambe le versioni della fine del dio: quella relativa alla dispersione delle membra e quella relativa alla loro “bollitura”, in parallelo al mito orfico che si avvale di una analoga dispersione delle parti del corpo. Troviamo inoltre numerose varianti sulla fine del cuore del dio. Per alcuni viene posto sul tripode di Delfi, per altri sarà sepolto a Libetra, ai piedi dell’Olimpo, custodito dalle Muse. Anche i giocattoli del dio (la palla, l’astragalo, il rombo, lo specchio, la trottola, le “marionette”, ecc.) assumono nuovi significati soprattutto alla luce di alcuni recenti ritrovamenti a Fayyum (Papiro di Gurob del II sec. a.C.), dove appare chiaro come l’azione dei Titani sia tesa a sconvolgere l’ordine creato da Zeus, dileggiando quei simboli dell’ordine celeste.
Assai interessante è l’analisi che questo testo propone sugli ambienti dei medici traci della scuola di Zalmoxis, che sembrano precedere la diffusione dell’Orfismo e che, ben lontani dalla medicina ippocratica, proponevano una terapia che congiungeva sempre la purificazione del corpo a quella dell’anima, in una continua osmosi tra magia e ritualismi di tipo estatico.
Fondamentale, a questo proposito, è la funzione iniziatica di Mnemosyne, i cui significati si estendono a coprire le ragioni stesse del percorso post mortem, e costituiscono contemporaneamente la vera e propria chiave di volta del passaggio salvifico del myste. Appoggiandosi su un esteso apparato documentale, D’Anna ci conduce a considerare la funzione “fisiologica” della fonte fredda, Mnemosyne, la fonte della memoria, ponendo in evidenza i passi di vari autori in cui il respiro diventa una tecnica per “espiare le antiche colpe” e per liberare l’anima “rinfrescandola”. A tal proposito è importante sia la citazione di Aristotele (De Anima) che alcune espressioni del più volte citato Papiro di Derveni che conservano, con buona probabilità, memoria dell’esistenza di concezioni collegate alla funzione liberatoria delle tecniche del respiro. Altrettanto importante risulta l’analisi che viene fatta sul significato del soffio e dello pneuma. Sia nella Grecia orfica come più tardi nella Magna Grecia pitagorica esisteva indubbiamente un uso del respiro quale supporto della meditazione, dell’ascesi e della guarigione secondo modalità assai simili a quanto proposto nelle dottrine estremo orientali.
A partire dalla metà del testo, si iniziano ad analizzare alcuni dei principali aspetti delle dottrine ascetiche dell’orfismo (dall’astensione dai cibi animali alla metempsicosi, dottrina in realtà completamente estranea alla religiosità olimpica).
Il passaggio dall’orfismo al pitagorismo viene preceduto da una disamina cosmologica e da un inevitabile confronto con le dottrine orientali, ponendo innanzitutto in evidenza come, sei secoli prima di Cristo, in tutto il mondo siano sorti personaggi e “scuole” che”riordinano” le antiche leggi, ripristinano e sistematizzano i riti, secondo uno schema straordinariamente vasto (vengono ricordati i miti e le tracce storiche relative a Numa, Confucio, Lao Tzu, Zaratustra, ecc.).
In Grecia dopo il tempo mitico di Dioniso, di Orfeo e, a latere, dello stesso Pitagora, arriveranno il monismo di Parmenide e la speculazione di Eraclito, particolarmente vicina, quest’ultima, all’orfismo e ad una dimensione filosofica polivalente. Ciò provocò sia a lui come a Pitagora, accuse pesanti di sviluppare l’”arte dell’inganno” (Diogene Laerzio). Ma, nello stesso tempo, la politica aristocratica alla quale si rifaceva Pitagora accentuò le critiche di Eraclito assai legato agli arcaici principi dei re-maghi dei tempi mitici delle poleis greche, in cui il “contatto” diretto ed estatico con la natura divina non transitava attraverso metodologie o filosofie ascetico-iniziatiche.
L’insegnamento di Pitagora ha creato comunque una ventata straordinaria in tutto il mondo classico. Le “vite”, oltre a descrivere i suoi innumerevoli viaggi corrispondenti ad un numero inimmaginabile di iniziazioni ricevute, ne proclamano le origini orfico-apollinee e in alcuni casi operano una vera e propria deificazione. Nel testo di Nuccio D’Anna si riassumono efficacemente le principali “dinastie” ipotizzate dagli agiografi e si giunge ad un denominatore comune in cui il rapporto Orfeo-Pitagora appare in tutta la sua straordinaria potenza spirituale. Ci si sofferma a lungo su quel coacervo di maestri-maghi-shamani di cui abbiamo accennato all’inizio e che gli allievi della scuola crotoniate spesso proposero come suoi insegnanti, altre volte come suoi allievi (dallo straordinario Ferecide, autore di una delle più straordinarie cosmogonie, al misterioso Aglaophamos).
Negli studi sull’orfismo-pitagorismo non sono separabili l’aspetto filosofico da quello mistico-religioso. E’ questo forse l’alveo più completo nel quale il termine “scienza sacra” trova giusta collocazione. Caratteristica del pitagorismo è la differenziazione gerarchica dei vari gradi sapienziali, tutti compresi in quella sacralità iniziatica in cui non è divisibile il sacerdote dal sapiente, dall’uomo di autentica scienza. A suffragio di tale tesi è determinante il brano di Porfirio in cui si parla della iniziazione che Pitagora riceve a a Creta, nell’antro Ideo, da parte di Morgo. In tale brano si evocano riti arcaici che sicuramente erano patrimonio dell’Ellade primordiale e soprattutto si pone in evidenza come, all’origine dei culti orfici e pitagorici ci fossero i misteriosi “Dattili Idei” che attraverso una “pietra di fulmine” o “pietra celeste” purificano l’iniziando. I misteri di Morgo, di cui parla Porfirio con grande lucidità, dovevano essere pervenuti in qualche modo fino a lui attraverso una stabile “catena iniziatica”, e una cosa che appare subito straordinaria è la somiglianza di determinate liturgie arcaiche con altre ritrovabili nelle cultualità primordiali di altre tradizioni. Il testo si sofferma poi lungamente sulle “prescrizioni” formali, sui “comportamenti” pitagorici e sulla loro formulazione attraverso i symbola che ne occultano il senso, spesso dietro una apparente semplicità etica.
Viene quindi specificamente riesaminato il simbolismo di Mnemosyne in una chiave eminentemente pitagorica, ricordando la funzione che Diogene Laerzio (il quale rinvia a sua volta ad un testo perduto di Polyistore) fa assumere alla dottrina del sangue, come veicolo animico, e a quella del “soffio” o respiro, come elemento vivificatore e animatore del sangue stesso. Approfondendo tale teoria si scopre un utilizzo del “pneuma freddo” che secondo Filolao, stabilisce la salute (Ygheia), e l’equilibrio del ciclo vitale in tutte le sue valenze materiali e spirituali. Il fatto che Alessandro Polyistore richiami una tal dottrina, in cui l’anima acquista forza e si riposa su se stessa, e in cui i “ragionamenti” sono considerati “soffi” dell’anima, richiama tutta una serie di termini, spesso affrettatamente tradotti in passato, che ipotizzano un’articolata metodologia realizzativa basata anche sulle tecniche del respiro e sul “refrigerio dell’anima” soccorsa da tale respiro “fresco” a causa di Mnemosyne. Suggerisce inoltre D’Anna, appoggiandosi a Louis Gernet e Jean-Pierre Vernant, che l’espressione “prapìdes” invece dell’usuale e accademico “potenza del suo spirito” ha il significato di “diaframma”. E quindi, richiamando altri testi che sicuramente incuriosiranno il lettore, si giunge a formulare una struttura operativa metodologico-pratica, vicina a quelle tecniche rituali richiamate dagli Yoga-sutra e dagli altri testi fondamentali della cultura del lontano Oriente.
Il saggio di Nuccio D’Anna termina con un capitolo dedicato alla sapienza numerica dei pitagorici. Si passa dal senso della geometria all’uso del numero quali strordinari mezzi di rappresentazione e veicoli di conoscenza della dimensione cosmica. L’ascolto dell’armonia delle sfere era un modo per penetrare nel mistero della creazione diventandone parte attiva e riversando l’armonia percepita in ogni atto celebrato sulla terra. Un tema su cui riflettere.
D'Anna è l'autore di due libri interessanti: Il Divino nell'Ellade e Il Gioco Cosmico.
George Aurach: Le Jardin de Richesses . Testo calligrafato.
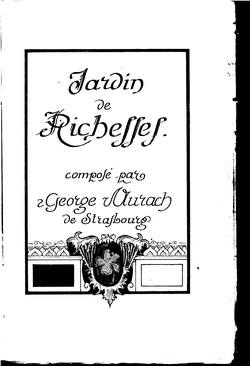
Il testo è stato calligrafato da Bernard Biebel e l'editore è Arma Artis. La bella scrittura era così cara a Eugéne Canseliet che gli fece pubblicare in elegante grafia I Tre Antichi Trattati di Alchimia . La bella, calma scrittura che nelle lunghe notti davanti al forno riempiva i lunghi intervalli in attesa che la temperatura giungesse al suo culmine . Biebel vede nel preziosissimo giardino una violetta di cui alla figura, dal particolari colori: nero e bianco-giallastro che a suo tempo lessi come giovane astro ( in francese jaunatre ).
gdg
gdg
" Il cristianesimo celtico.I pellegrini della luce."
Libro e l'introduzione che segue di Nuccio D'Anna.

Durante la sua bimillenaria storia il Cristianesimo ha sempre mostrato un’attenzione speciale per la dimensione più elevata della vita spirituale e a questo fine nel corso dei secoli ha presentato aspetti molto vari che secondo modalità diverse hanno teso ad avviare gli asceti verso l’esperienza di quella che può essere agevolmente definita, semplificando, la visione di Dio. Non si è trattato di un fenomeno uniforme ed omogeneo, ma di modalità ascetiche a volte diversissime fra loro, di forme non sempre comparabili anche se, ovviamente, il richiamo agli stessi fondamenti evangelici ne fa aspetti di un’unica, grandiosa realtà ecclesiale. Accanto ai notissimi monaci della Tebaide, agli eremiti della Siria, ai tanti solitari che a Lérins o nei cenobi scaturiti dall'insegnamento di Cassiano intendevano seguire il dettato evangelico “Lascia tutto e seguimi !”, fra il IV e il VII secolo in Irlanda si è dato origine ad un monachesimo che ha costituito uno dei fenomeni più complessi e ricchi fra quanti ne sono fioriti nel continente. Non si è trattato di un evento trascurabile o circoscritto ad una realtà geografica limitata, ma di una presenza massiccia che in breve tempo ha raggiunto molta parte delle regioni europee, ha alimentato gli ambiti dottrinali più diversi e ha sostanziato la contemplazione, la cultura, l’arte, la miniatura, l’oreficeria, i monumenti, i simboli e le forme sacramentali che hanno costituito la base di una ricchissima vita spirituale. Il monachesimo organizzatosi nelle isole del Nord del continente ha avuto una sua specificità che lo ha reso completamente diverso rispetto a quanto conosciamo dei monasteri benedettini, qui arrivati proprio quando quelli di rito celtico cominciavano a perdere la loro forza propulsiva e tendevano ad essere assorbiti nelle fondazioni “latine”. Non solo le diverse, asprissime forme di austerità, ma la stessa loro considerazione sul significato della vita sacramentale scaturiva da una particolare condizione che faceva percepire il cosmo e i ritmi temporali come una continua teofania che il monaco doveva, semplicemente, contemplare come il riflesso della “presenza” di Dio.
Lo studio della spiritualità cristiano-celtica ha conosciuto negli ultimi anni un'attenzione e un'estensione che ha toccato aspetti vari di quell’antica struttura ecclesiale e per la prima volta non si è limitata alla stretta cerchia élitaria degli specialisti anglo-irlandesi. Si è trattato di una vera e propria riscoperta di un mondo fin qui analizzato in modo limitato che però alcuni autori hanno condotto avventurosamente, senza una conoscenza adeguata dei valori specifici di quella realtà, in certi casi addirittura presumendo di trovare impossibili rispondenze con fantasiosi cicli mitologici. Nei moltissimi manuali che studiano il Cristianesimo dei primi secoli, nonostante la grande diffusione e la capillare presenza in ogni ambito della vita sociale, il monachesimo celtico viene spesso considerato un fenomeno “quasi spontaneo”, non paragonabile in nessun modo a quanto si è sviluppato altrove. Si è voluto sostenere che tale importante fenomeno possa essere considerato solo una specie di intermezzo provvisorio che avrebbe fatto seguito alle numerose comunità eremitiche fiorite nel sud della Gallia e nelle isole tirreniche, un'esperienza ritenuta funzionale al successivo arrivo dei Benedettini che con la loro Regola molto articolata, organizzata, più attenta alle necessità di una vita comunitaria e con i loro ricchi monasteri, sarebbero stati gli autentici iniziatori della civiltà conventuale fiorita in tutta Europa. E tuttavia, questa specie di convinzione acritica seguita dagli studiosi del mondo alto-medievale e continuatasi fino ai nostri giorni senza eccessive smentite, non solo non corrisponde affatto alla realtà, ma sostanzialmente ignora la peculiarità dell’esperienza mistica dei monaci e dei contemplativi celtici e, da un punto di vista strettamente erudito, sembra persino trascurare la pur copiosa letteratura critica fiorita in Irlanda e in Gran Bretagna.
Per meglio evidenziare le profonde diversità che distinguono i monaci di rito celtico da tutte le altre forme contemplative emerse nella storia del Cristianesimo, nel corso del libro ci siamo soffermati solo quando era strettamente necessario sulla struttura amministrativa, sulle specificità organizzative o sulla storia episcopale delle isole del Nord, e abbiamo preferito approfondire le particolarità liturgiche, i tipi di preghiera e le modalità “tecnico-realizzative” che hanno sostanziato le chiese celtiche, quelle che sembrano differire sotto moltissimi punti di vista dalla più conosciuta vita ascetica dei Benedettini. È il sostrato mistico-contemplativo nel quale si muovevano questi solitari asceti, e molto meno la storia ecclesiale, a mostrare la loro peculiarità. I monaci celtici che fra il IV e il VII secolo peregrinavano senza sosta nel mondo insulare del Nord non sono stati grandi protagonisti nel campo dottrinale e, pur saldamente ancorati alla “mistica della Luce” del Vangelo di san Giovanni, non hanno elaborato sistemi speculativi in grado di costituire il fondamento di scuole o comunità di studi teologici come quelle che poi fioriranno sul continente. D’altronde, lo stesso maldestro tentativo fatto da alcuni nostalgici del folklore druidico di ricondurre le dottrine di un eretico come Pelagio alla spiritualità degli asceti irlandesi e scozzesi è solo il frutto di una povertà interpretativa che mostra, fra l'altro, di non conoscere affatto le concrete radici dalle quali ha preso consistenza il pelagianesimo, la sua negazione del significato ontologico del peccato o la riduzione della preghiera e della stessa vita sacramentale ad una vuota vestigia priva di ogni portata “realizzativa”, tutte cose che avrebbero fatto inorridire qualsiasi monaco del tempo dello splendore dell’”isola santa” di Iona.
In realtà, l’attenzione di questi asceti del Nord era rivolta alla conversione del mondo e i loro ritmi di vita si modulavano essenzialmente sulla purificazione dell'anima, sulla mistica, sulla contemplazione, sull’imitatio Christi. Le loro forme sacramentali, le preghiere così singolari, la salmodia onnipervadente, i rigidi penitenziali e i canti ci conducono verso una realtà arcaica, rocciosa, spesso aspra; parlano di un mondo lontano, irraggiungibile, silenzioso, quasi incomprensibile per dei moderni. Tutto un ordinamento liturgico e “tecnico-realizzativo” fra i più complessi svela un modo diversissimo di affrontare i temi sacramentali e quelli che si è abituati ad elencare all'interno dell’ampia e variegata area della mistica. Da questi lontani monasteri emerge una quantità di pratiche ascetiche, di dure austerità, di invocazioni, di lodi, di inni, di regole e strutture organizzative che appaiono estremamente differenti rispetto a quanto si è abituati a vedere in altre aree del continente. La stessa singolare organizzazione ad un tempo cenobitica, eremitica ed “itinerante” del loro monachesimo ha permesso che affiorassero quelle straordinarie figure di asceti e di instancabili peregrini Dei conosciuti come Culdei, una comunità di misteriosi contemplativi le cui caratteristiche di fondo non sono certo assimilabili ad altre esperienze conventuali e probabilmente costituiscono lasignatura più autentica di tutto il monachesimo celtico. La loro forma spirituale rivela una profondità che per la sua specificità e per la sua aderenza ad una realtà immacolata può essere definita solo “primordiale”, rimasta fin qui sostanzialmente poco analizzata nella sua dimensione più autentica, ma che dal punto di vista della Storia delle Religioni indirizza verso un sostrato mistico-contemplativo dalle somiglianze straordinarie con aree lontane dall’Europa quali il Tibet buddhista, l’India delle prime Upanishad, l’Islam dei sufi eredi dell’insegnamento di Muhyiddin Ibn ‘Arabi, le foreste siberiane dei pustynniki, il Monte Athos degli esicasti, la Cina di alcune fra le più chiuse confraternite taoiste, il Giappone degli yamabushi, ecc.
Studiando l’attività apostolica dei monaci e di quegli innumerevoli peregrini Dei, i Deoradhs che con instancabile zelo missionario hanno percorso il continente europeo, non si può non rilevare l’enorme importanza che nei loro simboli e nella loro spiritualità hanno avuto le radici antico-celtiche dei popoli dai quali provenivano. Non si è trattata della solita, consolatoria e vaga “influenza” che resta sempre in superficie e non tocca il cuore dei fenomeni religiosi, ma della dimensione più profonda della religione druidica. D’altronde, mentre nel resto del continente le religioni antiche si trovavano al limitare estremo di un ciclo che andava a spegnersi in un crepuscolo senza luce, in Irlanda i missionari cristiani si sono trovati davanti una classe sacerdotale ancora molto vitale nonostante l'antichissimo passato e le radici “primordiali”, pienamente consapevole dei valori di cui era la portatrice, in grado di competere con i nuovi arrivati sul piano spirituale, dottrinale e rituale. Si è trattato perciò di un evento nuovo, sostanzialmente sconosciuto agli altri missionari che percorrevano il continente, ma che potevano affrontare solo apostoli cristiani perfettamente consapevoli della ricchezza del patrimonio rituale che si trovavano di fronte. La loro instancabile attività alimentata da una intensa vita liturgica e da un sostrato mistico-contemplativo molto profondo, condusse alla conversione della quasi totalità della casta sacerdotale della vecchia religione druidica e addirittura nel breve volgere di pochi decenni molti di quei cantori sacri, austeri veggenti e maghi-incantatori sono diventati famosi asceti cristiani, santi autorevoli, vescovi irreprensibili, abati illuminati e apostoli infaticabili. È un avvenimento unico nella storia delle conversioni che non autorizza affatto ad ipotizzare l'improbabile e, d’altronde, mai esistita “acculturazione latina dell'Irlanda” cui ha pensato qualche studioso prigioniero di uno schema mentale ottocentesco che lo costringe a ripetere, in modo improprio e senza adeguati approfondimenti culturali, formule tratte dall'etnologia o dalla sociologia, ed è sostanzialmente sfuggito nel suo vero significato e nelle sue implicazioni a molti storici delle religioni e del Cristianesimo che hanno preferito considerare semplicisticamente il monachesimo celtico una anticipazione barbara e rozza di quello benedettino.
La particolare articolazione di questa forma tradizionale, risultato della confluenza eccezionale nel Cristianesimo dei filid, gli autorevoli rappresentanti di una delle più antiche religioni dell’umanità che in Irlanda e in Scozia avevano conservato intatti i loro fondamenti dottrinali e rituali, è rimasta praticamente sconosciuta ai tanti ricercatori che hanno studiato la conversione dei popoli dell’impero romano senza minimamente accennare a ciò che succedeva nelle isole dell’estremità Nord dell’Europa. Proprio questa simbiosi delle forme più elevate ed “essenziali” del mondo celtico con la spiritualità cristiana, che qui ha teso sempre a preservare gli impulsi più profondi e creativi del druidismo, ha impedito persino lo svilupparsi in quelle terre di fenomeni di autentica persecuzione dall'una o dall'altra parte ed autorizza a parlare di un “monachesimo celtico” con una sua precisa identità dottrinale, liturgica e contemplativa. D'altronde, la locuzione “monachesimo irlandese” usata da alcuni specialisti, appare troppo circoscritta ad una determinata area geografica e non tiene conto che il tipo di spiritualità e lo stesso ordinamento conventuale che sottende si è estesa profondamente anche alla Scozia, alla Bretagna, al Galles, alla Cornovaglia, all'Armorica e persino a molte regioni del continente. Così come è ormai usuale distinguere per le loro peculiarità un “monachesimo siriaco”, un “monachesimo della Tebaide”, un “monachesimo copto”, un “monachesimo benedettino” o un “monachesimo athonita”, tutte forme contemplative sostanziate da ben distinte dottrine, simboli fra i più complessi e specifiche metodologie ascetiche, l'estrema articolazione e la sostanziale diversità delle forme spirituali fiorite nelle isole del Nord Europa rispetto alle altre, autorizza a parlare di un “monachesimo celtico” con una sua precisa identità mistico-contemplativa e con tutta una serie di metodi di preghiera e di sistemi liturgico-sacramentali che rendono la sua esistenza per molti aspetti un sostanziale affioramento di una religiosità primordiale, originaria.
È in quest’ambito che trova significato il sottotitolo del libro, I pellegrini della Luce. Esso intende evidenziare la speciale attitudine “mistico-visionaria” e le molte indicazioni di questi straordinari monaci. Non solo sentivano di seguire come pochi altri la dottrina della luce spirituale e le infinite articolazioni contemplative del rapporto suono-luce quali possono dedursi dalle indicazioni contenute nel Vangelo di Giovanni, ma ritenevano che la stessa luce fisica e il tracciato celeste del sole non facessero altro che costituire una sorta di veicolo di manifestazione della luce divina che già il Genesi (2, 8: “Poi il Signore Iddio piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e qui pose l’uomo che aveva formato”) aveva indicato come lo “specifico” del Paradiso terrestre, quell’”Oriente” che non si trova nelle carte geografiche, ma è il luogo teofanico nel quale risplende la “luce primordiale” di cui parlava Dionigi l’Areopagita (CH, I, 2), la Lux Matutina sperimentata da molti mistici, quella che secondo Meister Eckhart conduce alla “conoscenza aurorale” (morgenbekentnus), l’”Oriente” di una luce “originaria”.
Abbiamo evitato di soffermarci sui motivi e sulle modalità che condussero il monachesimo celtico ad essere assorbito, lentamente, ma inesorabilmente, nelle varie famiglie scaturite dall'Ordine benedettino, e abbiamo toccato questo complesso problema solo quando era strettamente necessario ai fini di una opportuna chiarificazione. Questo processo di assimilazione è durato molto tempo, almeno dal VII al XII secolo, è stato lento, ma continuo ed inesorabile, ed ha condotto alla sparizione di quasi tutte le forme sacramentali, i ritmi liturgici, i simboli, i tipi di preghiera e di meditazione che costituivano la caratteristica specifica del mondo che dall'Irlanda si era diffuso fra le popolazioni del Nord e poi si era riversato sul continente con una infaticabile forza di penetrazione definita efficacemente da alcuni studiosi come ”invasione mistica” dell’Europa che ha dato vita ad un numero inverosimile di fondazioni monastiche dalle quali si è irradiata una raffinatissima cultura. E tuttavia, alcuni elementi di quell'antica spiritualità devono essere rimasti tenacemente vivi anche quando sembrava che la tradizione cristiano-celtica fosse irrimediabilmente sparita se ancora in pieno XII secolo san Bernardo di Clairvaux, questo grande mistico e teologo cistercense considerato l’ultimo dei Padri della Chiesa, rimaneva ammirato di fronte all'elevatezza spirituale di quello che si presentava esteriormente come un semplice asceta ed un umile abate, uno dei tanti Patres che avevano fecondato la tradizione monacale celtica, san Malachia O’Morghair, l’arcivescovo di Armagh, l’erede di san Patrizio nella sede “primaziale” d'Irlanda.
Tommaso Campanella, Lettere.
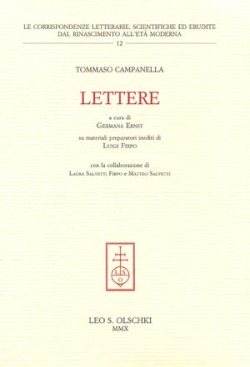
« Il secolo futuro giudicarà di noi, perché il presente sempre crucifige i suoi benefattori: ma poi risuscitano il terzo giorno, o il terzo secolo». Tommaso Campanella
Nel 1634 era stato costretto a una precipitosa partenza da Roma, sotto mentite spoglie e falso nome, per sfuggire alle fazioni filospagnole e filofrancesi della curia che avevano scatenato attorno al trono di Pietro una guerra di maghi e astrologi, spie e sicari, delazioni e omicidi. Uno degli attori principali di questo scontro era stato proprio Tommaso Campanella, umile frate di povere origini calabresi ma sottile filosofo naturalista e temuto mago. Fin dai primi tempi del suo arrivo a Roma, nel 1626, avevano preso a circolare insistenti voci sull’ormai prossima morte del Papa. Oscuri presagi astrali avevano convinto Urbano VIII (che si dilettava di astrologia e si vantava di conoscere le natività di tutti i membri del Sacro Collegio) a convocare a più riprese Campanella nei palazzi apostolici. Nelle relazioni diplomatiche di quegli anni si trovano frequenti accenni agli incontri segreti fra un Papa intenzionato a preservare il più a lungo possibile la propria vita e «il maggior astrologo de’ nostri tempi». Ma in Vaticano c’era chi stava tramando nell’ombra... e per frate Tommaso l’unica via di scampo era la fuga alla volta della Francia.
Fuga che, una volta a Parigi, sotto la protezione di Luigi XIII e del cardinale Richelieu, Campanella rievoca in una lettera del 9 aprile 1635 a Papa Urbano VIII, uno scritto fino a oggi inedito che finalmente si può leggere nel volume che raccoglie l’intero corpus epistolare del misterioso frate calabrese (alle lettere presentate in una precedente raccolta apparsa nel 1927, sono state aggiunte una cinquantina di significative missive scoperte nel corso degli ultimi decenni): Tommaso Campanella, Lettere (Olschki, pagg. 730, euro 74; a cura di Germana Ernst).
Il libro ha il pregio di non rivolgersi solo agli esperti. Le 172 missive permettono anche ai profani di passare, seppur in modo ineguale, attraverso la vita di questo frate di Stilo, temuto per la profondità deflagrante del suo pensiero e per la fama sinistra di mago. Le lettere, di varia natura (lunghi memoriali e rapidi biglietti, opuscoli e dediche) partono dalle giovanili frequentazioni napoletane (ove Campanella si forma presso il circolo del filosofo naturalista Bernardino Telesio) ai periodi trascorsi a Firenze presso la corte dei Medici e a Padova ove conosce il giovane Galileo; dagli anni in cui visse un violento contrasto con l’Inquisizione (le lettere dei primi anni in prigione sono locate «dal Caucaso» perché come Prometeo il frate è legato mani e piedi e costretto a continui supplizi, poi scampata la pena capitale riceverà col tempo condizioni migliori e intratterrà regolari corrispondenze con cardinali, principi e uomini di cultura) fino al suo approdo in terra francese.
Gianluca Montinaro
Nel 1634 era stato costretto a una precipitosa partenza da Roma, sotto mentite spoglie e falso nome, per sfuggire alle fazioni filospagnole e filofrancesi della curia che avevano scatenato attorno al trono di Pietro una guerra di maghi e astrologi, spie e sicari, delazioni e omicidi. Uno degli attori principali di questo scontro era stato proprio Tommaso Campanella, umile frate di povere origini calabresi ma sottile filosofo naturalista e temuto mago. Fin dai primi tempi del suo arrivo a Roma, nel 1626, avevano preso a circolare insistenti voci sull’ormai prossima morte del Papa. Oscuri presagi astrali avevano convinto Urbano VIII (che si dilettava di astrologia e si vantava di conoscere le natività di tutti i membri del Sacro Collegio) a convocare a più riprese Campanella nei palazzi apostolici. Nelle relazioni diplomatiche di quegli anni si trovano frequenti accenni agli incontri segreti fra un Papa intenzionato a preservare il più a lungo possibile la propria vita e «il maggior astrologo de’ nostri tempi». Ma in Vaticano c’era chi stava tramando nell’ombra... e per frate Tommaso l’unica via di scampo era la fuga alla volta della Francia.
Fuga che, una volta a Parigi, sotto la protezione di Luigi XIII e del cardinale Richelieu, Campanella rievoca in una lettera del 9 aprile 1635 a Papa Urbano VIII, uno scritto fino a oggi inedito che finalmente si può leggere nel volume che raccoglie l’intero corpus epistolare del misterioso frate calabrese (alle lettere presentate in una precedente raccolta apparsa nel 1927, sono state aggiunte una cinquantina di significative missive scoperte nel corso degli ultimi decenni): Tommaso Campanella, Lettere (Olschki, pagg. 730, euro 74; a cura di Germana Ernst).
Il libro ha il pregio di non rivolgersi solo agli esperti. Le 172 missive permettono anche ai profani di passare, seppur in modo ineguale, attraverso la vita di questo frate di Stilo, temuto per la profondità deflagrante del suo pensiero e per la fama sinistra di mago. Le lettere, di varia natura (lunghi memoriali e rapidi biglietti, opuscoli e dediche) partono dalle giovanili frequentazioni napoletane (ove Campanella si forma presso il circolo del filosofo naturalista Bernardino Telesio) ai periodi trascorsi a Firenze presso la corte dei Medici e a Padova ove conosce il giovane Galileo; dagli anni in cui visse un violento contrasto con l’Inquisizione (le lettere dei primi anni in prigione sono locate «dal Caucaso» perché come Prometeo il frate è legato mani e piedi e costretto a continui supplizi, poi scampata la pena capitale riceverà col tempo condizioni migliori e intratterrà regolari corrispondenze con cardinali, principi e uomini di cultura) fino al suo approdo in terra francese.
Gianluca Montinaro
Il problema dell'ateismo.

" Del Noce, uno dei più maggiori pensatori che l’Italia ha avuto negli ultimi cinquant’anni, ritiene infatti che dar conto della modernità altro non significhi che dar conto della genesi, dello sviluppo e degli esiti storici dell’ateismo: il problema epocale dell’ateismo è il problema decisivo della modernità. Ma in che senso?Ciò che differenzia in modo radicale l’età medievale dall’età moderna è che, in quest’ultima, Dio non è più al centro del mondo: l’età medievale era teocentrica, l’età moderna antropocentrica. Per Del Noce, a partire da Cartesio e dal razionalismo moderno ha preso piede, espandendosi in modo sempre più incontrollabile, un prometeismo dell’umano che ha portato i suoi protagonisti a non avere più il senso del limite e perciò alla convinzione, del tutto irrazionale, che l’uomo sia in grado di darsi ogni meta, che possa conquistare tutto, che abbia diritto a tutto. La modernità, in altri termini, è stata profondamente segnata dalla perdita fondamentale del «dogma cristiano»: l’idea biblica del peccato originale, vale a dire l’accettazione realistica dello status naturae lapsae che caratterizza, in modo irrimediabile, la costituzione stessa degli individui: gli uomini sono creature e non creatori "
Il problema dell'ateismo è un libro importante. Confrontarsi con Augusto del Noce non è una necessità ma può essere salutare per certi belli spiriti. Interessa la profondità dell'analisi piuttosto che le diatribe sulla religiosità di questo o di quello o dello stesso del Noce.
gdg
Il problema dell'ateismo è un libro importante. Confrontarsi con Augusto del Noce non è una necessità ma può essere salutare per certi belli spiriti. Interessa la profondità dell'analisi piuttosto che le diatribe sulla religiosità di questo o di quello o dello stesso del Noce.
gdg
Lettera Filosofica di Michele Sendivogio.
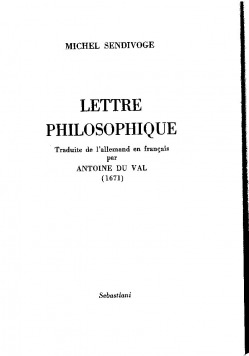
L'Adepto traccia i fondamenti della Arte Sacra. Egli precisa che non si rivolge ai pedanti e che la Fisica che egli propone potrebbe apparire stravagante e che i suioi insegnamenti sono rivolti esclusivamente a chi saprà servire il prossimo e a chi saprà glorificare l'Onnipotente.In lingua francese.
gdg
gdg
Epistola del Fuoco Filosofico di Iohannes Pontanus.
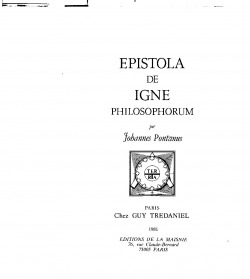
" Questo fuoco ,o acqua ardente, è la scintilla vitale comunicata dal Creatore alla materia inerte; è lo spirito incluso nelle cose, il raggio igneo, imperituro, chiuso nel fondo dell'oscura sostanza, informe e fredda. Per quanto ci riguarda noi non possiamo fare altro che segnalare lo scoglio e consigliare , con i più eminenti filosofi, la lettura attenta di Artefio, di Pontanus e della piccola opera intitolata: Epistola de Igne Philosophorum " Fulcanelli,Il Mistero delle Cattedrali
Questo libretto in lingua francese contiene anche una prefazione di Séverin Batfroi e una introduzione di Bernard Biebel.
gdg
Questo libretto in lingua francese contiene anche una prefazione di Séverin Batfroi e una introduzione di Bernard Biebel.
gdg
I misteri della Cattedrale di Chartres.
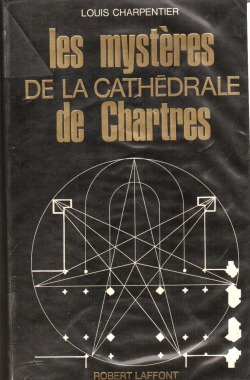
Luois Charpentier interroga la Cattedrale di Chartres. Molte sono le risposte e non poche le sorprese. Felice prosecuzione delle opere di Fulcanelli . Il libro lo si può facilmente trovare anche in italiano.
gdg
gdg
Ai confini dell'anima.

( Saggio sulla follia )
Come scrive Eraclito in un suo famoso frammento: «Per quanto tu cammini per ogni via, i confini dell' anima non li troverai». Per i Greci la follia fu appunto un mezzo per esplorare questi confini. Ma la nozione di follia (manìa) andava oltre la dimensione della patologia. «La follia è tanto superiore alla sapienza (scriveva Platone nel Fedro) in quanto la prima viene dagli dei, la seconda dagli uomini». Non tutte le forme di follia, s' intende: solo la follia che giunge «per dono divino». Ma qual è questa «divina follia»? Platone lo spiega poco dopo: quella del poeta ispirato che scopre in sé improvvise energie creative, quella del profeta che spinge lo sguardo nell' invisibile, quella di Dioniso che consente di entrare in uno stato mentale che i Greci definivano estasi, in cui un uomo percepisce di avere «un dio dentro di sé», e infine («la migliore di tutte» precisa Platone) la follia di Amore, che porta l' anima vicino alla sua vera natura. Così, per i Greci la follia assumeva una duplice faccia: da un lato malattia della mente, dall' altro potenziamento della personalità. Per i Greci del V secolo a.C. era un' alterazione della psiche. Ma il significato di psyche era in origine diverso. In Omero, la psiche era il soffio vitale che al momento della morte abbandonava il cadavere. La concezione di psiche come «anima» o «mente» si sviluppò a seguito di un' evoluzione alla quale contribuirono correnti religiose e saperi laici (in particolare filosofia e medicina). Alla fine, la psiche divenne la realtà interiore in cui si concentra la vera identità di un individuo: una concezione che da Platone passa al Cristianesimo. Nella Grecia arcaica l' alterazione della coscienza aveva uno spazio importante nella dimensione della religione, all' interno di istituzioni come il santuario di Apollo a Delfi, ove si praticava la divinazione estatica; o nei rituali di trance, di cui il culto di Dioniso rappresenta solo l' aspetto più noto e impressionante. Fu la cultura del secolo illuminista di Pericle e di Socrate a separare dalla sfera della conoscenza una serie di esperienze di confine quali la possessione, l' estasi e altri stati subliminali, per relegarle nel limbo delle manifestazioni irrazionali. A partire da allora, ragione e follia iniziarono a essere considerati aspetti alternativi della personalità: ogni uomo - scrive Platone - combatte una guerra contro se stesso e spesso a perdere è la ragione. Per i Greci, però, la follia non era solo il sonno della ragione: era anche un mezzo per esplorare le manifestazioni estreme e inquietanti della natura umana. Tutto ciò che di più insondabile e oscuro si agita nell' anima di un essere umano è tra i temi centrali della tragedia: il dramma di Eracle o di Medea che uccidono i figli pur amandoli, la violenza autodistruttiva di Aiace, i fantasmi di Oreste e di altri personaggi ai quali si può applicare la frase di Sofocle: «Un bene sembra un male a un uomo la cui mente è accecata da un dio». A differenza di quanto sarebbe accaduto nella società europea moderna, la Grecia non conobbe la reclusione dei folli: i greci seppero convivere con loro, elaborando forme di controllo dell' alienazione mentale all' interno della società, attraverso la reintegrazione e non l' esclusione. L' organizzazione logica, scientifica ed etica dell' esperienza - la gloria della Grecia - nacque per confronto col mondo della non ragione. Dal mito al logos: questa è una delle tradizionali chiavi di lettura della civiltà greca, ma si tratta di una semplificazione. In realtà mito e logos sono intrecciati lungo il percorso di quella cultura, come pure ragione e follia. Sono profonde le fratture nella storia della follia in Occidente, sono molte e molto interessanti le cose che racconta Giulio Guidorizzi in questo bel libro, il primo in italiano a tracciare una storia della follia nel mondo greco (Ai confini dell' anima. I greci e la follia, Raffaello Cortina editore, pp. 225, 19): un libro che stimola importanti riflessioni non solo sull' antichità, ma anche sul presente, su di noi e il nostro rapporto con la follia.
Eva Cantarella.
Come scrive Eraclito in un suo famoso frammento: «Per quanto tu cammini per ogni via, i confini dell' anima non li troverai». Per i Greci la follia fu appunto un mezzo per esplorare questi confini. Ma la nozione di follia (manìa) andava oltre la dimensione della patologia. «La follia è tanto superiore alla sapienza (scriveva Platone nel Fedro) in quanto la prima viene dagli dei, la seconda dagli uomini». Non tutte le forme di follia, s' intende: solo la follia che giunge «per dono divino». Ma qual è questa «divina follia»? Platone lo spiega poco dopo: quella del poeta ispirato che scopre in sé improvvise energie creative, quella del profeta che spinge lo sguardo nell' invisibile, quella di Dioniso che consente di entrare in uno stato mentale che i Greci definivano estasi, in cui un uomo percepisce di avere «un dio dentro di sé», e infine («la migliore di tutte» precisa Platone) la follia di Amore, che porta l' anima vicino alla sua vera natura. Così, per i Greci la follia assumeva una duplice faccia: da un lato malattia della mente, dall' altro potenziamento della personalità. Per i Greci del V secolo a.C. era un' alterazione della psiche. Ma il significato di psyche era in origine diverso. In Omero, la psiche era il soffio vitale che al momento della morte abbandonava il cadavere. La concezione di psiche come «anima» o «mente» si sviluppò a seguito di un' evoluzione alla quale contribuirono correnti religiose e saperi laici (in particolare filosofia e medicina). Alla fine, la psiche divenne la realtà interiore in cui si concentra la vera identità di un individuo: una concezione che da Platone passa al Cristianesimo. Nella Grecia arcaica l' alterazione della coscienza aveva uno spazio importante nella dimensione della religione, all' interno di istituzioni come il santuario di Apollo a Delfi, ove si praticava la divinazione estatica; o nei rituali di trance, di cui il culto di Dioniso rappresenta solo l' aspetto più noto e impressionante. Fu la cultura del secolo illuminista di Pericle e di Socrate a separare dalla sfera della conoscenza una serie di esperienze di confine quali la possessione, l' estasi e altri stati subliminali, per relegarle nel limbo delle manifestazioni irrazionali. A partire da allora, ragione e follia iniziarono a essere considerati aspetti alternativi della personalità: ogni uomo - scrive Platone - combatte una guerra contro se stesso e spesso a perdere è la ragione. Per i Greci, però, la follia non era solo il sonno della ragione: era anche un mezzo per esplorare le manifestazioni estreme e inquietanti della natura umana. Tutto ciò che di più insondabile e oscuro si agita nell' anima di un essere umano è tra i temi centrali della tragedia: il dramma di Eracle o di Medea che uccidono i figli pur amandoli, la violenza autodistruttiva di Aiace, i fantasmi di Oreste e di altri personaggi ai quali si può applicare la frase di Sofocle: «Un bene sembra un male a un uomo la cui mente è accecata da un dio». A differenza di quanto sarebbe accaduto nella società europea moderna, la Grecia non conobbe la reclusione dei folli: i greci seppero convivere con loro, elaborando forme di controllo dell' alienazione mentale all' interno della società, attraverso la reintegrazione e non l' esclusione. L' organizzazione logica, scientifica ed etica dell' esperienza - la gloria della Grecia - nacque per confronto col mondo della non ragione. Dal mito al logos: questa è una delle tradizionali chiavi di lettura della civiltà greca, ma si tratta di una semplificazione. In realtà mito e logos sono intrecciati lungo il percorso di quella cultura, come pure ragione e follia. Sono profonde le fratture nella storia della follia in Occidente, sono molte e molto interessanti le cose che racconta Giulio Guidorizzi in questo bel libro, il primo in italiano a tracciare una storia della follia nel mondo greco (Ai confini dell' anima. I greci e la follia, Raffaello Cortina editore, pp. 225, 19): un libro che stimola importanti riflessioni non solo sull' antichità, ma anche sul presente, su di noi e il nostro rapporto con la follia.
Eva Cantarella.
Le Origini Occulte del Nazismo.

INTRODUZIONE .
Mi sono proposto di esaminare, in questo volume, gli aspetti principali dell'Illuminismo tedesco, nei suoi rapporti con lo sviluppo storico-politico della Germania. Nel far ciò, durante una recente ricerca fatta in Baviera, ho scoperto qualche origine, fino ad oggi ignorata, del fenomeno nazionalsocialista, che non è del tutto tedesca. Inoltre, in rapporto al carattere "magico" dell'ideologia hitleriana, era necessario analizzame i temi simbolici e mitici fondamentali.
Voglio ricordare, a questo proposito, l'interesse degli studi di J.F. Neurhor, direttore dell'Istituto francese di Monaco, uno dei migliori "germanisti" contemporanei e la sua opera "Der Mithus von Dritten Reich" pubblicato a Stoccarda nel 1957. Vi sono pochi esempi, infatti, di un'analisi così precisa sulla situazione rivoluzionaria di una nazione, in funzione dei propri miti e della loro trasformazione nel corso della storia intellettuale, morale e spirituale. J.F. Neurhor ha scelto, per così dire, allo "stato nascente" quella cristallizzazione di "miti parziali", spesso contraddittori, che edificarono il "mito del Terzo Reich" così permettendo al nazionalsocialismo di modificarsi in religione e apparire alla comunità tedesca come una realtà mistica.
L'evoluzione è stata certamente accelerata dall'hitlerismo ma essa aveva precorso di molto l'apparizione del nazionalsocialismo 1; "Non si deve credere - sottolinea J.F. Neurhor - che Hitler o i nazionalsocialisti avessero inventato di punto in bianco il mito del 'Terzo Impero' per gettarlo alla massa. Esso preesisteva da molto allo stato latente nel popolo tedesco e soprattutto negli ambienti colti della nazione, passati attraverso le università, centri tradizionali del patriottismo e del nazionalismo da più di qualche secolo. Qualcuno dei temi del neo-nazionalismo si può far risalire fino alle guerre napoleoniche, ai filosofi e poeti del romanticismo e alla Restaurazione, altri si sono sviluppati nel corso del XIX secolo ove, sotto il regno di Gugliemo II, formano già delle parti costituenti il pangermanismo precedente la guerra. Altri, infine, riflettono la reazione della coscienza nazionale tedesca precedente la guerra, in vista di una situazione politica del tutto nuova e di problemi sociali sconosciuti fino allora".
Bisogna qui precisare che J.F. Neurhor intende generalmente limitare il concetto di "mito" alle analisi di Georges Sorel, e non interpreta affatto questa nozione in funzione delle teorie psicanalitiche. Si sa come la concezione soreliana del mito si ispiri alla psicologia bergsoniana. Per quest'ultimo, un "atto libero" dell'uomo consiste essenzialmente in uno di quei "momenti unici nel loro genere, in cui l'uomo prende possesso di sé, in cui ci si ricolloca nel puro fluire del tempo". Creiamo, in quei momenti, un mondo tutto artificiale d'immagini poste innanzi al presente, già formate da movimenti, e che dipendono da noi. Benché artificiali, queste immagini, queste rappresentazioni ideali, contribuiscono in modo decisivo a modificare il senso della direzione della nostra vita psicologica e ad indirizzarne gli atti.
J.F. Neurhor accosta questi "movimenti vissuti unici" bergsoniani a quelli che la moderna filosofia tedesca definisce e in "Erlebnis". Sorel sembra aver applicato questa filosofia dell'azione alla società e alla storia. "Questi mondi artificiali - egli dice - scompaiono generalmente dal nostro spirito senza lasciare ricordi, ma quando le folle si appassionano, allora è il momento di tracciare una immagine che costituisce un mito sociale". Per il celebre autore delle "Réflexions sur la violence", "lo sciopero generale costituisce il 'mito' in cui è racchiuso tutto il socialismo, ossia 'un'organizzazione' d'immagini capaci di evocare istintivamente tutti i sentimenti corrispondenti alle differenti manifestazioni della guerra ingaggiata dal socialismo contro la società moderna. Gli scioperi hanno prodotto nel proletariato i sentimenti più nobili, più profondi e più dinamici che egli possieda; lo sciopero generale li unisce in un quadro d'insieme e, attraverso il loro accostamento, dà a ciascuno il massimo d'intensità; facendo appello ai più ribollenti ricordi delle lotte particolari, esso colora di un'intensa vita ogni dettaglio della composizione presente alla coscienza. Otteniamo così quella intuizione del socialismo che il solo linguaggio non poteva offrire in maniera particolarmente chiara, - e l'otteniamo in un insieme istantaneamente chiarificato" 2.
Una nota che segue al testo di Sorel aggiunge: "È la conoscenza perfetta della filosofia bergsoniana". Si vede così come si tratti di una concezione pragmatista, anti-determinista, anti-intellettuale, anti-meccanicista, una filosofia mitica, individuale e collettiva. Gruppi sociali o intere nazioni, nel momento di gravi crisi o rivoluzioni, sarebbero animate da una vivente organizzazione d'immagini tratte dalla negazione del presente, ma anche dai loro sogni, dalle loro aspirazioni, dalle loro forze dinamiche. Questo mito rivoluzionario non sarebbe affatto una descrizione delle cose, né come sono né, soprattutto, tali quali saranno nella realtà, una volta sopravvenuto il cambiamento, ma esprime un'unione di volontà.
Un mito, nel senso soreliano, si distingue da un'utopia composta ed elaborata da un filosofo o da un uomo di cultura che pretende di "pensare per il proletariato". Il mito è una organizzazione immaginaria motrice, una "idea-forza" che influenza un gruppo sociale al punto da portarlo a diventare una forza creatrice della storia. Sorel cita l'esempio dei "protestanti della Riforma nutriti dalla letteratura dell'Antico Testamento. Volendo imitare le gesta degli antichi conquistatori della Terra Santa, essi assunsero l'offensiva e volevano stabilire il regno di Dio con la forza".
Si deve, a questo proposito, porre mente ad alcune espressioni di Sorel, riguardo la natura del socialismo, che evocano in maniera singolare la "Grande Opera" politica con cui certe società segrete indottrinavano iniziaticamente i loro adepti sugli arcani: "Bisogna che i socialisti - dichiara Sorel - siano persuasi che l'opera alla quale si sono consacrati è una 'pesante opera, irriducibile e sublime'; a questa condizione solamente essi potranno accettare gli innumerevoli sacrifici che richiede una propaganda che non può procurare né onori né profitti, e nemmeno immediate soddisfazioni intellettuali. Quando la nozione di sciopero generale non avrà altro risultato che rendere più eroica la nozione di socialismo essa dovrà già, per questo fatto soltanto, essere vista come avente un valore senza prezzo". Così, Sorel annuncia che una specie di irresistibile marea passerà sull'antica civiltà.
Questo linguaggio profetico, questa immagine diluviale della "mutazione" storica, il "salto qualitativo" che deve definitivamente separare due ere "geologico-sociali" successive, quella del capitalismo e quella del socialismo, ripetono, certamente con eloquenza, il tema della "rottura senza rimedio" già sviluppato da Marx e da Engels. Ma vi si ritrova tuttavia la nuova affermazione di un "messianesimo" fondato sul "momento unico vissuto" bergsoniano. L'eroismo diviene allora capace di adempiere con i suoi atti quella "grande scienza" di trasmutazione sociale che Sorel non cessa di opporre alla "piccola scienza" degli "intellettuali" e degli "utopisti pseudo-rivoluzionari".
Si osserva così che Sorel non concede alla nozione di "mito" il senso ordinario di "cosa favolosa". Ciò non avviene per denunciare il carattere illusorio e menzognero dello sciopero generale, che egli considera alla pari di un mito. Egli sostiene, al contrario, il significato essenzialmente creatore nella "pura durata" in cui esso si pone. Da ciò viene chiaramente espresso il suo dinamismo "poetico" nel senso letterale e non letterario del termine "poiein", "Creare". Sorello sottolinea, del resto, in numerosi passaggi della sua opera: il divenire sociale non è affatto un determinismo storico. È una "creazione libera" fatta sotto l'influenza di "miti sociali particolarmente scelti", da un gruppo d'uomini "capaci d'entusiasmo", ciò che significa etimologicamente un'"esaltazione prodotta dall'ispirazione divina". Così la causa del sindacalismo rivoluzionario sarà inseparabile dalla "Grande Opera" di un'energia trascendente, destinata a trasformare l'uomo, il mondo, la vita.
Se si ricercano le origini nascoste di questa universale trasmutazione che, in apparenza, possono sembrare utopiche, si trova che sono fondate inconsciamente su una nuova rappresentazione simbolica del tempo vissuto e, per così dire, su un'altra "considerazione mitica del tempo".
La nostra epoca, infatti, non è stata meno subitaneamente messa a confronto con nuove rappresentazioni dello spazio e del tempo di quanto lo fosse stato il Rinascimento. Poco a poco, un mito cronologico, diverso da quello dei secoli precedenti, sembra essersi imposto all'inconscio collettivo. Il nuovo mito trasferisce "verso il futuro" tutte le forze dell'epoca, diventando un "inventore incessante" e lo si scorge dominare non solo la filosofia bergsoniana, ma perfino le interpretazioni organicistiche dell'evoluzione, i deliri tecnologici, i profetismi mistico-politici del XX secolo.
Così il pensiero socialista soreliano giunge a dipendere più di ogni altro dalla concezione bergsoniana della durata e del suo orientamento generale verso l'avvenire delle società. Nella misura in cui si capovolge questo movimento, si capovolge tutto il sistema. Sarà sufficiente trasferire i principi soreliani sulla legittimità della violenza ai diritti di un "patriziato nazionalista" che rivendicava "nel nome del più lontano passato", la libertà di condurre a proprio modo una "lotta di razze chiamate a dominare il mondo, e non più una lotta di classi", per giungere in linea diretta a quell'imperialismo nazionalsocialista che, egli stesso, ha presentato i propri miti politici come un "insieme di volontà" rivoluzionaria, basata su "particolari miti sociali" e su gruppi d'uomini capaci di un entusiasmo distruttore.
La mistagogia hitleriana ha esteso, ad esempio, la concezione "diluviale" delle ere "geologico-sociali", annunciate da SoreI, a dei temi biologico e sociali di cui il "delirio endemico", la "Wehnstimmung" si è molto servita togliendo a prestito le divagazioni pseudo-esoteriche del XIX secolo: "Un tema che ritornava costantemente nei suoi pensieri - dice H. Rausching a proposito di Hitler - e ciò che egli definiva la 'svolta decisiva del mondo' o la cerniera delle epoche. Vi sarebbe stato uno sconvolgimento del pianeta di cui noi, non iniziati, non si sarebbe potuto comprendere tutta l'ampiezza. Hitler parlava come un veggente. Egli s'era costruito una biologia mistica che era alla base delle sue ispirazioni... Il periodo solare dell'uomo toccava l'apogeo: già si potevano vedere i primi esemplari del super-uomo, la nuova specie che andava respingendo l'antica umanità... Il nazionalsocialismo è più di una religione: esso è la volontà di creare il super-uomo" 3.
La citazione ci dà qualche idea del modo in cui il nazionalsocialismo "ha invertito gli scopi rivoluzionari", grazie a due sistemi assai semplici: il primo, che consiste nell'identificare la nazione con l'umanità, il partito con la chiesa, l'uomo con Dio; e il secondo, che dissimula i reali problemi dell'economia sotto gli illusori problemi di una pseudo-biologia.
Il "delirio endemico" dei capi nazionalsocialisti non deve far dimenticare, infatti, la quotidiana efficacia nel dominio della propaganda politica, né l'utilizzazione fattane da parte di gruppi d'interesse economico. Hitler si pronuncia chiaramente sul primo punto nel "Mein Kampf": "La facilità di assimilazione della massa", dice, "è assai ristretta ed il suo intendimento è piccolo: per contro, la sua smemoratezza è grande. Dunque tutta la propaganda efficace deve limitarsi a dei punti essenziali, poco numerosi, e farli valere a forza di formule stereotipe per tutto il tempo che sarà necessario a far sì che anche l'ultimo degli ascoltatori arrivi ad afferrare l'idea... La grande massa di un popolo non è composta né da professori né da diplomatici. Essa è poco accessibile alle idee astratte. Per contro, la si terrà in pugno più facilmente nel regno dei sentimenti, ed è là che si trovano i moventi segreti delle sue reazioni, sia positive che negative... In ogni periodo, la forza, che ha messo in movimento le rivoluzioni più violente su questa terra, è stata molto meno la proclamazione di una idea scientifica che si è impadronita delle folle, che non un fanatismo animatore e un vero e proprio isterismo che le eccita alla follia" 4. Per quanto riguarda la finalizzazione economica del "delirio endemico" della "Wahnstimmung" hitleriana, ecco un documento ancora poco conosciuto che merita di essere letto e meditato: un estratto della deposizione di Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, reso nel 1947 davanti alle autorità americane: "lo sottoscritto Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, Norimberga, dopo che mi è stato fatto notare che posso incorrere nei rigori della legge in caso di falsa testimonianza dichiaro quanto segue sotto giuramento e libero da ogni costrizione.
In risposta alla domanda sui motivi per i quali la mia famiglia si è pronunciata per Hitler, ho risposto: "L'economia necessita di uno sviluppo regolare e sempre più ampio. La lotta tra i molteplici partiti tedeschi e la conseguente confusione hanno impedito un'attività creatrice. Noi Krupp non siamo per nulla degli idealisti, siamo dei realisti". Mio padre era diplomatico. Avemmo l'impressione che Hitler ci avrebbe permesso un sano sviluppo. Così in effetti è stato. Il sistema preesistente dei partiti era del tutto folle. Hitler, al contrario, studiava dei piani e agiva in conseguenza. Al principio, noi abbiamo votato per il Partito del Popolo tedesco in cui mio nonno, von Wilmovsky, occupava una carica importante. Ma l'ala conservatrice era troppo debole per dirigere il nostro paese.
Non esistono ideali. La vita è una lotta per la "conservazione della vita", per il pane e per il potere. Parlo senza perifrasi, in quest'ora amara della sconfitta. In questa lotta così dura abbiamo bisogno di essere guidati da una mano forte e ferma. Hitler ci porse l'una e l'altra. Durante gli anni del suo governo ci sentimmo molto più sereni.
Ho già detto che tutti i tedeschi seguivano Hitler. La maggior parte del popolo era alle spalle del governo. Può essere stata questa la nostra debolezza. Ho letto, in seguito, i discorsi di Churchill, e ho constatato come anche lui fosse costretto a difendere la propria politica contro le critiche dei partiti e, all'occasione, modificarla. Non vi è mai stato nulla di ciò presso noi.
Ma, all'inizio, la differenza non fu così grande. Tutta la nazione si trovava d'accordo con le grandi linee della politica seguita da Hitler.
Noi Krupp non abbiamo mai dato grande importanza alla vita. Abbiamo solo cercato un sistema .che funzionasse bene e che offrisse la possibilità di lavorare in pace. La politica non è il nostro affare.
Quando mi hanno interrogato sulla politica anti-semita del nazionalsocialismo, e mi hanno chiesto che cosa ne sapessi, ho risposto che non ero a conoscenza di nulla sullo sterminio degli Ebrei e ho aggiunto: "Quando si compra un buon cavallo, non si guarda a qualche piccolo difetto" 5.
La firma dell'accusato segue la deposizione. Alfried Krupp, condannato il 31 luglio 1948 dal tribunale militare americano di Norimberga a 12 anni di reclusione e alla confisca dei beni, ritrovò la libertà e la propria fortuna nel gennaio 1951, grazie all'intervento dell'alto commissario americano in Germania, Mac Clov. Oggi "i Krupp" continuano, come nel passato, a "non dare grande importanza alla vita" e ad agire in funzione di quello che è il loro unico principio: "Non esistono ideali". Questi fatti debbono essere ricordati nel corso del volume, per ben distinguere ciò che chiamo l'analisi mito-politica del fenomeno hitleriano, dalle fabulazioni mistificatrici e sospette con cui alcuni scrittori, principalmente francesi, si sono troppo com,. piacentemente aggirati in questo campo, ricostituendo una pericolosa neo-mitologia del nazionalsocialismo.
Infatti, tutto il "delirio endemico" cerca di presentarsi politicamente come una sintesi demagogica del disparato e vi si scorge sempre ciò che vi si preferisce trovare. Il "razionalista darwiniano" può pretendere che il nazionalsocialismo sia stato un chiaro tentativo sperimentale di applicare all'umanità i principi scientifici della selezione delle razze e dell'evoluzione delle specie, riconoscendo così in Hitler l'incarnazione della "fredda ragione"; altrettanto legittimamente l'occultista è capace di scorgervi l'opera magica delle "potenze nere del Tibet". Perché è proprio di questo "delirio endemico" l'essere facilmente comunicabile a forme analoghe che vi si riconoscono, del resto, tanto più facilmente, quanto esso si mostri ai loro occhi attraverso l'autorità di un apparato storico che tende a confortarli sull'effettivo valore dei loro sistemi.
Da questo punto di vista, si deve ricordare, a rischio di essere sgraditi a tutti, che Hitler fu chiamato il "Cristo tedesco" altrettante volte che "Anticristo". W. Hofer cita, ad esempio, il testo seguente di un dettato di scuola comunale: "Gesù e Hitler": "Come Gesù liberò gli uomini dal peccato e dall'inferno, Hitler salvò il popolo tedesco dalla sua sconfitta: Gesù e Hilter furono perseguitati; ma mentre Gesù venne crocefisso, Hitler fu nominato cancelliere del Reich. Mentre i discepoli di Gesù rinnegarono e abbandonarono il loro maestro, i sedici camerati 6 caddero per il loro Führer. Gli apostoli proseguirono l'opera del loro Signore. Noi speriamo che Hitler terminerà da solo la propria. Gesù costruiva per il cielo: Hitler per la terra tedesca" 7.
In una recente opera 8 lo storico Friederich Heer riferisce che certi circoli cattolici spagnoli si ostinino a considerare Hitler come un santo sacrificatosi alla causa della protezione della Chiesa e che alcuni pregano per ottenere la sua intercessione e la sua protezione contro la "diabolica sovversione del comunismo".
Salvator Dalì, al limite "paranoico-critico", rivendica nel suo personale delirio fini ancora meno limitati di quelli della "Wahnstimmung" nazionalsocialista. Egli sogna una guerra cataclismica, "ultrarapida, colossalmente distruttiva e trasformatrice, di una ferocia inaudita" 9 che libererà i "veri maestri", i "grandi crudeli", i "signori senza limiti". Dalì dimentica che questi esistono già sotto forma dei "Krupp" e anche da molto tempo. "Hitler era forse un delirante - continua - ma seguiva dei precisi scopi come quelli dell'egemonia tedesca e della vittoria di una razza. Noi ancora non sappiamo che cosa siano i Superiori. Essi non saranno umanitari ma superumanitari, essi non si occuperanno del progresso, ma della trasmutazione, e cercheranno il massimo rendimento attraverso il massimo dei conflitti" 10. Questo è lo scopo principale di coloro che, in numerosi paesi, divennero i complici e i banchieri del nazionalsocialismo.
Esistettero in Germania due gruppi principali di logge massoniche, quelle che erano "umanitarie" perché accolsero gli ebrei e rimasero in rapporto con gli "Antichi Doveri" dettati dalla "Costituzione d'Anderson", e quelle dell'"Antica Prussia" che esclusero tutti i membri "non strettamente germanici" respingendo il rituale fondato sull'Antico Testamento e il simbolismo "non essenzialmente tedesco" dopo aver assicurato Hitler della loro devozione. Per ciò che è a mia conoscenza, non esistono logge sovraumanitarie: me ne dispiace per Dalì e anche per la Massoneria "antico prussiana" (Altpreussische) che commise errori non meno pesanti della Chiesa romana di Pio XII, degli "ultraconservatori" britannici, i "Die Hards" sul tipo di Sir Henry Deterding, il presidente della "Royal Dutch" e dell'"Unione delle Chiese protestanti" diretta dal pastore Miiller.
Il governo hitleriano regolò in pochi mesi i rapporti fra lo Stato e la Chiesa. I negoziati di von Papen a Roma si conclusero ben presto con la firma di un concordato con il Vaticano. Dopo la costituzione della "Chiesa evangelica", venne nominato un commissario di Stato per la Chiesa protestante di Prussia, Jager.
Il suo primo comunicato dichiara: "Dobbiamo rendere grazie a Dio per avere, attraverso il suo mezzo, Adolf Hitler, stornato da noi il caos bolscevico" 11. Non si potrebbe palesare più chiaramente come, sia per i cattolici romani che per molti protestanti e per qualche massone nazionalista, si tratti d'esorcizzare il Satana staliniano con il Belzebuth hitleriano.
Fedele alla sua tradizione politica d'opportunismo che lo aveva portato, qualche anno prima, a ricevere Giorgio Ciceriu, dopo Rapallo, il Vaticano si affrettava ad avvicinarsi ulteriormente alla campagna anti-sovietica dei "Die Hards", gli ultraconservatori britannici, e non esita ad abbandonare il cancelliere cristiano Briining per accostarsi alla nuova potenza demagogica di Adolf Hitler.
La Massoneria prussiana segue il movimento. Essa denuncia il carattere "pacifista e cosmopolita" delle idee delle logge "umanitarie"; essa proclama il suo carattere "puramente nazionale" (rein national) e la sua intenzione di "sviluppare l'amore per la patria, il sentimento della nazione e della comunità, così come di lottare contro il materialismo attraverso lo sviluppo del sentimento religioso nel popolo" 12.
Questi fatti sono sufficienti a dimostrare come la "rivoluzione conservatrice", espressione con cui qualcuno ha definito molto bene il nazionalsocialismo, si è rivestita per così dire degli aspetti mistici e mitici di quello che si potrebbe chiamare il "nazionalismo estatico", fenomeno storico già conosciuto dai francesi dopo Giovanna d'Arco e subìto da essi fino in epoca recente. È dunque possibile constatare come la nascita del nazionalsocialismo non fu meno avvolta d'ombre di quella del movimento sotterraneo, ancora poco conosciuto, che accompagnò e preparò l'apparizione della "Figlia di Dio" inviata dal "Re del Cielo" 13. Si è trattato, nel caso di Adolf Hitler, di un "figlio del diavolo" e grandi precauzioni furono prese al fine di cancellare le tracce di quelli che, per primi, misero in moto la macchina infernale condizionata dagli ordini dati per quella "missione provvidenziale" di cui Hitler fu il solo a non mai dubitare.
Mi sono quindi sforzato di ritrovare le tracce di questi troppo modesti personaggi che, messo in azione il loro dispositivo, non tengono molto, sembrerebbe, ad apparire nelle future opere degli storici. Se non sono riuscito a identificarli tutti, e ciò poco importa, ho almeno avuto la fortuna di scoprire due documenti che permettono, per la prima volta, di conoscere esattamente che cosa fosse quella celebre "Società Thule", la "Thule-Gesellschaft", su cui si sono scritte in Francia troppe favole ridicole e in Germania, al contrario, così poche cose degne di qualche attenzione.
Ho creduto bene tradurre, alla luce delle mie ipotesi, non soltanto l'autentica storia di questa società scritta dal suo fondatore, ma anche una lista dei membri, redatta nel 1933, nello stesso tempo in cui analizzavo i singolari esercizi mistico-magici descritti dall'autentico "maestro" della "Thule-Gesellschaft", un "Illuminato" germanico-turco, Rudolf von Sebottendorff.
I rapporti di queste teorie con quelle dell'alchimia chiariscono di una luce singolare il mito della "trasmutazione biologica" della Germania, di cui si è inutilmente cercata la spiegazione fino a oggi. Si giunge a chiedersi se il primo tentativo di applicazione di questa scienza segreta non sia stato tentato sullo stesso Hitler che sarebbe stato, per così dire, il "lievito" predestinato di una metamorfosi collettiva, capace di trovare in lui, attraverso il Führer, la guida e il modello.
Ed è almeno incontestabile il caso di Adolf Hitler, messo in risalto da uno studio attento della medianità del "Führerprinzip", di cui tutte le testimonianze conosciute non permettono di dubitare. Quei fenomeni di possessione, che presentava il signore della Germania, mi sono sembrati degni di essere esaminati, perché gli esercizi mistico-magici di Sebottendorff tendevano, esattamente, a porre in rapporto il "predestinato" con certe "entità" di un "altro mondo" e, in ogni caso, ad incoraggiare uno stato di auto-ipnosi favorevole allo sdoppiamento della personalità. Questo vero e proprio "innesto dell'Ombra" fu operato volontariamente su un soggetto medianico dall'eccezionale talento di totale esteriorizzazione oratoria, sfociante in una dissociazione dell'Io, senza dubbio favorita da gravi lesioni dell'apparato respiratorio, dalla tubercolosi contratta nella giovinezza e dai gas durante la guerra? O, forse, furono acquisite attraverso un allenamento personale del Führer secondo le occulte indicazioni trasmesse gli da Rudolf Hess o da qualche altro membro attivo della Thule-Gesellschaft o, ancora, attraverso un intermediario sconosciuto? È impossibile, sfortunatamente, rispondere a queste domande, ma non ci si può impedire di porle quando si osservi, attraverso lo studio delle numerose testimonianze, con quale costante attenzione Hitler badasse a che nessuno, nemmeno il suo cameriere personale o il suo medico privato, potesse penetrare i misteri della sua vita intima.
René Alleau
NB: Questo libro spiega in maniera indiretta perchè i Maestri come Alleau,Canseliet,Fulcanelli, Lucarelli e tutti quanti hanno difeso con grande scrupolo l'alchimia e i suoi segreti .
Note:
1. Nel corso del testo l'Autore fa uso indifferentemente della forma "national-socialisme" e "nazi". Ho tradotto ambedue con "nazionalsocialismo", non essendomi parsa la contrazione di senso adatto ad un testo storico (N.d.T.).
2. "Réflexion sur la violence", 1906, réedition Rivière, Parigi, 1946, p. 182 (tr. it. "Riflessioni sulla violenza", Laterza, Bari - N.d.C.).
3. Il libro di Hermann Rauschning ("Gespräche mit Hitler", 1939), famoso in tutto il mondo, è stato sempre utilizzato come fonte sicura e diretta sul nazionalsocialismo e su Hitler. come documento dei "veri" piani del dittatore tedesco e del suo "vero" carattere satanico. In tal senso lo utilizza René Alleau soprattutto nel capitolo dedicato a Hitler "medium" e "invasato". (Parte Seconda, capitolo 4), mentre il fondamento veritiero del libro è confermato in specie nel capitolo 1, Parte Seconda. Lo stesso atteggiamento hanno, proprio per l'aspetto "occulto", alcuni studiosi italiani (cfr. ad esempio Gianni Vannom, "Le società segrete", Sansoni. Firenze 1985). Uscito nel dicembre 1939 in francese, ebbe rapidissime traduzioni in Gran Bretagna e Stati Uniti, poi nel resto del mondo; in Italiano uscì nel 1944 a Roma (Edizioni delle Catacombe) e nel 1945 a Milano (Rizzoli) col notissimo titolo di "Hitler mi ha detto" Si tratta però di un falso. Ha smascherato l'operazione uno storico svizzero, Wolfgang Haenel, che ne parlò la prima volta nel 1983 ad un convegno dei membri dell'Istituto di Ricerche sulla Storia Contemporanea di Ingolstadt. Il suo lavoro è poi andato alla casa editrice tedesca Ullstem. Ne ha riferito ampiamente Michele Topa "Hitler mi ha detto un sacco di frottole", in "Il Giornale", Milano, 2 ottobre 1985, pag. 4), ma non pare che la stampa italiana né gli storici vi abbiano prestato molta attenzione, eppure, come ha osservato il dottor Alfred Schickel, direttore dell'Istituto, il falso denunciato da Haenel ha "ben altro peso" in confronto allo scandalo suscitato dai falsi "diari segreti" di Hitler che il settimanale tedesco "Stern" iniziò a pubblicare in quello stesso periodo. Infatti, come spesso accade, ciò che conviene non far risaltare in una "società dell'informazione" come l'attuale, si tace, si soffoca. E quel che non si sa, non esiste. I "colloqui" di Rauschning con Hitler sono dunque un falso, perché Rauschning non ebbe con il Führer quel "centinaio" di incontri di cui dice, ma - come sostiene Haenel confrontando testimonianze e documenti - lo vide "al massimo quattro volte e mai in 'tete-à-tete': c'era sempre qualcuno presente". Non si tratta, allora, di confidenze private e quindi più veritiere di quelle rese in e al pubblico. Il libro di Rauschning è invece formato da una serie di citazioni estratte dalle fonti più disparate e quindi manipolate da varie penne. Haenel ha ricostruito così la vicenda del libro: Rauschning, quando era a Parigi. nel luglio 1939. portò due suoi articoli a Emery Reves (l'oriundo magiaro Imre Revesz) un giornalista antinazista che aveva fondato la "Cooperation Service de Presse", un'agenzia stampa che forniva articoli di prestigiosi pubblicisti (Churchill, Eden, Blum, ecc.), a quattrocento giornali di settanta Paesi diversi. Reves rifiutò gli articoli, ma saputo che Rauschning aveva conosciuto di persona Hitler "molte volte, più di cento", e che aveva preso appunti, gli suggen di scrivere un libro su questi suoi incontri. Reves, lette poi le prime pagine, raccomandò a Rauschning di ampliare il tutto con "citazioni, citazioni, citazioni e niente altro". Il testo veniva poi tradotto, quindi accentuato, colorito, inasprito, da un altro collaboratore dell'agenzia stampa, Marcel Ray, capogabinetto dell'ex presidente francese Herriot. Come ha spiegato Reves (che è ovviamente la fonte di tutte queste notizie) a Haenel in una serie di colloqui registrati prima della sua morte a Montreux il 5 settembre 1981, "il manoscritto di Rauschning divenne quindi come dire? una mescolanza. Diciamo che per due terzi era tedesco e per un terzo francese. La ragione è che non avevamo tempo per fare diversamente... Dovevamo lavorare terribilmente in fretta". Infatti, la guerra scoppiò il l° settembre successivo. Le fonti di Rauschning, così come identificate dallo storico svizzero, sono le seguenti: "libri di Juergen, Haushofer, Lundendorff; pubblicazioni nazionalsocialiste; "Mein Kampf", discorsi pronunciati da Hitler dopo il '36; infine, formule, motti, interi passaggi presi da "La rivoluzione del nichilismo" [cioè il libro sulle origini del nazionalsocialismo pubblicato da Rauschning stesso per le Edizioni Europa di Zurigo nel 1938], trasformati e fatti 'pronunciare' dal Führer in discorso diretto". Si trattò dunque di una classica arma di propaganda, che in sé può forse anche essere legittima, ma che per 45 anni è stata considerata, utilizzata, citata e sfruttata, come fosse una fonte storica diretta, e quindi valida, del vero pensiero e del vero carattere di Hitler. Oggi questo non è più possibile. Così conclude Wolfgang Haenel il suo lavoro certosmo: "Il libro di Rauschning non fu altro che un'arma uscita dall'arsenale della guerra psicologica, che servì a rafforzare la resistenza contro Hitler in tutto il mondo e a spingere gli americani a entrare nel conflitto accanto agli alleati europei". Rauschning, morto novantacinquenne 1'8 febbraio 1982 a Portland, non aveva la coscienza tranquilla e si rendeva conto dei pericoli che correva, perché scrisse in una lettera: "Il Signor Haenel mi vuole smascherare" (N.d.C.).
4. Tr. it.: "Il Nazionalsocialismo, Documenti 1933-1945", Feltrinelli. Milano 1964 (N.d.T.).
5. Documento citato da Miche! Mazor in "Le Phénomène nazi", prefazione di Rémy Roure, Editions du Cèntre, Parigi, 1957, pagg. 116-117.
6. Si tratta delle vittime del Putsch di Monaco, i "martiri" della Feldhernnhalle.
7. W. Hafer, "Il Nazionalsocialismo", cit.
8. Friedrich Heen, "Der Glaube des Adolf Hitler, Anatomie einer politischen Religiositiit", Monaco 1968. Quest'opera, la più importante che sia apparsa nel dopoguerra, porta tutta la luce necessaria sulla crisi della Chiesa cristiana nei suoi rapporti con il nazionalsocialismo.
9. "Les Passions selon Dali", Denoel. Parigi 1968, p. 102.
10. "Les Passion", cit. p. 102.
11. H. Guilbeaux. "Où va l'Allemagne?", Parigi 1933, p. 259.
12. E. Lennohff e O. Posner, "lnternationales Freimaurer Lexicon", 1932, p.347.
13. L'accostamento non è casuale. Come si ricorderà Giovanna d'Arco sosteneva che "voci" e "apparizioni" guidavano la sua azione come, secondo taluni, "voci" e "apparizioni" avrebbero guidato Hitler. (N.d.T.).
Darwin o " il creazionismo antiscientifico" di Roberto de Mattei , Vice Presidente del CNR .
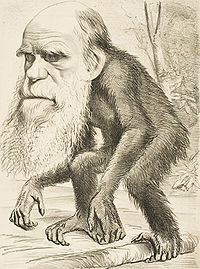
" Esiste una particolare specie di vespa (Ampulex compressa) che usa un cocktail di veleni per manipolare il comportamento della sua preda, uno scarafaggio. La vespa femmina paralizza lo scarafaggio senza ucciderlo, poi lo trasporta nel suo nido e deposita le sue uova nel ventre della preda, in modo che i neonati possano nutrirsi del corpo vivente dello scarafaggio. Mediante due punture consecutive, separate da un intervallo temporale molto preciso e in due parti diverse del sistema nervoso dello scarafaggio, la vespa riesce letteralmente a «guidare» nel suo nido già predisposto la preda trasformata in uno «zombie». La prima puntura nel torace provoca una paralisi momentanea delle zampe anteriori, che dura qualche minuto, bloccando alcuni comportamenti ma non altri. La seconda puntura, parecchi minuti più tardi, è direttamente sul capo. La vespa dunque non deve trascinare fisicamente lo scarafaggio nel suo rifugio, perché può manipolare le antenne della preda, o letteralmente cavalcarla, dirigendola come se fosse un cane al guinzaglio o un cavallo alla briglia. Il risultato è che la vespa può afferrare una delle antenne dello scarafaggio e farlo andare fino al luogo adatto all’ovodeposizione. Lo scarafaggio segue la vespa docilmente come un cane al guinzaglio. Pochi giorni più tardi, lo scarafaggio, immobilizzato, funge da fonte di cibo fresco per la prole della vespa.
Questa macabra ma illuminante storia entomologica è presentata dai cognitivisti Jerry Fodor e Massimo Piattelli Palmarini nel libro, appena stampato da Feltrinelli, Gli errori di Darwin, come uno degli argomenti più efficaci per confutare l’evoluzionismo darwiniano secondo cui gli organismi viventi traggono la loro origine da una «casuale» selezione naturale ...." Roberto de Mattei, Vice Presidente CNR Al de Mattei risponde Marco Ferraguti all'indirizzo .: http://temi.repubblica.it/micromega-online/levoluzionismo-fantasie-il-creazionismo-antiscientifico-del-vicepresidente-del-cnr/ Tema interessante sul quale è bene formarsi una propria opinione sentito anche un terzo attore in questa stucchevole diatriba : "Nella vita, con le sue diverse forze, originariamente impresse dal Creatore in poche forme, o in una forma sola, vi è qualcosa di grandioso; e mentre il nostro Pianeta ha continuato a ruotare secondo l'immutabile legge di gravità, da un semplice inizio innumerevoli forme, bellissime e meravigliose, si sono evolute e continuano ad evolversi". Charles Darwin
Mircea Eliade esoterico.
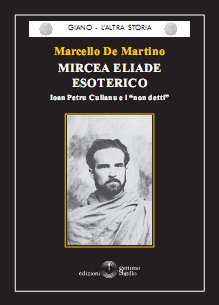
<< [...] Fin da giovane versato a rintracciare il «potere spirituale della materia», Eliade era andato cercando tracce di tradizione anche nella letteratura moderna, proprio per vedere se, al di sotto della catastrofe coscienziale europea, non fermentasse ancora inconsciamente un residuo valoriale: e dunque nell’Ulisse di Joyce vedeva balenare certi miti arcaici sull’eroe totemico, in Jonesco certe assonanze col Libro tibetano dei morti […]" Questo libro promette un viaggio interessante ,colmo di riferimenti, dove si possono incontrare insoliti personaggi .....da prendere con le molle, però. gdg
Il Pimandro.
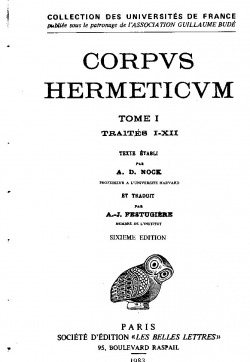
"Accresci te stesso d’una grandezza immensa, sorpassa tutti i corpi: attraversa tutti i tempi, diventa eternità, e tu comprenderai Dio. [...] Elevati al di sopra di ogni altezza, discendi al di sotto di ogni abisso; raduna in te tutte le sensazioni delle cose create, dell’acqua, del fuoco, del secco, dell’umido. Supponi d’essere nello stesso tempo dappertutto, sulla terra, nel mare, in cielo; di non essere mai nato, di essere ancora in embrione, di essere giovane, vecchio, morto, al di là della morte. Comprendi tutto insieme, i tempi, i luoghi, le cose, le quantità, le qualità, e tu comprenderai Dio.". A chi avrà la pazienza di leggere con attenzione il Pimandro troverà in questo lo stesso spirito che animo' Paolo Lucarelli in LETTERE MUSULMANE.
<<....Il monaco nero in grigio dentro Varennes >> di Georges Dumézil
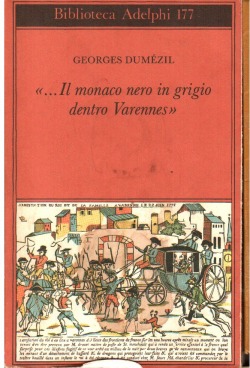
Il celebre quanto rigoroso linguista Dumézil, Accademico di Francia, attraversa il Rubicone . Attratto da non ben spiegabili coincidenze, pubblica questo saggio ben documentato su una quartina profetica di Nostradamus che sembra annunciare l'arresto di Luigi XVI a Varennes. Un divertissement direbbe al lettore lo studioso, ma è proprio così ?
Lettere musulmane. Riflessioni sull'Alchimia.
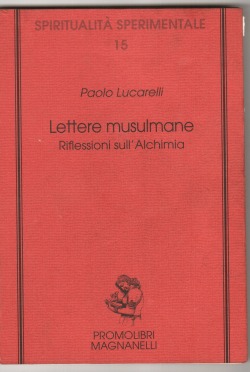
Paolo Lucarelli mi regalò questo piccolo libro e ricordo che lo lessi con superficialità sul treno mentre stavo tornando a casa per poi riporlo in un cassetto a sonnecchiare per qualche anno. Non fate il mio stesso errore: è un piccolo capolavoro che merita piu' di una lettura ! gdg
IL REGNO DI SATURNO CAMBIATO IN SECOLO D'ORO di Huginus A Barma.
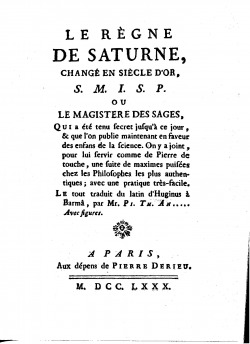
La copia anastatica in mio possesso di questo pregevole libro del 1780 è stata pubblicata da Archè nel 1971 in 520 esemplari. Ne consiglio la lettura non solo perchè il titolo è affascinante ma perchè zeppo di buoni consigli , di indicazioni operative ( ad esempio, sui pesi dell'opera ) e di principi che i Filosofi devono seguire per non incorrere in gravi errori.
Il testo in versione integrale è comunque facilmente reperibile su internet.
gdg
Il testo in versione integrale è comunque facilmente reperibile su internet.
gdg
L'Art du Potier di Cyprian Piccolpassi
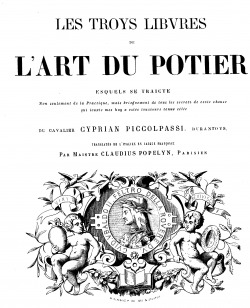
Tradotto dall'italiano ( ! ) da Maistre CLAUDIUS nel 1560 . Si tratta una copia anastatica di una edizione del 1860. Non è un testo di facile lettura perchè è in francese arcaico ma presenta di contro, un interessante gioco cabalistico , segnalato da Laurent Dutriaux , che riguarda l'autore il Cavaliere Cyprian Piccolpassi che "scrisse un libro intitolato I tre libri dell’arte del vasaio 11 in cui spiega come lavorare la terra di Durante, la sua patria. Vediamo per cominciare in bella evidenza il termine ‘cavaliere’ che ci indica il carattere cabalistico dell’opera; il nome stesso dell’autore è simbolico: in realtà ‘Cyprian’ equivale a Cypris (Cipro), null’altro che la Venere degli alchimisti; ‘Piccolpassi’ indica il modo di procedere. Il nostro cabalista segue dunque Venere (la Natura) a piccoli passi, perciò egli utilizza la terra d’oro innestata…"
FESTINA LENTE
gdg
FESTINA LENTE
gdg
La ricerca della Verità secondo Ingmar Bergman.
" La puntuale introspezione alla quale sono sottoposti i protagonisti Bergmaniani ci richiama alla mente quello che della vita e della filosofia dovrebbe essere (ma non è quasi mai) la continua ricerca: l'incessante cammino volto alla chiarificazione dell'esistenza e il modo più congruo per farlo, il tentativo di trovare un senso intrinseco all'esistenza del singolo che si configura come ricerca di Verità; l'esito di tale ricerca sembra non riesca mai a soddisfare o a raggiungere risultati rassicuranti; anzi l'esistenza singolare giunge quasi sempre ad un empasse, un limite invalicabile, all'interno di un più alto piano razionale "scricchiolante". I punti fermi, le certezze individuali passano al setaccio di mirabili analisi fino al completo dissolvimento. Si è parlato di possibili attinenze tra il cinema scandinavo (si pensi a Dreyer o al più recente Lars von Trier) e il pensiero di Kierkegaard. Da un certo punto di vista, lo si riscontra pienamente: la fede che diventa problematizzazione esistenziale, i tre "stadi" dell'esistenza umana e addirittura il concetto di angoscia. Sebbene il problema della fede sia evidente nel cinema di Bergman, la conciliazione con Dio non appaga, non affranca il singolo dall'angoscia. Dio per Bergman rimane l'assolutamente Altro, è pura trascendenza " Alessandra Pigliaru
Initiation a la symbolique romane
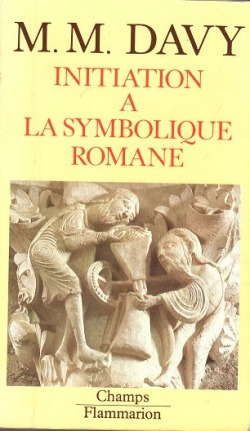
Per tutti gli appassionati che hanno apprezzato particolarmente il Mistero delle Cattedrali di Fulcanelli consiglio caldamente questo bel libro della Davy in lingua francese.
" Noi siamo simili a dei nani accovacciati sulle spalle di giganti. Noi siamo in grado di vedere più cose e ancora più lontano degli Antichi, ma ciò non è dovuto alla acutezza della nostra vista o alla nostra altezza ma al fatto che gli Antichi ci sostengono con la loro taglia gigantesca"
Bernardo di Chartres
gdg
" Noi siamo simili a dei nani accovacciati sulle spalle di giganti. Noi siamo in grado di vedere più cose e ancora più lontano degli Antichi, ma ciò non è dovuto alla acutezza della nostra vista o alla nostra altezza ma al fatto che gli Antichi ci sostengono con la loro taglia gigantesca"
Bernardo di Chartres
gdg
Saggio sul mito di Circe di Maurizio Bettini e Cristiana Franco.

La reazione eroica di Odisseo instaura sull´isola di Circe una dinamica che ai Greci dell´età arcaica e classica doveva apparire come giusto ordine delle cose. Prima dell´arrivo dell´eroe sull´isola, Aiaie è una terra di sole femmine abitata da Circe e dalle sue ninfe . Ogni uomo che passa di lì perde la propria identità di essere umano maschio libero indipendente, trasformandosi in belva sottomessa o in bestia da cortile, in ogni caso al servizio della dea. Doveva giungere il guerriero di Itaca perché l´incantesimo si rompesse – così aveva preannunciato Hermes – e Circe, almeno una volta, fosse sottomessa a una volontà maschile. Ecco perché a Odisseo non capita quello che accadrà all´"Ulisse" di Joyce, umiliato e trasformato in donna dalla sua virilissima "Circe". Né quello che succede agli hetáiroi, ridotti a un branco di suini all´ingrasso, ammassati nel porcile e nutriti dalle mani della dea, che possono essere salvati soltanto dal «cinghiale» eroico, il loro capo, capace di affrontare e vincere Circe a spada tratta. Come Penelope, anche Circe non cede a un pretendente qualunque [...]